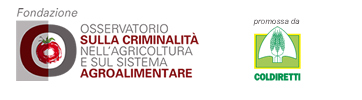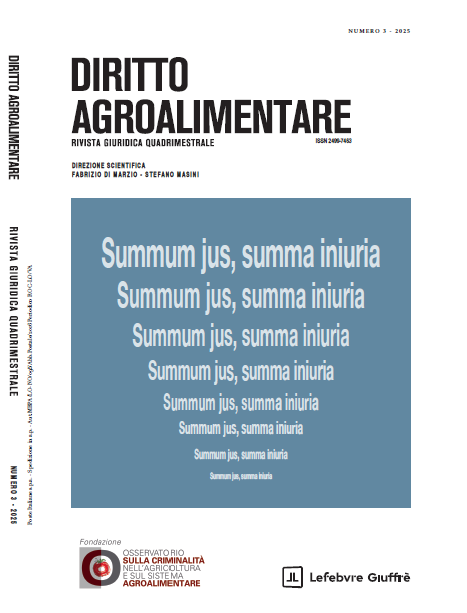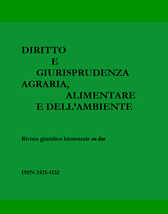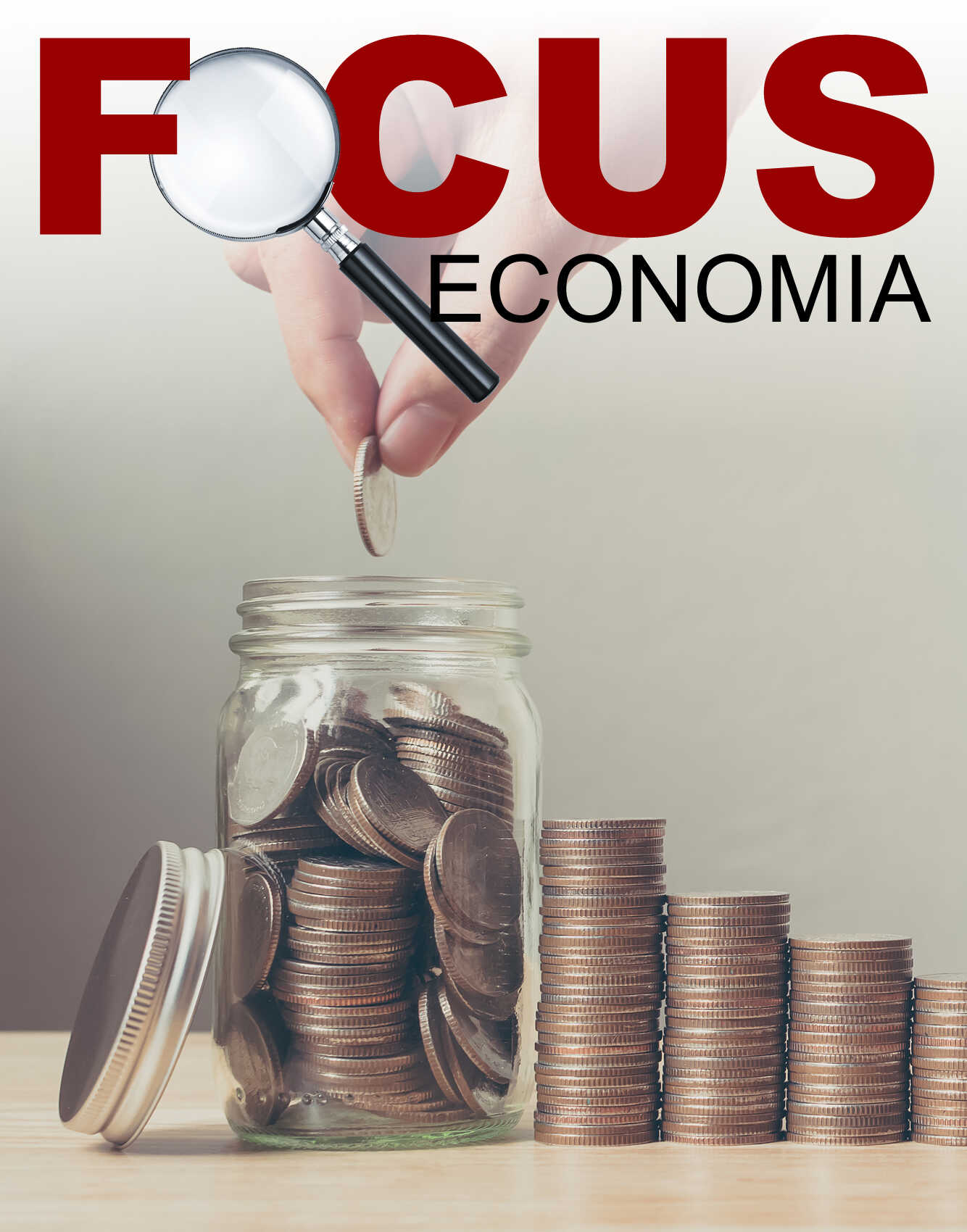Indice Fascicolo 3 - 2025
MARCO GOLDONI
Antonio Jannarelli gius-agrarista [approfondisci]
La produzione giuridica agraristica di Antonio Jannarelli attraversa un cinquantennio e ha la capacità di dare segnali importanti della specialità di una materia - il diritto agrario - in grado di congiungere un non breve, intenso e anche contraddittorio passato con le richieste di un incerto ma stimolante e provocatorio futuro. Da essa risulta l’individuazione identitaria del diritto agrario del nostro tempo come risultato del rapporto fra tradizione e rinnovamento, per cogliere i nuovi fermenti che la progrediente economia postindustriale declina. Il profilo identitario si collega così alle istanze della progettualità. Jannarelli preferisce rifiutare dichiarazioni “in principio” e preliminarmente si rifà alla rilevazione, con comparazione diacronica e sincronica, delle diverse situazioni offerte dai Paesi a economia di mercato. L’immagine offerta è della presenza diffusa di una singolare devianza di trattamento giuridico per cui l’esercizio dell’attività agricola è beneficiaria, per caratteristiche “sostanziali”, di normative più favorevoli rispetto agli altri settori economici: vale a dire che quella presenza esprime l’“eccezionalismo agricolo”. Per il “sistema agricolo” anche le società industrializzate non potranno fare a meno, nel futuro, di un sistema in definitiva “specifico” per l’“agricoltore”, l’“agricoltura” e il “governo dell’agricoltura”. Proprio quando il diritto comunitario propone la figura di un imprenditore alimentare comprendente senza specificazioni l’imprenditore agricolo, il Nostro propone un rinnovo delle ragioni che ampliano le connotazioni storicamente caratterizzanti il diritto agrario: nella modernità si ripresenta l’esigenza di un trattamento speciale, cosicché la mobilità dei confini non riesce a nascondere il continuum. Chiara è la prospettiva inaugurata: sarebbe illusorio rivendicare “competenza esclusiva” dell’agrarista sull’area regolamentare “diritto alimentare”, segnata fra l’altro dalla interdisciplinarità; non meno ingenuo sarebbe assegnare la modernità del diritto agrario all’interno dei confini propri del “diritto alimentare”, il cui paradigma fondativo è basato sulla tutela della salute del consumatore, e non certo sulla tutela dell’imprenditore agricolo o dell’imprenditore commerciale. La congiunzione della vocazione comparatistica con il fisiologico sguardo storicistico si rivolge a un rapporto per così dire “bilaterale” tra concretezza dei fenomeni economici e sociali, da un lato, ed emersione, affermazione ed efficacia della fonte normativa, dall’altro. Lo specialismo non riduce l’agrarista a proposizioni frantumate e ridotte alla misera esegesi, anche perché il sapere giuridico si articola sì in diversi specialismi, ma le ragioni convenzionali non possono dimenticare l’unitarietà del discorso giuridico, e comunque richiedono al diritto agrario il confronto non solo con il diritto alimentare ma anche con il diritto ambientale. Non si può difatti dimenticare la bivalenza valoriale (Alimentazione, Ambiente) che sempre anima l’agricoltura. Al centro stanno sempre, nell’impostazione culturale di Jannarelli, le aperture rese possibili dall’istanza comparatistica nei suoi due versanti: il sincronico e il diacronico.
Antonio Jannarelli’s legal work on agriculture spans fifty years and provides important insights into the special nature of agricultural law, which is capable of linking a long, intense, and even contradictory past with the demands of an uncertain but stimulating and provocative future. It identifies the identity of agricultural law in our time as the result of the relationship between tradition and renewal, in order to grasp the new developments that the progressive post-industrial economy is bringing about. The identity profile is thus linked to the requirements of planning. Jannarelli prefers to reject “in principle” statements and initially refers to the diachronic and synchronic comparison of the different situations offered by market economy countries. The picture presented is one of widespread legal treatment that favors agriculture, whereby farming benefits from more favorable regulations than other economic sectors due to its “substantial” characteristics: in other words, this situation reflects “agricultural exceptionalism”. When it comes to the “agricultural system”, even industrialized societies will not be able to do without a system that is ultimately “specific” to “farmers”, “agriculture”, and “agricultural governance” in the future. Just when EU law proposes the figure of a food entrepreneur that includes agricultural entrepreneurs without specification, Jannarelli proposes a renewal of the reasons that broaden the connotations that have historically characterized agricultural law: in modern times, there is a renewed need for special treatment, so that the mobility of borders cannot hide the continuum. The perspective that has been opened up is clear: it would be illusory to claim “exclusive competence” for the “agrarista” in the regulatory area of “food law”, which is characterized, among other things, by its interdisciplinary nature; it would be no less naive to assign the modernity of agricultural law within the confines of “food law”, whose founding paradigm is based on the protection of consumer health, and certainly not on the protection of agricultural or commercial entrepreneurs. The combination of comparative analysis with a natural historical perspective focuses on a “bilateral” relationship, so to speak, between the concrete nature of economic and social phenomena on the one hand, and the emergence, affirmation, and effectiveness of the normative source on the other. Specialization does not reduce the “agrarista” to fragmented propositions reduced to poor exegesis, partly because legal knowledge is divided into different specializations, but conventional reasoning cannot forget the unity of legal discourse, and in any case requires agricultural law to be compared not only with food law but also with environmental law. Indeed, we cannot forget the dual values (food and environment) that have always inspired agriculture. At the heart of Jannarelli’s cultural approach are the opportunities made possible by comparative analysis in its two aspects: synchronic and diachronic.
MARIARITA D’ADDEZIO
Sostenibilità e responsabilità nel settore agricolo e nelle filiere produttive intersettoriali [approfondisci]
Dopo la ricognizione di nuove fattispecie di responsabilità correlate allo sviluppo sostenibile, il lavoro individua alcuni tasselli e fattispecie del binomio sostenibilità-responsabilità a carico e a danno dell’agricoltura e delle filiere intersettoriali. La trattazione continua soffermandosi sui soggetti privati e pubblici coinvolti, sulle situazioni giuridiche lese e sui presupposti e limiti all’effettività della responsabilità risarcitoria dello Stato per i danni ai diritti fondamentali dei singoli derivati dalla violazione del diritto UE.
The work proceeds to the recognition of new types of liability related to sustainable development and identifies some cases of the combination sustainability-responsibility borne by and to the detriment of the agri-industrial system. The study continues by focusing on the public and private entities involved, the legal situations affected, the preconditions and limitations on the effectiveness of state liability for damages to individuals’ fundamental rights resulting from a violation of EU law.
ALESSANDRA DI LAURO
YuKa: quale orizzonte possibile per le applicazioni digitali fra informazione, pratica sleale e denigrazione [approfondisci]
Lo scritto affronta l’esame delle decisioni giudiziarie francesi e italiane relative all’uso dell’applicazione YuKa che ha avuto grande successo presso i consumatori. La giurisprudenza oscilla fra il riconoscimento della valutazione come pratica commerciale sleale, la collocazione nell’ambito degli atti di denigrazione e la qualificazione come esercizio della libertà di espressione e informazione. Le conseguenze delle diverse visioni giuridiche sono molteplici. Queste applicazioni potrebbero avere un ruolo nella diffusione di conoscenze nell’acquisizione di una maggiore trasparenza. La riconducibilità delle valutazioni effettuate da queste applicazioni all’atto di denigrazione e/o alla pratica sleale, potrebbero costituire una minaccia alla libertà di critica e anche di informazione.
This article examines French and Italian rulings on the use of the YuKa app, which has been very popular with consumers. Case law varies between recognising the assessment as an unfair commercial practice, classifying it as denigration, and qualifying it as an exercise of freedom of expression and information. The consequences of the different legal views are manifold. These apps could play a role in spreading knowledge and achieving greater transparency. The fact that the ratings given by these apps can be considered denigration and/or unfair practices could threaten freedom of criticism and even freedom of information.
ANTONIO JANNARELLI
La disciplina dei domini collettivi dopo la legge n. 168 del 2017 e quella regionale della Valle d’Aosta 1° agosto 2022, n. 19 [approfondisci]
La relazione intende illustrare l’impatto della legge n. 168 del 2017, riguardante i domini collettivi, sulla legislazione nazionale e regionale in materia di usi civici, anche alla luce della evoluzione intervenuta nella giurisprudenza della Corte costituzionale. A conclusione di questa indagine, la relazione segnala le principali novità normative legate alle modifiche intervenute con la legge n. 168 del 2017 e offre una prima lettura della legge regionale della Valle d’Aosta 1° agosto 2022, n. 19.
The report aims to illustrate the impact of Law No. 168 of 2017 on collective domains on national and regional legislation on civic commons, also considering developments in the jurisprudence of the Constitutional Court. At the end of this investigation, the report highlights the main regulatory changes introduced by Law No. 168 of 2017 and offers an initial reading of the regional law of Valle d’Aosta No. 19 of August 1, 2022.
LORENZA PAOLONI
Modelli organizzativi di agricoltura sociale tra multifunzionalità e sostenibilità [approfondisci]
Vengono indagate le diverse modalità di manifestazione dell’impresa agricola, organizzata sia in forma individuale che collettiva, nell’esercizio dell’agricoltura sociale ovvero di un’attività d’interesse generale che, oltre a costituire una singolare combinazione tra l’attività agricola produttiva di beni e rivolta al mercato, con attività di collaborazione con soggetti pubblici e privati ed azioni specifiche di inclusione sociale e lavorativa, di co-terapia e di creazione di servizi per la popolazione, si presenta attenta anche alle esigenze dei territori e delle comunità rurali. Il carattere multifunzionale dell’impresa agricola ed il dettato normativo riconoscono alle diverse tipologie di attività, svolte dall’imprenditore agricolo ed indirizzate all’utilità sociale, la valenza di attività connesse di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c.
This essay explores the various ways in which agricultural enterprises, both individually and collectively organized, engage in social farming. Social farming is a socially useful activity which, in addition to agricultural production for the market and collaboration with public and private entities, involves specific actions for social and labour inclusion, co-therapy, and the creation of services for the population. It also pays attention to the needs of rural areas and communities. The multifunctional nature of agricultural enterprises and regulatory provisions recognize various activities carried out by farmers that are related to social utility, as referred to in paragraph 3 of Article 2135 of the Italian Civil Code.
FRANCESCO SCALIA
Pianificazione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili e riserva di procedimento amministrativo [approfondisci]
Obiettivo del saggio è valutare la costituzionalità della riserva al legislatore regionale della pianificazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, operata con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2001. Tale previsione, infatti, si pone in apparente contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ha riservato al procedimento amministrativo la pianificazione delle aree non idonee. L’Autore conclude per la compatibilità della previsione legislativa in questione con la gerarchia degli interessi che si è affermata nel nostro ordinamento per opera del legislatore euro-unionale. In particolare, la fissazione di obiettivi inderogabili di produzione di energia da fonte rinnovabile, in un processo top-down che prescinde da condizioni e peculiarità dei territori che ne devono ospitare gli impianti, rende di fatto l’interesse al raggiungimento di tali obiettivi non bilanciabile con altri in potenziale conflitto, ancorché costituzionalmente rilevanti.
The aim of this paper is to assess the constitutionality of entrusting regional legislatures with the planning of areas suitable for the siting of renewable-energy production plants, as set out in Article 20 of Legislative Decree No. 199/2001. At first glance, this provision seems to clash with Constitutional Court case law, which has instead assigned the planning of unsuitable areas to administrative procedures. The Author, however, concludes that the legislative provision is compatible with the hierarchy of interests that has emerged in the Italian legal order under the influence of EU law. In particular, the establishment of non-derogable targets for the production of renewable energy – through a top-down process that pays no heed to the conditions and peculiarities of the territories where the plants must be located – effectively renders the interest in achieving those targets non-negotiable against other potentially conflicting interests, even when the latter are constitutionally protected.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
AMARILLIDE GENOVESE
Filiere e potere: il caso Coop Italia tra AGCM e Consiglio di Stato [approfondisci]
La vicenda Coop Italia c. AGCM ripropone all’interprete il tema dei criteri di valutazione dello squilibrio significativo nelle posizioni di forza commerciale, presupposto di ammissibilità dell’intervento dell’Autorità antitrust e condizione di operatività della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari dell’art. 62, d.l. n. 1 del 2012. A distanza di dieci anni dal provvedimento Coop Italia-Centrale Adriatica, in cui per la prima volta l’AGCM sanziona la pratica abusiva della GDO di imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ai propri fornitori, i giudici amministrativi “riscrivono la storia” e annullano due delle tre sanzioni comminate dall’AGCM, in particolare ritenendo che non sia stato provato né lo squilibrio significativo tra le posizioni di forza commerciale degli operatori coinvolti, né la imposizione ingiustificata di una condizione gravosa. Il Consiglio di Stato ritiene che la valutazione dello “squilibrio significativo” non possa essere affidata unicamente alle caratteristiche dimensionali delle imprese e alla durata della relazione commerciale e richiama la necessità di accertare in concreto il ruolo svolto dalla impresa fornitrice nella catena di approvvigionamento che, nella specie, sarebbe quello di un commerciante di prodotti ortofrutticoli all’ingrosso e non di un agricoltore “debole” che subisce condizioni imposte dalle imprese della GDO.
The Coop Italia v. AGCM case raises once again the issue of the criteria for assessing significant imbalance in positions of commercial strength, a prerequisite for the admissibility of intervention by the Antitrust Authority and a condition for the applicability of the rules governing commercial relations in the sale of agricultural and food products under Article 62 of Decree Law No. 1 of 2012. Ten years after the Coop Italia-Centrale Adriatica ruling, in which the AGCM sanctioned for the first time the abusive practice of large-scale retailers imposing unjustifiably burdensome contractual conditions on their suppliers, the administrative judges “rewrote history” and annulled two of the three sanctions imposed by the AGCM, in particular considering that neither the significant imbalance between the commercial positions of the operators involved nor the unjustified imposition of a burdensome condition had been proven. The Council of State considers that the assessment of “significant imbalance” cannot be based solely on the size of the companies and the duration of the commercial relationship, and points to the need to ascertain in concrete terms the role played by the supplier company in the supply chain which, in this case, would be that of a wholesale fruit and vegetable trader and not a “weak” farmer who is subject to conditions imposed by large-scale retailers.
[approfondisci]
Indice Fascicolo 2 - 2025
MARIA BEATRICE BERNADETTE ARNESE
La tutela delle indicazioni geografiche del settore agroalimentare e vitivinicolo nel “diritto vivente” dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale [approfondisci]
Lo scritto, partendo dal commento di una decisione dell’ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) riguardante la DOP Champagne, intende far luce sul ruolo di enforcement svolto dall’EUIPO per la tutela delle indicazioni geografiche in ragione delle funzioni assegnate a tale Agenzia europea per la protezione delle indicazioni geografiche che, a seguito dell’entrata in vigore del reg. (UE) n. 2024/1143 sono state ulteriormente rafforzate. A tal fine, l’articolo analizza alcune rilevanti decisioni dell’EUIPO, nonché le prassi applicative sviluppatesi nel corso dell’attività dell’Ufficio, in materia di “uso” ed “evocazione” di un’indicazione geografica con l’intento di valutare la corretta applicazione degli insegnamenti resi dalla Corte di giustizia in materia di tutela delle indicazioni geografiche.
The article, starting from the analysis of a decision of the European Intellectual Property Office (EUIPO) concerning the PDO Champagne, intends to highlight the enforcement role played by the EUIPO for the protection of Geographical Indications due to the functions assigned to this European agency for the protection of Geographical Indications that, following the entry into force of Regulation (EU) No. 2024/1143, have been further strengthened. To this end, the article analyses some relevant decisions of the EUIPO as well as the enforcement practices that have developed during the Office’s activity, concerning the “use” and “evocation” of a Geographical Indication to assess the correct application of the Court of Justice’s teachings on the protection of Geographical Indications.
MARIASSUNTA CICCONE
Verso la competitività: prospettive e aspettative per la prossima PAC. Riflessioni a margine sulla nuova comunicazione «Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione» [approfondisci]
A partire dalla comunicazione della Commissione europea, «Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione. Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell’UE attrattivo per le generazioni future», pubblicata il 19 febbraio, il presente contributo si propone di approfondire alcuni dei principali aspetti che caratterizzano il percorso verso la competitività del settore agricolo europeo. In primo luogo, la Commissione attribuisce un ruolo prioritario alla sicurezza alimentare (intesa primariamente come food security). La pandemia da COVID-19 aveva già messo in evidenza la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento mondiali, a causa della loro interdipendenza. In tale contesto, il rafforzamento dell’autosufficienza e la riaffermazione della sovranità alimentare dell’Unione europea, si configurano come un’efficace strategia di difesa. Un sistema agricolo competitivo, inoltre, non può prescindere dalla sostenibilità economica che richiede un bilanciamento ben calibrato fra costi sostenuti dall’agricoltore e i benefici per l’ambiente e il clima. Per tale ragione, i pagamenti diretti al reddito e il sostegno agli investimenti strutturali previsti nell’ambito della PAC svolgono un ruolo cruciale nel supportare la stabilità del reddito degli agricoltori. È necessario, inoltre, adottare un approccio rinnovato alla sostenibilità che, intesa nella sua tridimensionalità, contribuisce alla resilienza dell’attività agricola attribuendo un valore aggiunto al prodotto europeo. In tale contesto, la PAC post-2027 dovrà innalzare l’ambizione ambientale, promuovendo azioni mirate e orientate a produrre risultati concreti e misurabili. In conclusione, nel settore agricolo europeo la competitività si traduce nell’incremento della capacità produttiva che favorisce la crescita economica di lungo termine e nella necessità di ridurre gli effetti negativi delle pratiche agricole sull’ecosistema. Il raggiungimento di questo equilibrio non può prescindere dall’integrazione reciproca fra la produttività e la sostenibilità, in cui l’innovazione tecnologica rappresenta un elemento di connessione fondamentale.
Starting from the Communication of the European Commission «A Vision for Agriculture and Food Shaping together an attractive farming and agri-food sector for future generations», published on 19 February, this paper aims to explore some of the key aspect underpinning the path towards enhancing the competitiveness of the agricultural sector. Firstly, the Commission assigns a strategic priority to the food security. The COVID-19 pandemic highlighted the vulnerabilities of the global supply chains due to their interdependence. Within this context, strengthening self-sufficiency and reaffirming the food sovereignty emerge as an effective defence strategy. Moreover, a competitive agricultural system cannot disregard economic sustainability, which entails a careful balance between the costs incurred by farmers and the environmental and climate related benefits generated. In this regard, direct income payments and structural investment support, as envisaged under the CAP, play a crucial role in ensuring farmers’ income stability. Furthermore, it is essential to embrace a renewed approach to sustainability, conceived in its threefold dimension, which not only contributed to the resilience of the agricultural activity, but also adds value to the European products. For this reason, the post-2027 CAP should raise the level of environmental ambition, through targeted measures designed to deliver concrete and measurable outcomes. Finally, within the European agricultural sector, competitiveness is reflected, on the one hand, in the enhancement of productive capacity, which supports long-term economic growth, on the other, in addressing the need to mitigate the negative impacts of farming practices on the ecosystem. To strike a balance between these two aspects, it is essential to promote and disseminate requires necessarily the technological innovation, as a strategic lever.
MATTEO FERRARI
Distribuzione di valore e regolazione dell’innovazione in campo vegetale [approfondisci]
Il settore a monte della filiera agroalimentare, che possiamo in prima approssimazione far coincidere con il segmento coinvolto nella fornitura di input (tecnologici o di altra natura), ha ricevuto tradizionalmente minore attenzione rispetto a quello posto a valle. Si tratta, tuttavia, di una porzione di filiera caratterizzata da asimmetrie, in termini di potere di mercato e contrattuale, che possono incidere significativamente sulla ripartizione di valore tra i protagonisti della filiera. Le dinamiche regolative e contrattuali che contraddistinguono l’innovazione in campo vegetale costituiscono un esempio di come sia necessario valutare attentamente la relazione esistente tra diritto e distribuzione di valore, al fine di incentivare soluzioni che permettano l’accesso all’innovazione a condizioni eque e trasparenti.
The segment of the agrifood chain placed upstream, which can approximately be identified as the one concerning the provision of inputs, has traditionally received less attention than the segment placed downstream. Nonetheless, it represents a part of the chain affected by both market and contractual asymmetries which can impact on value distribution among the chain’s players. The regulatory and contractual dynamics characterizing innovation in the plant variety sector provides an example of how it is necessary to carefully assess the relationship between law and value distribution, with the aim to incentivize solutions that facilitate access to innovation at fair and transparent conditions.
NICOLETTA FERRUCCI
La quarta dimensione della sostenibilità sulle orme della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione [approfondisci]
Il lavoro prospetta una serie di riflessioni sull’essenza della riforma costituzionale, alle quali si lega il disegno di una quarta dimensione della sostenibilità.
The paper presents a range of reflections about the meaning of constitutional reform, to which the design a fourth dimension of sustainability is linked.
STEFANO MASINI
Originalità e rilevanza sistematica del territorio: idee di un diritto agrario in cammino (dentro il laboratorio di Ferdinando Albisinni) [approfondisci]
L’itinerario degli studi sull’impresa agricola che, nel tempo, Ferdinando Albisinni ha svolto, con evidente validità metodologica, incornicia un’originale ricerca nell’intendimento di mettere a fuoco e ricombinare, insieme, dimensione territoriale e commercialità diversamente ritenute varianti di indagine separate e distinte. Se è vero che il diritto agrario ha il carattere della concretezza, l’Autore ha il merito di riconoscere e, via via, precisare in dettaglio le traiettorie di trasformazione che attraverso la multifunzionalità e l’identità sul mercato dei prodotti vincolano ad una equilibrata valutazione la sfera aziendale con i doveri comunitari e premiano le opportunità offerte a livello europeo per un adattamento del ciclo biologico a esigenze ambientali, in coerenza con il disegno costituzionale in cui l’agricoltura si fa natura e custode di habitat. La sensibilità culturale dell’Autore è quella di aver meditato intorno ad un progetto che conserva al suo centro la terra in una proiezione, tuttavia, funzionale all’adozione di modelli differenziali riconducibili al disegno complessivo del territorio e alla salute di tutto ciò che è vivente. Un’intuizione condotta con fedeltà al progetto di assestamento e crescita della materia, che risponde alla necessità di un’architettura unitaria per contenere una vasta e disordinata produzione di norme senza sottrarsi, nella manutenzione del suo perimetro, al compito di cogliere nuove opportunità.
The itinerary of studies on agricultural enterprises that, over time, Ferdinando Albisinni has carried out, with evident methodological validity, frames original research in the intention to focus and recombine, together, territorial dimension and commerciality otherwise considered separate and distinct variants of investigation. While it is true that agricultural law has the character of concreteness, the Author has the merit of recognizing and, gradually, specifying in detail the trajectories of transformation that, through multifunctionality and identity on the market of products bind the corporate sphere to a balanced assessment with community duties and reward the opportunities offered at the European level for an adaptation of the biological cycle to environmental needs, consistent with the constitutional design in which agriculture becomes nature and guardian of habitats. The cultural sensitivity of the Author is to have pondered around a project that retains the earth at its center in a projection, however, functional to the adoption of differential patterns traceable to the overall design of the land and the health of all that is living. An insight conducted with fidelity to the project of settling and growth of the subject matter, which responds to the need for a unified architecture to contain a vast and messy production of standards without evading, in the maintenance of its perimeter, the task of seizing new opportunities.
LUIGI RUSSO
La Politica agricola comune tra esigenze di sostenibilità economica e l’attuazione del Green Deal a tutela della biodiversità [approfondisci]
Non è tutto oro quello che luccica: a fronte dell’enfasi posta sul Green Deal e sulle sue declinazioni nel settore agro-forestale (Strategia From farm to fork e sulla Biodiversità per il 2030), la primazia ecologica che traspare da tali documenti strategici sembra iniziare a scontrarsi con le scontate esigenze di sostenibilità economica delle imprese agricole coinvolte nella transizione verde. Con il lavoro, si intende evidenziare come il regolamento sul ripristino della natura, approvato con difficoltà dal legislatore europeo, sia destinato ad incidere sull’attività dei produttori agricoli e come, al contempo, siano sostanzialmente trascurati gli aspetti di sostenibilità economica dei nuovi impegni che per essi si profilano. Occorre di conseguenza riflettere se gli obiettivi, estremamente ambiziosi, del Green Deal, potranno essere raggiunti nel rispetto del cronoprogramma che ne costituisce un corollario essenziale, anche alla luce degli evidenti rallentamenti nella sua attuazione, come confermato dalle recenti modifiche dei regolamenti attuativi della PAC per alcuni aspetti di natura “ambientale”.
Not all that glitters is gold: in the face of the emphasis placed on the Green Deal and its declinations in the agro-forestry sector (From farm to fork strategy and Biodiversity for 2030), the ecological primacy that transpires from these strategic documents seems to be beginning to clash with the obvious requirements of economic sustainability of agricultural enterprises involved in the green transition. With the paper, it is intended to highlight how the nature restoration regulation, passed with difficulty by the European legislature, is bound to affect the activities of agricultural producers and co-measures, at the same time, the economic sustainability aspects of the new commitments looming for them are substantially neglected. As a result, it is necessary to reflect on whether the extremely ambitious goals of the Green Deal can be achieved within the timetable that is an essential corollary of it, also in light of the obvious slowdowns in its implementation, as confirmed by the recent changes in the CAP implementing regulations for certain aspects of an “environmental” nature.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
GIOVANNI GALASSO
Tutela degli acquisti del patrimonio agricolo e compatibilità con i princìpi del mercato unico europeo: riflessioni sulla sentenza C-419/23 della Corte di giustizia dell’UE [approfondisci]
La sentenza del 12 dicembre 2024 della Corte di giustizia dell’UE nella causa C-419/23 ribadisce l’incompatibilità delle restrizioni imposte dalla legislazione ungherese sulla trasmissibilità dei diritti di proprietà e di usufrutto sui terreni agricoli con i princìpi fondamentali del diritto dell’UE. In particolare, la decisione fa riferimento al diritto di registrare nuovamente il diritto di usufrutto illegittimamente cancellato, riconoscendo la necessità di ripristinare la situazione giuridica violata. Il contributo analizza il bilanciamento tra libertà di circolazione dei capitali, tutela dei diritti di proprietà e obiettivi di politica agraria, evidenziando la criticità di misure restrittive che, pur perseguendo obiettivi di interesse generale, risultano sproporzionate e prive di strumenti alternativi meno dannosi. L’azione coordinata della Corte e della Commissione europea definisce un quadro coerente per superare le misure restrittive che ostacolano la libera circolazione dei capitali e l’accesso al mercato fondiario, promuovendo un modello normativo basato su incentivi e monitoraggio dell’uso del suolo, nonché un uso più strategico delle risorse della PAC. Questo approccio è ulteriormente sviluppato nella comunicazione della Commissione «A Vision for Agriculture and Food» (2025), che sottolinea il ruolo centrale della PAC nel bilanciare la competitività, la sostenibilità e la tutela degli interessi agricoli, escludendo soluzioni nazionali che, attraverso restrizioni proprietarie, siano in conflitto con i princìpi fondamentali del diritto dell’UE.
The judgment of the Court of Justice of the EU in Case C-419/23 reaffirms the incompatibility of the restrictions imposed by Hungarian legislation on the transmissibility of property and usufruct rights over agricultural land with the fundamental principles of EU law. In particular, the decision refers to the right to re-register the unlawfully cancelled right of usufruct, recognizing the need to restore the violated legal situation. The contribution analyzes the balance between freedom of movement of capital, protection of property rights and agrarian policy objectives, highlighting the critical nature of restrictive measures that, while pursuing general interest objectives, are disproportionate and lack alternative, less damaging instruments. The coordinated action of the ECJ and the European Commission sets out a coherent framework to overcome restrictive measures that hinder the free movement of capital and access to the land market, promoting a regulatory model based on incentives and land use monitoring, as well as a more strategic use of CAP resources. This approach is further developed in the European Commission’s Communication «A Vision for Agriculture and Food» (2025), which emphasizes the central role of the CAP in balancing competitiveness, sustainability and the protection of agricultural interests, excluding national solutions that, through ownership restrictions, conflict with the fundamental principles of Union law.
[approfondisci]
Indice Fascicolo 1 - 2025
LAURA COSTANTINO
Regole di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari tra equilibrio dei rapporti b2b e concorrenza [approfondisci]
Il saggio analizza il quadro disciplinare relativo alle regole di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, con riferimento alle relazioni negoziali lungo la filiera e alle regole del mercato all’interno del quale operano le imprese, con particolare riguardo al tema della determinazione del prezzo nei contratti di cessione.
The paper analyses the disciplinary framework of the rules governing the marketing of agricultural and food products, with reference to the contracts of the agri-food chain and the rules of the market, with particular regard to the issue of pricing in the supply contracts.
DOMENICO CRISTALLO
La filiera olivicolo-olearia nella dimensione promozionale della PAC 2023-2027 e nella strategia nazionale: armonie e idiosincrasie tra competitività e sostenibilità [approfondisci]
La filiera olivicolo-olearia è stata, nel tempo, oggetto di una complessa trama normativa che ha interessato tutti i singoli segmenti della stessa. Il presente contributo pone il focus sul sistema promozionale delineato dai regolamenti della politica agricola comune (PAC) 2023-2027 e dal conseguente piano strategico nazionale relativo alla predetta filiera. Il PSP italiano fissa, difatti, «una strategia per il settore olivicolo-oleario che mette a disposizione degli operatori un sistema di interventi per il simultaneo raggiungimento dei seguenti obiettivi: miglioramento della competitività del settore, miglioramento della qualità della produzione; maggiore sostenibilità, inclusa quella sociale». Siffatta strategia si caratterizza per una molteplicità di strumenti che mirano a conformare l’attività dei singoli agricoltori, nonché la definizione di un agire collettivo degli stessi, verso il paradigma della sostenibilità cui è orientata la nuova PAC. Tuttavia, l’analisi delle singole misure mette in luce le sfide e le criticità relative all’efficacia e all’effettività del nuovo quadro giuridico, derivanti dalle intrinseche idiosincrasie esistenti tra sostenibilità e competitività.
The olive-oil sector has historically been governed by a comprehensive regulatory framework that has affected every segment of the supply chain. This paper centers on the promotional system established by the Common Agricultural Policy (CAP) 2023-2027 regulations and the corresponding National Strategic Plan for this sector. The Italian National Strategic Plan outlines a strategy for the olive-oil industry that equips operators with a suite of interventions to concurrently boost sector competitiveness, enhance production quality, and advance overall sustainability, including its social dimension. This strategy features a range of tools designed to shape the activities of individual farmers and to foster a collective approach, aligning with the sustainability orientation of the new CAP. Nevertheless, an examination of the specific measures reveals significant challenges and complexities in achieving the effectiveness and efficiency of this new legal framework, underscored by the inherent tensions between sustainability and competitiveness.
MAURIZIO FLICK
Il contenzioso climatico nel diritto agroalimentare: un intreccio di norme e giustizia [approfondisci]
Il cambiamento climatico rappresenta una doppia sfida per il settore agroalimentare, che subisce gli effetti di eventi climatici estremi ma, al tempo stesso, è responsabile di una quota rilevante delle emissioni di gas serra. Questo articolo analizza il ruolo del contenzioso climatico come strumento per affrontare le responsabilità nel diritto agrario e alimentare, approfondendo il legame tra giustizia climatica, sostenibilità e politiche di adattamento. Vengono esaminati i profili della responsabilità civile, le complessità del nesso di causalità e i limiti del sistema giuridico nel rispondere ai danni climatici.
Climate change presents a dual challenge for the agri-food sector, which suffers the impacts of extreme climatic events while also being a significant source of greenhouse gas emissions. This article examines the role of climate litigation as a tool to address responsibilities within agricultural and agri-food law, exploring the intersection of climate justice, sustainability, and adaptation policies. It analyzes civil liability frameworks, the complexities of causation, and the limitations of legal systems in addressing climate damages.
CLELIA LOSAVIO
Agricoltura e sussidiarietà orizzontale: le esperienze di cura e tutela del bene terra e il ruolo del legislatore regionale [approfondisci]
Agricoltura e sussidiarietà orizzontale: le esperienze di cura e tutela del bene terra e il ruolo del legislatore regionale
STEFANO MASINI
Parassiti e malattie delle piante. Sulla difesa dello Stato e la sicurezza alimentare [approfondisci]
L’impiego di prodotti in grado di prevenire o combattere parassiti o malattie delle piante si presta quale punto di osservazione per valutare il recupero, da parte dello Stato, di spazi di intervento dopo una lunga e, all’apparenza, inesorabile esperienza di integrazione di mercato a senso unico. La stessa imposizione di soglie di tolleranza ha, anzi, promosso l’importazione di prodotti agroalimentari ottenuti in aree geografiche in cui sono utilizzate sostanze altrimenti vietate, con una sottovalutazione delle necessità prioritarie di approvvigionamento. Una serie di fattori esterni torna, tuttavia, ad imporre la necessità del recupero dell’intervento statale chiamato ad occuparsi di temi sensibili per la comunità nazionale e la tutela della sicurezza alimentare ne riassume le funzioni di garanzia delle condizioni di vita. Ciò che mostra, partendo da un tema marginale, la possibilità del discorso dell’agrarista di inserirsi con adeguata consapevolezza nella riflessione sullo spazio giuridico europeo e sul riconoscimento del ruolo ancora ineludibile dello Stato imposto dalla complessità dell’oggetto segnalato.
The use of products capable of preventing or combating parasites or plant diseases lends itself as an observation point for assessing the recovery, by the State, of space for intervention after a long and, apparently, inexorable experience of one-way market integration. The very imposition of tolerance thresholds has, indeed, promoted the import of agri-food products obtained in geographic areas where otherwise banned substances are used, with an underestimation of priority supply needs. A series of external factors returns, however, to impose the need for the recovery of State intervention called upon to deal with sensitive issues for the national community and the protection of food security summarizes its functions of guaranteeing living conditions. What shows, starting from a marginal theme, the possibility of the agrarianist’s discourse to insert itself with adequate awareness in the reflection on the European legal space and on the recognition of the still unavoidable role of the State imposed by the complexity of the object reported.
FEDERICA RAFFONE
L’illegal oil blending fra cripticità della normativa europea e ricostruzione domestica del precetto [approfondisci]
Il presente contributo analizza uno specifico caso di blending dell’olio di oliva a partire da una recente pronuncia del Tribunale di Perugia, che attesta la liceità penale della miscelazione fra olio vergine ed extravergine d’oliva. La sentenza risulta originale per aver affrontato in maniera inedita il tema. Ricostruendo la «disciplina speciale specifica» dell’olio, e ripercorrendo i fatti ed i motivi che hanno determinato l’assoluzione per il giudice di prime cure, si indagherà se ci si trovi dinanzi ad una nuova casistica di illegal blending, o se tale pratica sia consentita ed esente da sanzioni. In definitiva, il caso portato ad esempio si rivela un’occasione di riflessione sulle problematiche di gestione domestica delle norme penali alimentari che presentino una struttura “aperta”, laddove l’essenza del precetto penalistico si fondi su un contenuto extra-penale, c.d. elemento normativo, necessariamente da ricostruire alla luce normativa europea cogente. Il caso risulta, inoltre, di particolare interesse per il penalista in quanto evidenzia l'emergere di un errore sulla legge extra-penale.
This paper analyzes a specific case of olive oil blending from a recent ruling of the Court of Perugia, which attests to the criminal lawfulness of blending virgin and extra virgin olive oil. The decision under comment is original for having addressed the issue in a novel way. Reconstructing the «oil’s specific special discipline», and reviewing the facts and reasons that led to the judge of first instance’s absolution, it will investigate whether it constitutes a new case of illegal blending, or whether this practice is permitted and exempt from sanctions. Ultimately, the case turns out to be an opportunity for reflection on the problems of domestic management of criminal food regulations that present an “open” structure, where the essence of the criminal precept is based on an extra-criminal content, so-called normative element, necessarily to be reconstructed in the light of cogent European legislation. The case is of particular interest to the criminalist because of the occurrence of an error on extra-criminal law.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
MARCO GJOMARKAJ
Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte EDU n. 16760/22 del 2024 [approfondisci]
Con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 16760/22, Executief van de Moslims van België ed a. c. Belgio la Corte EDU si è pronunciata sulla possibilità che il benessere animale possa configurarsi quale restrizione alla libertà di religione. Innestandosi in un quadro giurisprudenziale travagliato, che ha visto in più battute la Corte di giustizia europea prendere posizione sul punto, la decisione della Corte EDU sembra assumere una portata innovativa in quanto accosta la tutela del benessere animale, intesa quale principio di diritto, al concetto di moralità pubblica.
With the sentence of February 13, 2024, No. 16760/22, Executief van de Moslims van België and others. v. Belgium, the ECtHR ruled on the possibility that animal welfare could constitute a restriction on freedom of religion. Fitting into a troubled jurisprudential framework, which has seen the European Court of Justice take a position on the point on several occasions, the ECtHR’s decision seems to take on an innovative significance as it brings together the protection of animal welfare, understood as a principle of law, with the concept of public morality.
ANTONIO JANNARELLI
Le disavventure delle cooperative agricole di conferimento dinanzi alla Corte di cassazione: cronache di una giurisprudenza ondivaga [approfondisci]
La nota analizza criticamente la decisione di Cass. 28 maggio 2024, n. 14850. Questa, in conflitto con altre recenti decisione della stessa Corte di cassazione relative, però, anche a fattispecie diverse, si è occupata del tema relativo alla tutela del produttore agricolo socio di una cooperativa agricola a proposito della remunerazione a lui spettante in relazione ai suoi conferimenti di latte da trasformare in formaggio. Infatti, per via di un approccio concettualistico e fuorviante, pur pervenendo ad una soluzione corretta nel caso concreto, la decisione non tiene però conto sia delle caratteristiche operative proprie di queste cooperative, sia di tutto il quadro normativo applicabile, adottando una motivazione contraddittoria e fuorviante.
The note critically analyses the decision of Court of Cassation No. 14850 of May 28, 2024. This one, in conflict with other recent decisions of the same Court of Cassation relating, however, also to different cases, dealt with the issue of the protection of an agricultural producer who is a member of an agricultural cooperative with regard to the remuneration owed to him in relation to his milk deliveries to be transformed into cheese. In fact, although the decision reached a correct solution in the concrete case, it did not take into account both the operational characteristics of these cooperatives and the entire applicable regulatory framework, adopting a contradictory and misleading motivation.
Indice Fascicolo 3 - 2024
ETTORE BATTELLI
Innovazione tecnologica e gestione della filiera agroalimentare [approfondisci]
L’utilizzo delle nuove tecnologie assume un ruolo sempre più determinante per garantire la sicurezza alimentare, incidendo in maniera significativa sulle dinamiche del mercato dell’agrifood, nel quale le imprese coinvolte sono chiamate ad un continuo confronto sul piano della produzione di beni agroalimentari di qualità, sani e sicuri per i consumatori. Al fine di assicurare un maggiore benessere alimentare, così come un più elevato livello di sicurezza e qualità dei prodotti, un ruolo centrale nell’ambito del sistema di gestione agrifood assume l’impiego di alcune tecnologie: sistemi di intelligenza artificiale (IA), blockchain, Internet of Things (IoT), app. mobile, cloud. Nel settore agroalimentare, queste ultime si rivelano strategiche, non solo per favorire la disintermediazione delle transazioni e una maggiore trasparenza nei rapporti tra le parti coinvolte, ma anche per promuovere una tracciabilità dinamica pro-competitiva a vantaggio tanto degli operatori coinvolti nella catena di produzione e distribuzione (supply chain) quanto dei consumatori-clienti finali.
The use of new technologies is taking on an increasingly decisive role in ensuring food security. Indeed, it is significantly affecting the dynamics of the agrifood market, in which companies involved are called upon to sistematically compete among themselves in terms of production of quality agrifood goods that are healthy and safe for consumers. In order to ensure a greater food welfare, as well as a higher level of product safety and quality, the use of certain technologies, such as artificial intelligence (AI) systems, blockchain, Internet of Things (IoT), mobile apps, and Cloud, assumes a key role within the agribusiness management system. In the agrifood sector, the above mentioned means prove to be strategic for two main reasons: firstly, they foster both the disintermediation of transactions and a greater transparency in the relationships between the parties involved; secondly, they promote a dynamic and pro-competitive traceability of the products, so to benefit both the operators involved in the production and distribution chain and consumers-final customers.
NICOLETTA FERRUCCI
Il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura: una prima overview [approfondisci]
Il lavoro analizza l’impianto complessivo e le linee di indirizzo del nuovo regolamento dell’Unione europea sul ripristino della natura che ha concluso il suo iter di approvazione il 16 giugno 2024, e offre una panoramica dei suoi punti salienti, mettendone in luce gli aspetti innovativi e i profili di criticità.
The paper analyzes the overall plant and the guidelines of the new European Union Regulation on Nature Restoration which concluded its approval process on 16 June 2024, and offers an overview of its key points, highlighting its positive aspects and critical profiles.
LUCA LEONE
Big data e intelligenza artificiale nell’agricoltura europea 4.0: una lettura etico-giuridica [approfondisci]
Nell’ambito del crescente fenomeno della digitalizzazione in agricoltura, lo sviluppo e la moltiplicazione delle fonti di accesso e produzione di grandi quantità di dati, personali e non, pongono sul piano etico-giuridico temi di frontiera che esigono di coniugare le finalità agro-alimentari-ambientali con la transizione ecologica verso un sistema resiliente. Si tratta, per esempio, dell’approccio normativo all’ingegneria dei sistemi e alla gestione dei big data; dei criteri di responsabilità e sicurezza nei processi decisionali automatizzati; delle garanzie di visibilità e trasparenza nella validazione di algoritmi che fanno uso dell’intelligenza artificiale. A fronte dei potenziali rischi derivanti dall’utilizzo di dispositivi mobili, macchinari e sensori collegati in rete, e delle questioni etiche correlate ai profili di opacità e ambiguità sottesi alle procedure di data analytics e machine learning, il contributo intende esplorare le nascenti riflessioni che autorità pubbliche e organismi non governativi stanno elaborando alla ricerca di princìpi armonizzati nello scenario istituzionale europeo. In questa prospettiva, gli approcci normativi by design rilevano come forme sperimentali di tecno-regolazione volte ad aprire spazi di riflessione e decisione rispetto a nuovi «diritti digitali» e a criteri di sostenibilità da condividere e implementare nelle pratiche agricole del domani.
Against the growing phenomenon of digitalisation in agriculture, the development and multiplication of sources for accessing and producing large quantities of personal and agronomic data raise ethical and legal issues. These aspects require agrifood and environmental purposes to be aligned with the ecological transition towards a resilient system. Examples include: the regulatory approach to systems engineering and big data management; the criteria for responsibility and security in automated decision-making processes; the guarantees of visibility and transparency in the validation of algorithms that make use of artificial intelligence. Considering the potential risks arising from the use of networked sensors and devices, as well as the ethical concerns related to the opacity and ambiguity underlying data analytics and machine learning procedures, this contribution explores the reflections that public authorities and non-governmental bodies are developing in search of harmonised normative principles. In this perspective, the evolving approaches of regulation by design are emerging as experimental forms of normativity to be framed and promoted for greater transparency and sustainability. Indeed, they appear suitable to opening spaces for debate and discussion as regards new «digital rights» and innovation criteria to define and implement in the agricultural practices of tomorrow.
STEFANO MASINI
La resistibile ascesa dell’azione pubblica di contrasto alle pratiche commerciali sleali [approfondisci]
Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, muove verso il definitivo superamento della tradizionale debolezza degli agricoltori nei rapporti tra imprese lungo la filiera. Le indagini avviate dalla Commissione europea registrano, tuttavia, a livello dei singoli Stati membri, alcune difficoltà operative connesse alla scarsa efficacia delle misure adottate dalle autorità pubbliche nelle attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali, con conseguente aumento dell’effetto paura nei confronti della parte più forte in termini di potere contrattuale. Nel nostro ordinamento, mentre non sembra trovare una adeguata diffusione il perfezionamento dei contratti di cessione ordinati ad esigenze di giustizia contrattuale e, come tali, riconosciuti conformi a buone pratiche commerciali, l’attività di contrasto esercitata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), appare in progressivo sviluppo nonostante le difficoltà imposte dai differenziali biologici che presentano specifiche filiere e, sopra tutto, per gli evidenti limiti procedurali derivanti dalla necessità di osservare la l. 24 novembre 1981, n. 689. Si segnala, così, la necessità di introdurre, attraverso un apposito regolamento sulle procedure istruttorie essenziali modifiche, capaci di rispondere ad esigenze di certezza e trasparenza, anche in vista della corretta rilevazione dei costi.
Legislative Decree No. 198 of 8 November 2021, which implements Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, moves towards definitively overcoming the traditional weakness of farmers in business-to-business relations along the supply chain. However, the investigations launched by the European Commission record, at the level of the individual Member States, some operational difficulties related to the limited effectiveness of the measures taken by public authorities in combating unfair commercial practices, with a consequent increase in the fear effect against the stronger the party in terms of bargaining power. In our legal system, while the completion of transfer contracts ordered to meet contractual justice requirements and, as such, recognized as conforming to good commercial practices does not seem to find adequate diffusion, the law enforcement activity carried out by the Central Inspectorate Department for the Protection of Quality and Repression of Food Fraud (ICQRF), appears to be progressively developing despite the difficulties imposed by the biological differentials that specific supply chains present and, above all, due to the evident procedural limits deriving from the need to comply with the Law of 24 November 1981, n. 689. Thus, it is necessary to introduce, through a specific regulation on the preliminary investigation procedures, essential changes to meet the requirements of certainty and transparency, also with a view to the correct recognition of costs.
LORENZA PAOLONI
Sostenibilità e innovazione in agricoltura. Dilemma o opportunità? [approfondisci]
Il raggiungimento degli obiettivi generali prefigurati dall’Agenda 2030, nell’ambito dell’ampio progetto dello sviluppo sostenibile globale, presenta serie difficoltà e la sostenibilità (ambientale, economica, sociale ed ora anche culturale) rischia di diventare un semplice miraggio per il mondo rurale mentre dovrebbe essere un necessario elemento di conformazione dell’impresa agricola. Gli agricoltori devono diventare loro stessi protagonisti dei meccanismi di rinnovamento che interessano i territori rurali, in modo sistemico e secondo processi bottom up, che comportano la mescolanza delle conoscenze locali e delle conoscenze tecnologiche, in una prospettiva di vera sostenibilità.
Achieving the general objectives prefigured by the 2030 Agenda, within the broad project of global sustainable development, presents serious difficulties and sustainability (environmental, economic, social and now also cultural) risks becoming a simple mirage for the rural world while it should be a necessary element of conformation of the agricultural enterprise. Farmers themselves must become protagonists of the renewal mechanisms that affect rural territories, in a systemic way and according to bottom up processes, which involve the mixing of local knowledge and technological knowledge, in a perspective of true sustainability.
FRANCESCO PAOLO TRAISCI
Primo non uccidere: il diritto alla vita dell’animale selvatico e la caccia [approfondisci]
L’attività venatoria, insieme alla raccolta di frutti spontanei, è stata sicuramente la prima attività con la quale l’essere umano si è procurato il proprio sostentamento. E, anche quando l’uomo ha iniziato a dedicarsi alla coltivazione del fondo ed all’allevamento, l’uccisione di animali selvatici ha rappresentato una diffusa occupazione, svolta spesso a fini ludici ma regolamentata dalla legge nei vari contesti nazionali, con la considerazione che l’animale selvatico fosse comunque un oggetto a disposizione dell’uomo. Questa concezione utilitaristica dell’animale si è tuttavia progressivamente scontrata con una visione più empatica nei suoi confronti, secondo la quale egli dovrebbe essere considerato un essere sensibile, capace di pensiero e di sofferenza, e non un mero oggetto di diritti. Proprio in quest’ottica sono stati introdotti strumenti di tutela penale degli animali, in particolare della loro incolumità fisica, che debbono tuttavia trovare un contemperamento con la riconosciuta liceità dell’attività venatoria. Il presente saggio si prefigge proprio di delineare gli estremi di questa contrapposizione fra la normativa penale che punisce chiunque uccida senza necessità un animale ed il diritto di caccia riconosciuto e regolamentato dal nostro ordinamento (così come da quasi tutti gli ordimenti occidentali), valutando le soluzioni attualmente adottate.
Hunting, together with gathering of wild fruits, was certainly the first activity provided by the human in order to procure his livelihood. And even when man began to devote himself to har-vesting and breeding, the killing of wild animals still represented a widespread activity often car-ried out as a sport or for recreational purposes, with the view that wild animals were things avail-able to the humans. This utilitarian view has, however, progressively clashed with a more empathic vision of animals seen as sensitive beings, capable of though and of sufferance, and not as mere objects. According the this different point of view, rulers have issued laws of criminal protection against abuses and cruelty towards animals. These rules must however find a coherence with the recognized liceity of the hunting activity. The present article aims to outline the issues involved by the contradiction between criminal rules that prohibits the killing of animals without due necessity and the right of hunting, and the solutions currently provided.
GIUSEPPE VERSACI
La regolazione dei dati per l’agricoltura di precisione tra questioni generali ed esigenze settoriali [approfondisci]
L’utilizzo di dispositivi intelligenti nelle varie fasi della filiera agroalimentare richiede una riflessione sul piano giuridico, soprattutto alla luce della recente normativa europea in tema di accesso ai dati generati da simili prodotti e servizi tecnologici (reg. UE n. 2023/2854: c.d. Data Act). Dopo aver ricostruito le novità di tale disciplina generale, l’articolo si sofferma sulle peculiarità del contesto agricolo, suggerendo un intervento regolatorio che, pur non sconfessando l’impianto del Data Act, si adatti meglio alle specifiche esigenze degli operatori del settore.
The use of smart devices in the different stages of the agri-food supply chain calls for a legal analysis, especially in the light of the recent EU regulation on access to data generated by such technological products and services (Reg. EU No. 2023/2854: so-called Data Act). After outlining the novelties of this general regulation, the article dwells on the peculiarities of the agricultural context and suggests the adoption of rules that, while not contracting the structure of the Data Act, are better suited to address the specific needs of sector-operators.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
SONIA CARMIGNANI
Società, agrarietà e oggetto sociale [approfondisci]
L’esonero di una società agricola dall’assoggettamento alle procedure fallimentari non può ritenersi incondizionato, venendo meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con il «ciclo biologico», inteso come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all’art. 2135 c.c., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, ovvero quando risulti accertato in sede di merito che l’impresa agricola costituita in forma societaria abbia esercitato in concreto attività commerciale, in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale. Alla ricerca degli indici di qualificazione di una società agricola, ai fini della sottrazione alla procedura fallimentare, si pone, cioè, la questione dell’effettività dell’oggetto sociale. L’interrogativo è quale statuto debba essere applicato nell’ipotesi in cui alla dizione società agricola e all’oggetto dichiarato agricolo non corrisponda sul piano dell’effettività l’esercizio di un’attività ex art. 2135 c.c., così come quale statuto applicare nel caso di società ad oggetto dichiarato commerciale che svolga nei fatti attività agricola, e quale disciplina, infine applicare quando l’oggetto dichiarato agricolo sia in realtà un oggetto illecito.
The exemption of an agricultural company from being subject to bankruptcy procedures cannot be considered unconditional, as it ceases when the functional connection with the «biological cycle», understood as a production factor, is in fact non-existent or when the connected activities referred to in Art. 2135 of the Civil Code, take on decidedly prevalent importance, disproportionate to those of cultivation, livestock and forestry, or when it is ascertained in the merits that the agricultural enterprise established in corporate form has actually exercised commercial activity, to a prevalent extent on agricultural activity contemplated exclusively by the corporate purpose. In search of the qualification indices of an agricultural company, for the purposes of avoiding bankruptcy proceedings, the question of the effectiveness of the corpo-rate purpose arises. The question is which statute should be applied in the event that the term agricultural company and the declared agricultural object do not correspond in terms of effectiveness to the exercise of an activity pursuant to art. 2135 of the Civil Code, as well as which statute to apply in the case of a company with a declared commercial object which actually carries out agricultural activity, and which regulations to finally apply when the declared agricultural object is in reality an unlawful object.
2024
[approfondisci]Indice Fascicolo 2 - 2024
MARIA AMBROSIO
Assetti organizzativi adeguati e sostenibilità nelle imprese agricole [approfondisci]
L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese, anche agricole, sulle quali si intende concentrare l’attenzione, ha di recente trovato attualità normativa alla luce dell’art. 2086, comma 2 del codice civile. Lo studio in esame si propone di indagare se sussistano ulteriori assetti di impresa agricola oltre quelli tipicamente previsti nella norma in oggetto, anche alla luce della normativa europea di settore. Il riferimento va in particolare alla direttiva 2022/2464/UE, più nota come CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Il lavoro sarà svolto anche alla luce delle recenti modifiche costituzionali nonché con riferimento alle norme di organismi internazionali e dell’Unione europea al fine di far emergere le nuove frontiere delle imprese agricole nella direzione della sostenibilità coniugata agli assetti organizzativi adeguati.
The adequate organizational, administrative and accounting structures of enterprises – including agricultural enterprises – have recently set out in Art. 2086 of the Italian Civil Code. The present study aims at defining the existence of further aspects exceeding those contemplated in the said article in the light of the European legislation and principles with special regards to sustainable development as well as to the Directive 2022/2464/UE, best known as CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). The research work takes into account the recent amendments in the Italian Constitution as well as the guidelines of the international organizations and the European Union so as to highlight the new frontiers of the agricultural enterprises towards sustainability and adequate organizational structures.
FRANCESCO AVERSANO
Sulla circolazione degli alimenti nel virtuale e nel metaverso. Intersezioni e modelli possibili [approfondisci]
Il lavoro concerne alcuni sviluppi del mercato alimentare relativi alla veicolazione dei cibi attraverso circuiti virtuali e di metaverso. Si rafferma la convenienza di un’adesione alla disciplina del settore, misurata in termini di rispondenza ai modelli contrattuali e alla diligenza degli operatori.
The paper concerns certain developments in the food market relating to the conveyance of food through virtual and metaverse circuits. It confirms the need for full adherence to the discipline of the sector, verified in terms of compliance with contractual models and the diligence of operators.
ANDREA CALONI
Cessione di prodotti agricoli e alimentari: struttura della contrattazione e rimedi [approfondisci]
La filiera agroalimentare è spesso teatro di rapporti asimmetrici, ma la direzione in cui l’asimmetria opera in concreto non può essere determinata a priori. Questa considerazione, che sta alla base della disciplina introdotta dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, induce a riflettere sugli spazi dell’autonomia privata nei rapporti di filiera, condizionata, più che dai rimedi civilistici, dalle sanzioni amministrative e penali, per chiedersi se il legislatore abbia fornito agli operatori strumenti efficaci oppure se l’effetto della disciplina speciale si risolva nell’imporre un mero formalismo. L’attenzione è dedicata, in particolare, al ruolo dell’accordo quadro e al rapporto tra contenuto del contratto e pratiche commerciali sleali.
The agrifood supply chain is often the scene of asymmetrical relationships, but the direction in which the asymmetry operates in practice cannot be determined a priori. This consideration, which underlies the discipline introduced by Legislative Decree No. 198 of November 8, 2021, leads to reflection on the spaces of private autonomy in supply chain relations, conditioned, more than by civil law remedies, by administrative and criminal sanctions, to ask whether the regulation has provided operators with effective tools or whether the effect of the special discipline is resolved in imposing mere formalism. Attention is devoted, in particular, to the role of the framework agreement and the relationship between contract content and unfair trade practices.
SONIA CARMIGNANI
L’acqua e il suo riciclo. Considerazioni sulla fertirrigazione [approfondisci]
Il trattamento e il riciclo delle acque assolvono a finalità di tutela ambientale ma rispondono anche ad obiettivi di efficienza economica. Con specifico riferimento al settore agricolo, il riutilizzo dell’acqua a fini irrigui contribuisce a promuovere l’economia circolare recuperando i nutrienti dalle acque affinate e applicandoli ai raccolti mediante tecniche di fertirrigazione. Il trattamento e riciclo delle acque ad usi irrigui in agricoltura presenta il volto di buona pratica nella prospettiva della sostenibilità e della tutela ambientale; di efficienza economica dell’impresa, rendendo le acque reflue non un rifiuto ma un bene aziendale ed un bene dell’azienda essenziale; di un diverso modo di fare agricoltura, supportando il ciclo della vita, dunque la produzione, con il recupero di nutrienti piuttosto che con l’apporto esterno di concimi, in un ciclo virtuoso diretto ad autoalimentarsi.
The treatment and recycling of water fulfills environmental protection purposes but also responds to economic efficiency objectives. With specific reference to the agricultural sector, the reuse of water for irrigation purposes contributes to promoting the circular economy by recovering nutrients from refined water and applying them to crops using fertigation techniques. The treatment and recycling of water for irrigation uses in agriculture presents the aspect of good practice in the perspective of sustainability and environmental protection; of economic efficiency of the company, making waste water not a waste but a company asset and an essential company asset; of a different way of doing agriculture, supporting the cycle of life, therefore production, with the recovery of nutrients rather than with the external supply of fertilizers, in a virtuous cycle aimed at self-feeding.
NICOLETTA FERRUCCI
La prospettiva tridimensionale del giardino storico tra cultura, ambiente e paesaggio: icona del novellato art. 9 della Costituzione [approfondisci]
Il lavoro ripercorre le orme della normativa in materia di giardini storici, evidenziando l’evoluzione dell’approccio legislativo dalla mera protezione del relativo valore culturale e paesaggistico al riconoscimento del loro importante ruolo nell’ambito della politica ambientale e climatica, fino a configurare questa peculiare tipologia del giardino come una icona della trilogia di valori, cultura, paesaggio e ambiente, tutelati dal novellato art. 9 della Costituzione.
The work traces the footsteps of the legislation on historic gardens, highlighting the evolution of the legislative approach from mere protection of their cultural and landscape value to recognition of their important role in environmental and climate policy, up to configure this peculiar type of garden as an icon of the three values, culture, landscape and environment, currently protected by the novel Art. 9 of the Constitution.
FIORE FONTANAROSA
The right of animals to life and freedom: a comparative review of case law [approfondisci]
La maggior parte delle persone concorda sul fatto che il diritto alla vita è il diritto umano più importante, perché costituisce la base per la tutela di tutti gli altri diritti fondamentali, incluso il diritto alla salute e quello alla libertà. Ciononostante, negli ultimi anni i legislatori e i giudici hanno riconosciuto, in molti casi, agli animali o comunque ad alcuni di essi i diritti alla vita, al benessere e alla libertà. La dottrina e la giurisprudenza si sono recentemente concentrate sull’identificazione dei diritti degli animali, cercando di enumerare sempre nuovi diritti potenzialmente attribuibili a questi esseri viventi, nonostante il fatto che l’espressione «diritti degli animali» possa sembrare un ossimoro, una contraddizione in termini, perché gli esseri umani sono gli unici che possono far valere i diritti nei confronti degli altri esseri umani. L’obiettivo di questo studio è quello di valutare, tramite un’analisi delle più significative e recenti pronunce in materia di diritti degli animali, se e in quale misura la giurisprudenza tuteli, in maniera concreta ed effettiva, i diritti alla vita e alla libertà che alcuni legislatori hanno concesso agli animali. Lo scopo del contributo è anche quello di accertare, in una prospettiva comparativa, quali sistemi giuridici mostrano un maggiore livello di attenzione e sensibilità nei confronti della protezione dei diritti degli animali.
Most people agree that the right to life is the most important human right because it is the basis for protecting all other fundamental rights, including the right to health and freedom. Nonetheless, there have been numerous instances in the past few years of lawmakers and judges awarding animals, or at least some of them, the right to life, welfare, and freedom. Doctrine and case law have recently focused on the identification of animal rights, always trying to enumerate new rights potentially attributable to these living beings, even though the term «animal rights» may seem like an oxymoron, a contradiction in terms, because humans are the only ones who can enforce rights against other humans. This study aims to assess, through an analysis of the most significant and recent rulings in the area of animal rights, if and to what degree the case law respects the rights to life and freedom that some legislators have granted to animals. The aim of the paper is also to ascertain, from a comparative perspective, which legal systems exhibit a higher level of attention and sensitivity towards protecting animal rights.
MARIANITA GIOIA
La disciplina europea in materia di etichettatura nutrizionale front-of-pack [approfondisci]
Il front-of-pack nutrition labelling è stato individuato dalla Commissione europea quale potenziale e fondamentale strumento per orientare le scelte dei consumatori verso regimi alimentari più sani nell’ottica di un cambio complessivo di paradigma dei sistemi alimentari europei. L’analisi dell’attuale normativa, delle implicazioni giuridiche, economiche e politiche e la disamina dei diversi modelli di etichettatura nutrizionale sintetici più diffusi nel mercato agroalimentare europeo aiutano ad indagare sull’efficacia di tale strumento.
The European Commission has identified front-of-pack nutrition labelling as a potential tool to guide consumer choices towards healthier diets in order to promote a paradigm shift in European food systems. An analysis of the currently applicable legislation, an analysis of the legal, economic and political implications and an examination of the various synthetic nutrition labelling models, most widely used in the European agri-food market, helps to investigate the effectiveness of this tool.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
LAURA COSTANTINO
Produzione e commercializzazione di uva senza semi: uso e abuso del principio dell’ordine pubblico [approfondisci]
Il lavoro analizza in modo critico la recente pronuncia della Corte di cassazione in materia di privative sui ritrovati vegetali, inquadrando la complessa fattispecie negoziale oggetto di valutazione giudiziale nell’ambito dei contratti di integrazione verticale.
The paper critically analyzes the recent decision of the Supreme Court in the field of plant variety rights, framing the complex contracts subject to judicial evaluation in the context of vertical integration contracts.
Indice Fascicolo 1 - 2024
GIULIA DE LUCA
Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti per i vini, fra tecnicismi informativi e barriere digitali [approfondisci]
Il reg. (UE) n. 2021/2117 ha introdotto delle importanti novità per il settore vitivinicolo, prevedendo, in particolare, l’obbligo di fornire ai consumatori la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti dei vini, a decorrere dall’8 dicembre 2023. La disamina della disciplina riservata a tali indicazioni rivela come esse mirino non solo a colmare una situazione di asimmetria informativa, ma anche a fornire ai consumatori gli strumenti per compiere scelte più consapevoli e in linea con l’obiettivo di favorire una generale riduzione del consumo di alcolici. Senonché il legislatore europeo, nel demandare una chiara funzione educativa alle informazioni di cui si tratta, non pare aver tenuto in debita considerazione le specificità che caratterizzano i prodotti enologici e le dinamiche di consumo che li riguardano. Ne consegue che le nuove informazioni previste per i vini e, in particolare, l’elenco degli ingredienti, rischiano di risultare scarsamente comprensibili per la maggior parte dei consumatori, generando potenziali situazioni di fraintendimento e di incertezza rispetto ai dati conoscitivi veicolati. Inoltre, il reg. (UE) n. 2021/2117 ha previsto che, a talune condizioni, gli operatori del settore enologico potranno fornire le informazioni di cui si tratta per via elettronica, limitandosi a indicare in etichetta, ad esempio, un QR-code per consentire ai consumatori di accedere con gli smartphone ai dati relativi alla dichiarazione nutrizionale completa e all’elenco degli ingredienti. Tale possibilità impone una riflessione sull’impiego delle nuove tecnologie nella fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti ai consumatori e sulla necessità di evitare che il ricorso a tali strumenti determini, di fatto, la creazione di barriere e di meccanismi di discriminazione, a causa del persistente divario digitale.
Reg. (EU) No. 2021/2117 has introduced important innovations for the wine sector, imposing, particularly, the obligation to provide consumers with the nutrition declaration and the list of ingredients of wines, as of December 8, 2023. An examination of the discipline reserved for such information reveals how they aim not only to bridge an information asymmetry situation, but also to provide consumers with the tools to make more informed choices that are in line with the goal of encouraging a general reduction in alcohol consumption. However, the European legislator, in devolving an educational function to the information in question, does not seem to have given due consideration to the specificities that characterize wine products and the consumption dynamics that affect them. As a result, the new information imposed for wines and the list of ingredients, risks being poorly understood by most consumers, generating potential situations of misunderstanding and uncertainty with respect to the cognitive data conveyed. In addition, Reg. (EU) No. 2021/2117 has provided that, under certain conditions, wine operators may provide the information in question electronically, merely indicating on the label, for example, a QR-code to allow the consumers to access with smartphones the data related to the full nutrition declaration and the list of ingredients. This possibility calls for reflection on the use of new technologies in the provision of mandatory food information to consumers and the need to prevent the use of such tools from leading to the creation of barriers and mechanisms of discrimination, due to the persistent digital divide.
CLAUDIA GESMUNDO
Questioni sulle tipologie contrattuali flessibili nel mercato del lavoro in agricoltura [approfondisci]
Muovendo da un’analisi relativa alle specificità del mercato del lavoro agricolo, il saggio esamina i profili che contraddistinguono i contratti più utilizzati per l’impiego di lavoratori subordinati nel settore agricolo, anche in relazione al sistema di contrattazione collettiva operante in agricoltura, alle opportunità di rilancio dell’occupazione e ai meccanismi di cooperazione tra produttori agricoli, in una visione tendente a garantire una maggiore stabilità ai rapporti di lavoro. Il contributo si sofferma poi sul lavoro occasionale e, in particolare, sulla recente evoluzione legislativa in materia di prestazioni di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura, per evidenziare i rischi che presenta tale fattispecie, volta ad ampliare gli strumenti di flessibilità, rispetto all’effettività delle tutele dei lavoratori e al contrasto al lavoro irregolare in agricoltura.
Starting from an analysis related to the specifics of the agricultural labor market, the paper examines the profiles that distinguish the most commonly used contracts for the employment of subordinate workers in the agricultural sector, also in connection to the system of collective bargaining operating in agriculture, the opportunities for boosting employment and the mechanisms of cooperation between agricultural producers, in a vision tending to ensure greater stability in labor relations. The essay focuses on occasional work and, in particular, on the recent legislative evolution in the area of occasional fixed-term employment in agriculture, to highlight the risks presented by this case, aimed to expanding flexibility tools, related to the effectiveness of worker protections and the fight against irregular work in agriculture.
GIULIA TORRE
Gli effetti della riforma introdotta dal reg. (UE) n. 2019/1381 sulla procedura di autorizzazione dei novel foods. Trasparenza versus innovazione? [approfondisci]
Il rapporto tra innovazione e trasparenza pone sfide peculiari nel quadro europeo dei novel foods, legate alla necessità di sostenere la commercializzazione di prodotti innovativi, potenzialmente in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e sicurezza alimentare, al contempo migliorando, nella fase di valutazione del rischio, la trasparenza della procedura e, quindi, l’applicazione del principio di precauzione. Il presente documento intende identificare i contenuti del principio di trasparenza alla luce della riforma introdotta dal reg. (UE) n. 2019/1381, per verificare come tale regolamento si ripercuote sulla valutazione del rischio degli alimenti nuovi. Dopo aver esaminato le modifiche che hanno interessato la procedura di autorizzazione dei prodotti regolamentati e la divulgazione dei documenti detenuti dall’EFSA, sono evidenziati gli elementi di principale novità e le problematiche emerse dalla recente applicazione del reg. (UE) n. 2015/2283 in materia di novel foods e analizzate le principali modifiche introdotte dal reg. (UE) n. 2019/1381 alla procedura di autorizzazione di tali alimenti innovativi. Alla luce dei canoni di trasparenza e innovazione, l’elaborato si interroga sull’idoneità del quadro legislativo vigente a rispondere alle sfide poste dalla produzione e commercializzazione di novel foods nel mercato agroalimentare europeo, coniugando le esigenze pubbliche di trasparenza con la necessità di sostenere il rinnovamento della filiera alimentare.
The relationship between innovation and transparency poses peculiar challenges in the European framework of novel foods, related to the need to support the marketing of innovative products, potentially able to contribute to the achievement of sustainability and food safety objectives, while at the same time improving, at the risk assessment stage, the transparency of the procedure and, therefore, the application of the precautionary principle. This paper intends to identify the contents of the transparency principle in the light of the reform introduced by Regulation (EU) 2019/1381, in order to examine the impact of the provisions introduced by this regulation on the risk assessment of novel foods. After examining the changes that have affected the authorisation procedure for regulated products and the disclosure of documents held by EFSA, the main new elements and issues that have emerged from the recent application of Regulation (EU) 2015/2283 on novel foods are highlighted and the key changes introduced by Regulation (EU) 2019/1381 to the novel food authorisation procedure are analysed. In the light of the canons of transparency and innovation, the paper questions the suitability of the current legislative framework to respond to the challenges posed by the production and marketing of novel foods in the European agri-food market, combining public demands for transparency with the need to support the renewal of the food supply chain.
STEFANIA VASTA E STEFANIA PEDRABISSI
Enoturismo: un modello di sostenibilità e valorizzazione del territorio [approfondisci]
Il contributo si pone l’obiettivo di riflettere sul tema dell’enoturismo in chiave giuspubblicistica al fine di cogliere quegli aspetti della regolazione che contribuiscono ad allineare detta disciplina ai valori dominanti in questo momento storico. Gli Autori propongono una riflessione sugli ambiti che, nell’esperienza italiana, caratterizzano il turismo enologico, e che si articolano in piena sinergia con i canoni di sostenibilità e di valorizzazione delle comunità rurali entro le quali si radicano gli insediamenti vitivinicoli; con il fine ultimo di individuare alcuni «sistemi/modelli virtuosi» da replicare o implementare, con il contributo di soggetti pubblici e privati.
The contribution aims to reflect on the topic of wine tourism from a public law perspective in order to grasp those aspects of regulation that contribute to aligning this discipline with the dominant values in this historical moment. The Authors propose a reflection on those areas which, in the Italian experience, characterize wine tourism, and which are articulated in full synergy with the canons of sustainability and valorisation of the rural communities within which the wine-growing settlements are rooted; with the ultimate aim of identifying some «virtuous systems/models» to replicate or implement, with the contribution of public and private entities.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
MARCO GJOMARKAJ
Riflessioni sulla competenza regionale in materia di tutela degli animali [approfondisci]
Partendo dalla recente sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2023, n. 121, il presente contributo offre alcune riflessioni circa il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni con riguardo alla tutela degli animali e in particolare con riguardo al fenomeno relativo alla sovrapposizione di sanzioni amministrative regionali alla disciplina penale. La decisione della Corte fornisce, inoltre, ulteriori e utili spunti di ragionamento circa il nuovo assetto Costituzionale con riguardo al tema ambientale e, in particolare, circa le ricadute in materia di tutela degli animali in conseguenza all’introduzione del nuovo ultimo comma dell’art. 9 Cost. L’art. 9 Cost., ult. comma, infatti, introduce una riserva di legge statale quanto ai modi e le forme di tutela degli animali.
Starting from the recent ruling of the Constitutional Court of 15 June 2023, n. 121, this contribution offers some reflections on the division of legislative competences between the State and the Regions with regard to the protection of animals and in particular with regard to the phenomenon relating to the overlap of administrative sanctions regional to criminal discipline. The Court’s decision also provides further and useful ideas for reasoning about the new Constitutional structure with regard to the environmental issue and, in particular, about the implications for the protection of animals following the introduction of the new last paragraph of the Article 9 Const. Article 9 Const., last paragraph, in fact, introduces a state law reservation regarding the methods and forms of animal protection.
STEFANO MASINI E ALDO NATALINI
Miscelazione di oli di oliva senza frode in commercio. A margine della prima sentenza di merito in tema di blending tra vergine ed extravergine [approfondisci]
La nota a sentenza, scritta «a quattro mani», affronta da due diversi punti di vista – quello del penalista e quello dell’agrarista – l’annosa questione, trattata per la prima volta dal Tribunale di Perugia, della (ir)rilevanza penale delle pratiche di miscelazione (c.d. blending) tra oli di oliva extravergini e vergini, tanto diffuse nella pratica dei trasformatori e produttori di olio industriale e tuttavia finora mai trattate nella giurisprudenza (né di merito né di legittimità) in tema di frode in commercio, mercè le note del Ministero dell’agricoltura e della D.G. Agri della Commissione europea che ne hanno affermato, più di vent’anni fa, la liceità, in quanto riguardanti un’unica categoria merceologica ai sensi del regolamento CEE n. 2568/1991. Il penalista analizza la proposizione principale da cui muove il Tribunale di Perugia a fondamento dell’assunto assolutorio, verificando se effettivamente – e, in caso positivo, a quali condizioni e con quali conseguenze – l’alterità e la diversità costituiscono elementi normativi della fattispecie di frode in commercio, come tali da interpretare alla luce della disciplina di settore, nella specie europea. L’agrarista sottopone invece a vaglio critico la ricostruzione del quadro europeo di riferimento operata in sentenza, al fine di verificare se la propugnata miscelabilità trovi effettivo riscontro nella sopravvenuta normativa.
The sentence note, written «by four hands», tackles from two different points of view – that of the criminalist and that of the agrarianist – the long-standing issue, dealt with for the first time by the Court of Perugia, of the criminal (ir)relevance of blending practices between extra-virgin and virgin olive oils, so widespread in the practice of processors and producers of industrial oil and yet so far never dealt with in jurisprudence (neither of merit nor legitimacy) on the subject of fraud in trade, thanks to the notes of the Ministry of Agriculture and the D.G. Agri of the European Commission that affirmed, more than two decades ago, their lawfulness, as they referred to a single commodity category under EEC Regulation No. 2568/1991. The penalist analyzes the main proposition from which the Court of Perugia moves as the basis of the absolutory assumption, verifying whether indeed – and, if so, under what conditions and with what consequences – otherness and diversity constitute normative elements of the cases of fraud in trade, as such to be interpreted in the light of the sector regulations, in this case European. Instead, the agrarist subjects the reconstruction of the European frame of reference made in the judgment to critical scrutiny, in order to ascertain whether the advocated mixability is actually reflected in the above legislation.
2023
[approfondisci]Indice Fascicolo 3 - 2023
IRENE CANFORA
Le Organizzazioni di produttori agricoli tra funzioni di mercato e composizione interna. Riflessioni a margine della sentenza della Corte di giustizia nel caso Saint-Luis Sucre [approfondisci]
Nella visione dell’attuale politica agricola comune costruita intorno alle relazioni tra i soggetti della filiera, le organizzazioni di produttori assumono un ruolo centrale nella regolazione del mercato, principalmente perché rafforzano la posizione dei produttori agricoli nelle relazioni contrattuali di fornitura delle materie prime agricole lungo la filiera. La natura essenzialmente agricola di tali soggetti richiede, ai sensi del reg. n. 1308/2013, una verifica della coerenza della composizione interna rispetto alle funzioni di mercato: in particolare, in riferimento alla possibile presenza di soci non produttori e al controllo democratico dell’organizzazione da parte dei soci produttori. Sotto questo profilo, la questione discussa dalla Corte di giustizia nel caso Saint-Luis Sucre focalizza l’attenzione sulle relazioni tra le organizzazioni di produttori e gli organismi sindacali, rappresentativi di categoria dei produttori agricoli. La questione va considerata, a parere dell’A., nella prospettiva dell’elaborazione di nuove strategie e strumenti di tutela effettiva della parte agricola nelle relazioni di filiera.
Within the current vision of the Common Agricultural Policy, built on the relationships between business operators of the food chain, producers organizations play a central role in market regulation, first of all, because they enhance the position of farmers in the agricultural products supply relationships. Since these subjects are established by the EU law as expression of farmers, Regulation No. 1308/13 requires a control on the consistency of the internal composition with the functions for the market: in particular with regard to the eligibility of non producers members and to the democratic accountability of the organization by producers members. In this respect, the issue discussed by the European Court of Justice in Saint-Luis Sucre case, focuses on the relationships between producers organizations and professional organizations representative of farmers. This issue shall be considered, according to the Author, in the perspective of the development of new strategies and legal tools for an effective protection of the agricultural part within the food chain relationships.
ALBERTO GERMANÒ
Sulla lettera f) del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 168/2017 [approfondisci]
Che valore hanno le (qui apparentemente superflue) parole «sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici» aggiunte alle parole «sono beni collettivi i corpi idrici» nella lett. f) del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 168/2017, espressioni perfettamente corrispondenti a quelle della precedente lett. d) per cui «sono beni collettivi le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati» a cui seguono le (qui rilevantissime, perché indicano una diversa categoria di usi civici) parole «sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici»? Ma se i «corpi idrici» altro non significano che le «acque fluenti» e se queste ora sono di proprietà dello Stato ai sensi dell’art. 144 del Codice dell’ambiente – cioè di un Codice che, in virtù del comma 3 dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 152/2006, non può essere abrogato se non espressamente per una sorta di clausola di resistenza rinforzata alle abrogazioni – come potrebbe la legge n. 168/2017 (che iscrive i corpi idrici tra il patrimonio collettivo) derogare alla norma che proclama la pubblicità di tutte le acque? Un Commissario agli usi civici afferma che una fonte sorgiva in un terreno di proprietà collettiva è un privato bene collettivo dell’entità che ha la proprietà del terreno su cui il «caput fluminis» insiste. Ma non tutti i commentatori di siffatta pronuncia ne accettano in pieno tale conclusione. Allora l’Autore resta dell’opinione che, come tra i beni collettivi rientrano, ai sensi della lett. d) del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 168/2017, gli usi civici (in senso stretto) che i residenti di un Comune esercitano su «terre di proprietà di soggetti pubblici o privati» cioè su terre altrui, così per la lett. f) del comma 1 dell’art. 3 della detta legge del 2017 rientrano tra i beni collettivi gli usi civici che i residenti del Comune esercitano su corpi idrici altrui, cioè dello Stato, corpi idrici (ovverosia, in sostanza, acque) che rimangono, per l’art. 144 del Codice ambientale, appunto beni dello Stato.
What is the meaning of the (here apparently unnecessary) wording «over which residents from the municipality or district shall exercise usi civici» on top of «water bodies are collective goods» in subparagraph (f), paragraph 1, Article 3 of Law No. 168/2017? In fact, this clearly matches subparagraph (d) above, which states that «lands owned by public or private entities are collective goods», and follows the wording (highly relevant here, for it refers to a different category of usi civici) «over which residents from the municipality or district shall exercise usi civici». But if «water bodies» mean nothing other than «flowing waters» and if these are now State property under Article 144 of the Environmental Code – a Code which, under Article 3 bis(3) of Legislative Decree No. 152/2006, cannot be repealed if not explicitly by some sort of reinforced provision – how could Law No. 168/2017 (which lists water bodies as part of the collective heritage) deviate from the rule whereby all waters are claimed to be public? A Commissioner for Usi Civici states that a spring in a collectively owned land is a private collective asset of the entity that has ownership over the land where the «caput fluminis» lies. But not all reviewers of such ruling fully accept this conclusion. So the author is still of the opinion that, just as collective property includes – under subparagraph (d), paragraph 1, article 3 of Law No. 168/2017 – the civic uses (in a strict sense) that the residents of a municipality exercise over «lands owned by public or private entities», i.e. on the lands of others, the same applies to subparagraph. (f), paragraph 1, Article 3 of the said 2017 law, including usi civici that residents of the municipality exercise over water bodies of others, i.e. the State; these water bodies (i.e., basically, waters) continue, in fact, to constitute State property under Article 144 of the Environmental Code.
ANTONIO JANNARELLI
Gli accordi di sostenibilità nell’art. 210 bis del reg. 1308 del 2013 ed il relativo progetto di comunicazione della Commissione europea [approfondisci]
Il saggio prospetta una prima interpretazione dell’art. 210bis del reg. 1308 del 2013 sugli accordi di sostenibilità nel settore agro-alimentare e agro-industriale alla luce della disciplina della concorrenza. A tale riguardo, contiene una sintetica illustrazione del contenuto dell’intera norma, nonché dell’incidenza che va riconosciuta alla sostenibilità anche nella lettura della competition law: di qui l’analisi critica dell’approccio ermeneutico adottato dalla Commissione nel progetto di comunicazione relativo all’applicazione dell’art. 210 bis.
The essay presents a first interpretation of art.210 bis of the Regulation No. 1308 of 2013 on vertical and horizontal initiatives for sustainability in the agri-food and agro-industrial sector in light of european competition law. In this regard, it contains a concise illustration of the content of the entire new rule, as well as the impact that must be recognized on sustainability also in the application of competition law: hence the critical analysis of the hermeneutic approach adopted by the Commission in the Draft guidelines on the application of a new EU antitrust exemption for sustainability agreements involving producers relating to application of the art. 210 bis.
MARIO MAURO
Prime riflessioni a margine della novella dell’art. 210 bis del reg. (UE) n. 1308/2013, introdotto dal reg. (UE) n. 2021/2117 [approfondisci]
Il nuovo art. 210 bis del reg. (UE) n. 1308/2013, rubricato iniziative orizzontali e verticali per la sostenibilità, introduce nuove eccezioni all’art. 101 TFUE, se funzionali al perseguimento di obiettivi di sostenibilità, senza che ciò significhi poter prescindere dagli obiettivi di politica agricola comune. La novella va inquadrata in un contesto in cui diversi sono i provvedimenti che, nel corso degli ultimi anni, si orientano verso una efficacia sempre più pervasiva del principio di sostenibilità, tale da incidere anche nel settore dell’agricoltura, non escluso il profilo della concorrenza. La norma costituisce così l’occasione per aprire una riflessione su quale sia il rapporto tra sostenibilità e obiettivi di politica agricola comune, e come esso si declini entro la cornice della regolamentazione concorrenziale.
The new Article 210a of Reg. (EU) No. 1308/2013, named horizontal and vertical initiatives for sustainability, introduces new exceptions to Article 101 TFEU, if they are functional to pursue sustainability objectives, without prejudice to common agricultural policy objectives. The reform should be set in a context where, over the past few years, several measures have moved toward increasingly and pervasive use of the sustainability principle, affecting the agricultural sector too, not excluding the competition law. The rule thus provides an opportunity to open up a discussion about the relationship between sustainability and common agricultural policy objectives, and how this relationship is declined within the framework of competition law.
DOMENICO MONCI
L’origine degli alimenti nel rapporto tra prodotto finito e ingrediente primario [approfondisci]
La tensione commerciale che caratterizza le dinamiche del mercato globale, pervaso dalle costanti aspirazioni di diverse, contrastanti esigenze, giustifica la considerevole sensibilità che il legislatore europeo e quello nazionale riconoscono al tema della tutela del consumatore di alimenti, in specie sotto il profilo dell’attenzione rivolta alla comunicazione commerciale degli operatori economici. La fornitura di informazioni al consumatore è il momento nel quale occorre garantire il giusto equilibrio tra l’esercizio di una concorrenza libera e leale tra operatori economici e il diritto all’esercizio di scelte consapevoli e discrezionalmente orientate alle proprie preferenze etiche ed estetiche da parte dei consumatori. L’etichetta è il mezzo d’elezione attraverso il quale, il sistema normativo ha inteso realizzare l’aspirazione di fornire al consumatore medio, il cui profilo è stato tipizzato anche da incisivi pronunciamenti della Corte di giustizia europea, tutte le informazioni necessarie, rese con un grado di chiarezza idoneo a consentirgli di compiere una scelta consapevole. L’ambiziosa linearità del modello informativo astratto, si complica particolarmente in relazione al tema dell’origine degli alimenti, e in particolare, nel suo delicato rapporto tra prodotto finito e ingrediente primario. Dietro una apparente essenzialità rinvenibile all’interno della cornice regolatoria delineata dal legislatore europeo, che poggia sull’obbligo di indicare in etichetta il Paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario quando questo non è lo stesso dell’alimento finito, si articola, in realtà, un delicato sistema di doveri per l’operatore del settore alimentare, in specie quando il tema interessa un prodotto trasformato, realizzato con diversi ingredienti e materie prime provenienti da diversi Paesi e/o continenti. In tali circostanze, gli stessi obblighi informativi legali, traslati sul fronte applicativo della prassi commerciale, potrebbero disvelare una loro attitudine a generare incertezza informativa, tradendo il valore della loro stessa esistenza.
The commercial tension, which characterizes the dynamics of the global market, permeated by constant aspirations of different and conflicting needs, justifies the considerable sensitivity that the European and national legislator acknowledges towards the issue of consumer protection in the food sector. Particularly, the European and national legislator has been mainly focused on the commercial communication of economic operators. The provision of information to consumers should guarantee the right balance between the exercise of free and fair competition among economic operators and the right to exercise informed and discretely oriented choices based on ethical and aesthetic preferences by consumers. The label is the preferred means through which the regulatory system has intended to fulfill the aspiration of providing the average consumer with all necessary information. Information have to be provided with a suitable level of clarity to enable them to make an informed choice. The complex interplay between the finished product and the primary ingredient adds further intricacies to the ambitious linearity of the abstract informational model, particularly concerning the issue of food origin. The European legislator requires that food labeling indicates the country of origin of the main ingredient, if it differs from that of the finished product. This regulation may seem simple, but for operators in the food industry that produce processed foods with ingredients sourced from different parts of the world, it becomes a complex system of obligations. In such circumstances, the same legal information obligations, translated into the practical application of business practices, could reveal their propensity to generate informational uncertainty, betraying the value of their own existence.
GIULIANA STRAMBI
Il vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato come «prodotto innovativo» per il mercato dell’Unione europea alla luce del regolamento (UE) 2021/2117 [approfondisci]
Nell’ambito della riforma della PAC del 2021, il regolamento (UE) n. 2021/2117 ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’OCM unica, consentendo la commercializzazione nell’Unione come «vino» di prodotti vitivinicoli che hanno subìto un trattamento di dealcolizzazione parziale o totale e che pertanto hanno un tenore alcolico inferiore a quello previsto dalla normativa UE o quasi nullo. L’articolo focalizza l’attenzione sulle novità introdotte in tema di autorizzazione della pratica enologica di dealcolizzazione parziale e totale del vino alla luce dell’evoluzione degli standards dell’OIV in materia. Analizza, poi, le ragioni e i limiti dell’estensione dell’autorizzazione della dealcolizzazione parziale per i vini con DOP o IGP, nonché delle regole di etichettatura del vino dealcolizzato e del vino parzialmente dealcolizzato. Infine, indaga sulle implicazioni che questa evoluzione normativa può avere sull’interpretazione della denominazione legale «vino» dettata dall’Unione europea e sulla tradizionale concezione del vino come bevanda alcolica.
As part of the 2021 CAP Reform, the Regulation (EU) No. 2021/2117 amended the Regulation (EU) No. 1308/2013 on the single CMO, allowing the marketing in the Union of grapevine products that have undergone a partial or total dealcoholisation treatment, as «wine». The new product has an alcohol content lower than that previously required by the EU legislation or almost zero. The article focuses on the novelties concerning the authorization of the oenological practices of partial and total dealcoholisation of wine in the light of the evolution of the OIV standards on the matter. It then analyses the reasons and limits of the extension of the authorization of partial dealcoholisation to PDO or PGI wines, as well as of the labelling rules for dealcoholized wine and partially dealcoholized wine. Finally, it reflects on the potential effects of this legislative evolution on the interpretation of the legal name «wine» and on the traditional idea of wine as an alcoholic beverage.
Indice Fascicolo 2 - 2023
FABRIZIO DI MARZIO
Il tramite necessario. Angelo Falzea e la prassi giuridica [approfondisci]
Il lavoro esamina l’idea di prassi nell’opera di Angelo Falzea. La particolarità della ricostruzione proposta dall’eminente Studioso è nell’offrire, attraverso la meditazione sulla prassi, un contributo significativo ad un’idea unitaria del diritto, in cui le diverse componenti della norma positiva e dell’agire giuridico socialmente rilevante non solo non si contrappongono ma si compongono in un disegno complessivo teso a fondare una teoria unitaria del diritto. La prassi è studiata nella tripartizione tra «prassi realizzativa, prassi genetica e prassi adeguatrice». In questo sforzo di classificazione si evidenziano i molteplici profili di un fenomeno complesso. L’esito è nella proposta ricostruttiva dell’attuazione del diritto attraverso l’individuazione della «norma causale» ossia della regola del caso concreto. Tale regola è proposta come il risultato delle reciproche influenze delle componenti di diritto positivo e di prassi sociale. L’insegnamento di Angelo Falzea è nel ripudio di ogni tentazione ideologica e di ogni soggettivismo, sicuramente dannosi per la doverosa tensione verso l’oggettività del diritto. Questo insegnamento ammonisce tuttavia anche a respingere le semplificazioni eccessive che, in nome di un diritto certo e prevedibile, ne limiterebbero l’immagine al solo diritto legislativo.
The work examines the idea of praxis in the work of Angelo Falzea. The particularity of the reconstruction proposed by the eminent Scholar is in offering, through meditation on praxis, a significant contribution to a unitary idea of law, in which the different components of the positive norm and of legal action are not opposed to each other but, on the contrary, are combined in an overall design aimed at founding a unitary theory of law. Praxis is studied in the tripartition between «prassi realizzativa, prassi genetica e prassi adeguatrice». In this classification effort, the multiple profiles of a complex phenomenon are highlighted. The outcome is in the reconstructive proposal of the implementation of law through the identification of the «norma causale» and thus of the rule of the concrete case law. This latter is proposed as the result of the reciprocal influences of the components of positive law and social practice. Angelo Falzea’s teaching is in the repudiation of every ideological temptation and every subjectivism, which are certainly detrimental to the necessary tension towards the objectivity of law. However, this teaching also warns against the excessive simplifications that, in the name of a certain and predictable law, would limit its image to legislative law alone.
STEFANO MASINI
Piattaforme online e motori di ricerca: sul rischio di accesso del consumatore digitale di alimenti [approfondisci]
Il diffuso impiego delle tecnologie digitali conduce ad un aumento degli scambi commerciali per via elettronica, impegnando il giurista ad adattare le regole sulla formazione del contratto a distanza. Specialmente il ricorso alle piattaforme online per organizzare la distribuzione di un ampio assortimento di prodotti alimentari e l’allestimento di siti web aziendali impongono maggiore cautela nella definizione degli strumenti per valutare la trasparenza dei contenuti rispetto alle informazioni veicolate dai tradizionali mezzi in ragione della rapidità con la quale si perfeziona la conclusione del rapporto. E la natura pericolosa della tecnica impiegata sollecita il ricorso a clausole rafforzate di conoscenza del programma contrattuale. La sequenza di norme continuamente rinnovate a livello europeo e recepite sul piano interno rende, peraltro, difficile offrire una descrizione esauriente se non rintracciare la stessa coerenza nello sviluppo di un disegno compiuto. Resta, invece, del tutto insufficiente il sistema di attribuzione della responsabilità in capo agli intermediari digitali per quanto riguarda i rischi inerenti alla circolazione dei prodotti anche con riguardo alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, se bene più recenti interventi normativi impongano un vero e proprio obbligo di diligente accertamento del comportamento commerciale dell’operatore da parte dei gatekeepers.
The widespread use of digital technologies leads to an increase in commercial exchanges by electronic means, committing the jurist to adapt the rules on the formation of the distance contract. The use of online platforms to organize the distribution of a wide assortment of food products and the setting up of corporate websites require greater caution in defining the tools to evaluate the transparency of the contents compared to the information conveyed by traditional means due to the speed with which the conclusion of the relationship is perfected. And the dangerous nature of the technique employed calls for the use of strengthened knowledge clauses of the contractual programme. Furthermore, the sequence of standards continually renewed at the European level and transposed domestically, makes it difficult to offer an exhaustive description other than to trace the same consistency in the development of an accomplished design. On the other hand, the system of attributing responsibility to digital intermediaries remains completely insufficient with regard to the risks inherent in the circulation of products, even with regard to the infringement of intellectual property rights, although more recent regulatory interventions impose a real obligation on gatekeepers to diligently ascertain the commercial behavior of the operator.
SONIA CARMIGNANI
PNRR e tutela della agrobiodiversità. L’esperienza dei giardini storici [approfondisci]
Il piano di intervento legato al PNRR, volto al recupero di parchi e giardini storici, dà vita ad una vasta e diffusa azione sul territorio nazionale, con lo scopo di restituire un rinnovato ruolo ai parchi e ai giardini storici come centri di «bellezza pubblica» e luoghi identitari per le comunità. I giardini storici tengono indissolubilmente legati valori storico-culturali e valori ambientali, fornendo una molteplicità di servizi ecosistemici al territorio che vanno oltre quelli tipicamente culturali-ricreativi e che interessano la conservazione della biodiversità, la produzione di ossigeno, la riduzione del livello di inquinamento ambientale e del rumore, la regolazione del microclima. Quando il giardino afferisce o è compreso nel più ampio contesto di una impresa agricola, il giardino storico costituisce una parte del paesaggio agrario. La sinergia tra attività agricola e tutela dei giardini storici si coglie non solo sul versante della incidenza dei vincoli insiti nella protezione dei giardini sull’attività primaria, laddove l’impresa agricola costituisca il formante di una porzione del paesaggio agrario ricadente nell’ambito della tutela, quanto e soprattutto sul versante dell’incidenza e del contributo che l’attività agricola può portare agli obiettivi di tutela. In altri termini, la considerazione dell’attività ex art. 2135 c.c. nel contesto del regime di protezione dei giardini di pregio ambientale, storico, culturale, paesaggistico, viene in evidenza in modo bidirezionale, considerando la conformazione che le esigenze di protezione ambientale possono produrre sull’attività agricola, quando all’azienda acceda un giardino storico, ma in particolar modo il ruolo che lo svolgimento dell’attività produttiva può svolgere come strumento funzionale agli obiettivi di conservazione.
The intervention plan linked to the PNRR, aimed at the recovery of historic parks and gardens, gives life to a vast and widespread action on the national territory, with the aim of restoring a renewed role to historic parks and gardens as centers of «public beauty» and places of identity for communities. Historic gardens keep historical-cultural values and environmental values inextricably linked, providing a multiplicity of ecosystem services to the territory that go beyond the typically cultural-recreational ones and which concern the conservation of biodiversity, the production of oxygen, the reduction of the level of environmental pollution and noise, the regulation of the microclimate. When the garden pertains to or is included in the broader context of an agricultural enterprise, the historic garden constitutes a part of the agricultural landscape. The synergy between agricultural activity and the protection of historic gardens can be seen not only in terms of the impact of the constraints inherent in the protection of gardens on the primary activity, where the agricultural enterprise constitutes the formant of a portion of the agricultural landscape falling within the ambit of protection, how much and above all on the side of the incidence and contribution that agricultural activity can bring to the objectives of protection. In other words, the consideration of the activity pursuant to Art. 2135 of the Civil Code in the context of the protection regime of gardens of environmental, historical, cultural, landscape value, it is highlighted in a bidirectional way, considering the conformation that the environmental protection needs can produce on agricultural activity, when the company has access to a historic garden, but in particular the role that the performance of the productive activity can play as a functional tool for the conservation objectives.
LUCIANA FULCINITI
Demanialità e appartenenza dei corpi idrici [approfondisci]
Il contributo esplora la condizione giuridica dei corpi idrici nel percorso verso la pubblicità, raggiunta con la dichiarazione di tutte le acque come demanio dello Stato. Analizza il regime dell’appartenenza pubblica necessaria del demanio idrico. Ne indaga il fondamento nella teoria generale del demanio pubblico e l’evoluzione nella funzione ambientale. Analizza la demanialità idrica in relazione a interpretazioni giurisprudenziali, teorie dottrinali e iniziative legislative che mirano a sostituirla con l’eterogenea categoria dei beni comuni. Sul sistema ordinamentale del demanio idrico, il contributo considera criticamente la fattispecie dei corpi idrici sui quali si esercitano usi civici, come deroga introdotta dalla legge sui domini collettivi.
The contribution explores the legal status of water bodies in the path towards publicity, achieved with the declaration of all waters as state property. It analyzes the regime of the necessary public belonging of the water domain. It investigates its foundation in the general theory of public property and its evolution in the environmental function. It analyzes state-owned water in relation to jurisprudential interpretations, doctrinal theories and legislative initiatives that aim to replace it with the heterogeneous category of common goods. On the legal system of water state property, the contribution critically considers the case of water bodies on which «usi civici» are exercised, as a derogation introduced by the law on «domini collettivi».
GIUSEPPE SPOTO
Greenwashing: tutela dei consumatori e responsabilità delle imprese [approfondisci]
Il saggio esamina le ipotesi di greenwashing e la proposta di direttiva sulla fondatezza e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite (direttiva Green Claims). L’autore richiama le regole generali per contrastare le pratiche commerciali sleali, ma sottolinea la necessità di rinvenire ulteriori strumenti che possano tutelare imprese e consumatori in modo più efficace. Una particolare attenzione è dedicata alle forme di soft law ad iniziativa dei privati, sebbene nessuno di questi strumenti possa essere considerato sufficiente e adeguato, senza l’approvazione di un quadro normativo uniforme e senza l’applicazione di sanzioni più rigorose. Le conseguenze e le sanzioni dovrebbero essere differenti a seconda degli obiettivi fraudolenti perseguiti dalle imprese, distinguendo tra pratiche illecite in violazione delle regole della concorrenza, rispetto alle frodi per ottenere finanziamenti pubblici o agevolazioni senza che ricorrano i presupposti effettivi per il loro riconoscimento.
The essay examines Greenwashing and the proposal for a Directive on Green Claims affecting commercial communications. The author believes that the general rules against unfair business practices can be invoked but emphasises the need to find additional instruments that can protect businesses and consumers more effectively. Particular attention is paid to private-initiative forms of soft law, although none of these remedies can be considered sufficient and adequate without the approval of a uniform regulatory framework and the application of stricter sanctions. Consequences and sanctions should differ depending on the fraudulent objectives pursued by the companies, distinguishing between unlawful practices in violation of competition rules and fraud to obtain public funding or subsidies without meeting the actual conditions for their recognition.
ANETA SUCHO? E ANDRII BILOCHENKO
Agricultural Activity in Ukraine and Poland after the Russian aggression against Ukraine. Chosen legal and economic aspects [approfondisci]
Lo scopo di questo articolo è innanzitutto quello di valutare l’impatto della guerra in Ucraina sulle attività agricole in questo Paese e in Polonia, e in secondo luogo di stabilire in che misura le norme giuridiche rispondono alle attuali sfide e necessità legate alle attività agricole in Polonia e Ucraina. Vengono analizzati i principali aspetti legali ed economici e vengono affrontati i principali problemi che i produttori agricoli di entrambi i Paesi hanno dovuto affrontare in questo periodo. La prima parte dell’articolo riguarda l’Ucraina, la seconda la Polonia. La guerra non solo ha causato enormi perdite di vite umane in Ucraina, ma ha anche portato a distruzioni catastrofiche e ridotto il potenziale dell’economia del Paese e del suo settore agricolo. Allo stesso tempo, fin dalle prime settimane di guerra, il Parlamento e il Governo ucraini hanno iniziato a sviluppare e adottare tempestivamente regolamenti volti a semplificare le attività agricole sotto la legge marziale. La guerra ha influenzato anche lo svolgimento delle attività agricole in altri Paesi, in particolare quelli confinanti con l’Ucraina (Polonia, Slovacchia, Romania). L’articolo sottolinea il coinvolgimento della Polonia nell’aiutare i cittadini ucraini emanando un atto separato sull’aiuto ai cittadini ucraini in relazione al conflitto armato sul territorio di questo Paese. Allo stesso tempo, per gli agricoltori polacchi sono emersi problemi legati ai maggiori costi di gestione delle attività agricole (carburante, energia, fertilizzanti). Attualmente, gli agricoltori polacchi hanno problemi con le vendite di prodotti agricoli (grano, colza, latte) e di animali da allevamento. I prezzi dei prodotti sono molto bassi. I prodotti agricoli provenienti dall’Ucraina e venduti in Polonia sono esenti da dazi doganali e i prezzi risultano essere vantaggiosi rispetto a quelli dei prodotti agricoli nazionali. Il legislatore polacco sta cercando di risolvere i problemi associati all’aggressione della Russia contro l’Ucraina sostenendo finanziariamente i produttori agricoli polacchi (alcuni provvedimenti sono presentati nell’articolo). Anche la Commissione europea ha dichiarato di voler fornire aiuti ai produttori agricoli. In conclusione, si può sostenere che l’aggressione della Russia all’Ucraina abbia avuto ripercussioni anche sulla sicurezza alimentare (in termini di quantità e qualità sanitaria) e sulla sicurezza energetica e ambientale.
The purpose of this article is firstly to assess the impact of the war in Ukraine on agricultural activities in this country and Poland, secondly to establish the extent to which legal norms meet the current challenges and needs related to agricultural activities in Poland and Ukraine. The key legal and economic aspects are investigated, and the main problems faced by agricultural producers in both countries during this period are addressed. The first part of the article deals with Ukraine, the second with Poland. The war has not only caused huge loss of life in Ukraine, but has also led to catastrophic destruction and reduced the potential of the Ukrainian economy and its agricultural sector. At the same time, from the first weeks of the war, the Ukrainian parliament and government began to develop and promptly adopt regulations aimed at simplifying agricultural activities under martial law. The war also affected the conduct of agricultural activities in other countries, particularly those bordering Ukraine (Poland, Slovakia, Romania). The article highlights Poland’s involvement in helping Ukrainian citizens by enacting a separate law Act of March 12, 2022 on assistance to citizens of Ukraine in connection with the armed conflict on the territory of that country. At the same time, there were problems for Polish farmers associated with the higher costs of running agricultural activities (fuel, energy, fertilisers). Currently, Polish farmers have problems with sales of agricultural products (wheat, rapeseed, milk), and farm animals. Prices of agricultural products are low. Agricultural products from Ukraine that have been sold in Poland are exempt from customs duties and the prices were attractive compared to prices of Polish domestic agricultural products. The Polish legislature is trying to solve the problems associated with Russia’s aggression against Ukraine by financially supporting Polish agricultural producers and some of regulations are presented in the article. Aid for agricultural producers was also declared by the European Commission. In conclusion, the authors stated that Russia’s aggression against Ukraine affected also the violation on food security and safety, as well as energy and environmental security.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
ALBERTO GERMANÒ
Necessità della previa sdemanializzazione rispetto all’atto di espropriazione per pubblica utilità degli usi civici gravanti su beni altrui [approfondisci]
Un decreto di espropriazione di beni altrui su cui una collettività ha diritto di usi civici è incapace di provocare l’estinzione degli usi civici se non è preceduta da un atto di loro formale sdemanializzazione.
A decree of expropriation of others assets over which a community has the right of «usi civici» is incapable of causing the extinction of «usi civici» if it is not preceded by an act of formal change of their use.
ALBERTO GERMANÒ
Sul rapporto tra la legge statale sui domini collettivi e le leggi regionali in contrasto [approfondisci]
Una legge regionale che è in contrasto con il principio fondamentale della personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali delle comunità titolari di beni collettivi è abrogata ad opera della legge n. 168/2017.
A regional law which is in contrast with the fundamental principle of the legal personality of private law of the exponential bodies of the communities owning collective goods is repealed by Law No 168/2017.
ALBERTO GERMANÒ
Sulla sentenza n. 119/2023 della Corte costituzionale [approfondisci]
L’Autore mette in evidenza tre aspetti della sentenza della Corte costituzionale: la dichiarazione di incostituzionalità del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 168/2017 che esclude l’alienabilità delle terre di soggetti privati sulle quali una collettività esercita usi civici in senso stretto non ancora liquidati; la perdurante vigenza della legge n. 1766/1927 sul riordinamento degli usi civici nel contesto della legge n. 168/2017 in materia di domini collettivi e quindi il loro coordinamento; la pregnanza del vincolo paesaggistico nell’individuazione della funzione sociale della proprietà dei beni civici per cui il privato proprietario di beni gravati da usi civici non ancora liquidati ha il dovere di non dividere il fondo, né di effettuare interventi o trasformazioni che pregiudichino la fruizione collettiva e che sottraggano il terreno alla sua destinazione a tutela anche del paesaggio.
The author highlights three aspects of the ruling of the Constitutional Court: declaration of unconstitutionality of Article 3 (3) of Law No. 168/2017 which excludes the alienability of the lands owned by private individuals and that are used by a community for «usi civici» strictly intended that have not yet been liquidated; continued validity of Law No. 1766/1927 on the reorganization of «usi civici» within the meaning of Law No. 168/2017 on the subject of «domini collettivi» and then their coordination; pregnant environmental legal constraints in identifying the social function of the ownership of civic assets whereby the private owner of a land subject to «usi civici» that has not yet been liquidated has the duty of not dividing it into smaller parcels or carrying out interventions or transformations that would jeopardize the community’s fruition of that land by putting it to uses that are different from its intended use, also with a view to protecting the landscape.
LETTURE
LORENZA PAOLONI
The United Nations’ Declaration on Peasants’ Rights (a cura di M. Alabrese, A. Bessa, M. Brunori, P.F. Giuggioli)
Indice Fascicolo 1 - 2023
FRANCESCO AVERSANO
Illeciti alimentari e conformazione alla disciplina eurounionale: modelli, casi e questioni [approfondisci]
L’inquadramento degli illeciti in una dimensione più ampia di quella domestica risulta imprescindibile per la salvaguardia del sistema agroalimentare e per il consolidamento della protezione di beni giuridici fondamentali, riferibili non solo al consumatore, alla sua salute e alle libere e consapevoli scelte di acquisto, ma anche agli operatori e alle imprese, per la difesa della leale concorrenza e del buon andamento del mercato. È auspicabile, allora, una crescente interazione tra disciplina interna ed European Food Law, a vantaggio delle risultanze ufficiali degli organi di controllo e a garanzia dell’efficacia degli esiti processuali.
A framework of crime in a wider dimension than domestic law is essential for the preservation of the agri-food system and for the consolidation of the protection of fundamental legal goods, not only relating to the consumer, its health and free and informed purchasing choices, but also to operators and companies, for the protection of fair competition and good market performance. It is desirable, then, a growing interaction between internal discipline and European Food Law, to the advantage of the official findings of the control bodies and to ensure the effectiveness of the procedural outcomes.
IRENE CANFORA
Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE [approfondisci]
Il saggio ripercorre la relazione tra le regole dell’organizzazione comune di mercato e le regole della concorrenza nel settore agricolo, al fine di inquadrare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE che si è occupata sino ad oggi di questioni relative a pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. Alla luce della recente giurisprudenza della Corte, si vuole delineare una traccia interpretativa per l’inquadramento delle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare di cui alla direttiva n. 633/2019, nel quadro normativo dell’Unione europea e nella sua attuazione a livello nazionale.
The paper examines the relationship between Common Market Organization rules and competition rules applicable to the agricultural sector, with the goal to frame the EU Court of Justice case law examined until now, concerning unfair trading practices in the agri-food chain. In the light of the recent case law of the Court of Justice, the Author aims to draw a line of interpretation of the unfair trading practices as regulated by the directive No 633/2029, in the framework of the European Union law and for the purpose of its implementation at national level.
SONIA CARMIGNANI
L’agricoltura resiliente e le sfide della giustizia climatica [approfondisci]
Il tema dei cambiamenti climatici è affrontato nell’ottica delle reciproche interazioni tra attività agricola e cambiamenti climatici, individuando i possibili interventi sul lato della domanda e sul lato dell’offerta per raggiungere l’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, da un lato, e della costruzione di un’agricoltura resiliente dall’altro. Nella prospettiva aperta dalla nuova PAC in ordine al ruolo dell’agricoltura nella lotta ai cambiamenti climatici, la valutazione dell’impatto delle politiche nazionali sul clima è valutata alla luce della giustiziabilità dei diritti che ai cambiamenti climatici sono connessi. La giustizia climatica sembra poter svolgere il ruolo di garanzia di un sistema di interventi climate smart in agricoltura, nel quale la necessità di delineare obiettivi sfidanti sia connesso all’esigenza di abilitare il comparto agricolo come attore protagonista nelle strategie climatiche di adattamento e di mitigazione nella prospettiva di dare piena attuazione alle finalità economiche e sociali dell’art. 39 TFUE.
The issue of climate change is addressed from the point of view of the reciprocal interactions between agricultural activity and climate change, identifying possible interventions on the demand side and on the supply side to achieve the goal of climate change mitigation, on the one hand, and of building resilient agriculture on the other. In the perspective opened up by the new CAP regarding the role of agriculture in the fight against climate change, the assessment of the impact of national policies on the climate is assessed in the light of the justification of the rights connected to climate change. Climate justice seems to be able to play the role of guaranteeing a system of climate smart interventions in agriculture, in which the need to outline challenging objectives is connected to the need to enable the agricultural sector as a leading player in climate adaptation and mitigation strategies in the prospect of fully implementing the economic and social purposes of art. 39 TFEU.
STEFANO MASINI
Le pratiche commerciali sleali nel d.lgs. n. 198 del 2021: tra implicazioni teoriche e prime applicazioni [approfondisci]
Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’art. 7 della l. 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, intende regolare le relazioni della filiera agroalimentare, rimuovendo l’esposizione del fornitore all’effettivo condizionamento della controparte che si trovi in posizione di supremazia. A più di un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo in essere, è possibile una prima valutazione in ordine alla sua applicazione condotta attraverso il numero limitato di denunce presentate dagli operatori a fronte di un’intensa attività di indagine e controllo disposta di propria iniziativa dall’Autorità designata.
Legislative Decree No. 198 of 8 November 2021 Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, intends to regulate relations in the agri-food supply chain, removing the supplier’s exposure to the effective conditioning of the counterparty that is in a position of supremacy. More than a year after the entry into force of the current legislative decree, it is possible to make an initial assessment of its implementation conducted through the limited number of complaints filed by operators in the face of intensive investigation and monitoring activities arranged on its own initiative by the designated Authority.
MARIO MAURO
Il benessere animale nel quadro delle fonti internazionali ed europee: una nozione dal contenuto complesso [approfondisci]
Il benessere animale è da tempo entrato nel linguaggio giuridico. Oltre all’art. 13 TFUE che richiede di tenere conto degli animali «in quanto esseri senzienti», l’espressione ritorna anche in diverse fonti derivate, sia di portata generale, sia di rilevanza settoriale, sia nella nuova PAC. Una relazione del Parlamento europeo di febbraio 2022 bolla però l’attuale legislazione come datata, derogatoria, eccezionale e vaga, senza garanzie specifiche e livelli di tutela minimi garantiti. Anche per questo motivo, e nel contesto della strategia sulla sostenibilità, dal 2017 sono stati pubblicati diversi atti di soft law, culminati nella strategia «From farm to fork» e nell’impegno riformatore ivi assunto dalla Commissione. Sorgono così nuove questioni e interrogativi. Nel dipanarsi tra interessi riconducibili al diritto alimentare e ambientale, il benessere animale sembra condizionare il funzionamento della filiera, incidendo sempre di più sulle regole di produzione primaria. Rileva poi una qualità, legata al processo produttivo e fondata su basi scientifiche, che possa essere percepita, senza dare spazio a pratiche sleali. Si richiedono dunque certezze, che l’attuale situazione normativa non sempre presenta e la cui assenza nel mercato globale potrebbe causare distorsioni, aprire i confini a importazioni di dubbia provenienza e confondere il consumatore, così rischiando di compromettere quegli obiettivi collettivi cui il benessere animale contribuisce.
Animal welfare has been introduced for some time in the legal language. In addition to the art. 13 TFEU, which requires to consider the animals as «sentient beings», the following expression also returns in various European legal sources, both of general application, sector regulation, and in the new CAP. However, a report by the European Parliament in February 2022 stigmatized the current legislation as outdated, waiver-clause, exceptional and vague, without specific guarantees and minimum warranty protection standards. Also, for this reason, in the context of the EU sustainable development strategy, since 2017 several soft law acts have been published, culminating in the From farm to fork strategy, where the Commission undertook a reforming commitment. Thus, new issues and challenges arise. Sorting out between the food and environmental law interests, animal welfare seems to influence the supply chain functioning, increasing her impact on the primary production rules. It also suggest a quality linked to the production process and built on scientific bases, which can be perceived by consumers, without giving room to unfair practices. Therefore, certainties are needed. The current regulatory situation does not always bring forward certainties, and its absence in the global market could cause distortions, open the borders to imports of dubious origin and confuse the consumer, thus risking to compromise those common goals to which animal welfare contributes.
VINCENZO PACILEO
Una modesta risposta sulla procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari [approfondisci]
Lo scritto intende offrire un punto di vista diverso rispetto alle critiche sollevate contro il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni alimentari introdotto dalla c.d. riforma «Cartabia». Se i critici pongono l’accento sul depotenziamento della tutela della sicurezza in campo alimentare che ne conseguirebbe, si osserva «modestamente» che ciò non pare del tutto esatto e che la riforma è in grado di portare dei vantaggi sul piano della regolarizzazione delle accertate non-conformità. Piuttosto, è vero che il testo di legge presenta dei difetti tecnici, che sarebbe opportuno fossero corretti. Ma lo scopo principale dello scritto resta quello di stimolare il dibattito su una innovazione comunque importante.
The script wants to give a different point of view in regard to the disapprovals of the reform «Cartabia» on food crimes. The critics underline the effect of weakening the protection of consumers. This does not seam completely exact, because the reform is able to bring some advantages, compelling to remedy the violation and reducing the trials. On the other hand, it is true that the legislative text has some technical flaws, to be possibly corrected. In any case, the main goal is to stimulate a debate upon this important innovation.
ROBERTO SAIJA
Diritto agrario e alimentare: alla ricerca di una nuova sistematicità? [approfondisci]
L’A. tenta una ricostruzione del diritto agrario sin dalle sue origini, quando la disciplina si separò formalmente dal diritto civile e da quello commerciale per poi confluire nell’alveo codicistico nel 1942. Dopo la fine del II conflitto mondiale, il diritto agrario, pur rimanendo ancora saldamente ancorato alle sue radici privatistiche, si sganciò dal codice civile nella c.d. età della decodificazione e di ciò sono tangibile testimonianza le diverse leggi sui contratti agrari fino alla l. 3 maggio 1982, n. 203. Il sistema delle fonti, tuttavia, è travolto e sconvolto dal passaggio dalla dimensione nazionale a quella sovranazionale con la comunitarizzazione fino alla globalizzazione. Gli anni Sessanta e Settanta del Novecento costituiscono un momento determinante fino agli anni Novanta con il Trattato di Marrakech e i suoi accordi. I mobili confini del diritto agrario hanno condotto a profondi e rivoluzionari cambiamenti che hanno spostato drasticamente il campo d’indagine della disciplina verso l’agroalimentare. Questo passaggio è delicato e, per quanto possa sembrare che la disciplina abbia subìto degli stravolgimenti, tanto da aver perso la sua originaria struttura, emerge che ha mantenuto una sua identità di fondo attraverso la teoria del ciclo biologico che ha accompagnato il diritto agrario sin dagli anni Settanta. Tale criterio rimane e riemerge ancor oggi nonostante la dimensione agroalimentare sia divenuta prevalente. Ciò risulta da alcuni provvedimenti del legislatore europeo che riportano e mantengono questa materia inglobata nel ciclo vitale e per quanto i cambiamenti possano apparire rivoluzionari e «disordinanti», si finisce sempre per recuperare una sorta di filo conduttore che accompagna le tante e variegate tappe attraverso cui si è evoluta una disciplina sempre soggetta ai progressi della scienza ai quali non può e non vuole restare insensibile. L’innovazione tecnologica, nell’agricoltura e nell’alimentazione, condiziona il diritto e lo trasforma. È così che assistiamo al passaggio dal diritto agrario al diritto agroalimentare, a un nuovo meccanismo delle fonti che diventa necessariamente multilivello ma la natura e la vita in tutte le forme (umana, animale e vegetale) rimangono il criterio guida al quale ancorarsi in questo continuo e incessante dibattersi tra tradizione e innovazione.
The Author attempts a reconstruction of agricultural law from its origins, when the discipline formally separated from civil and commercial law and then merged into the Code in 1942. After the end of the Second World War, agricultural law, although still remaining firmly anchored to its private roots, it disengaged itself from the civil code in the age of decoding and the various laws on agricultural contracts are tangible evidence of this up to the law of 3 May 1982, No. 203. The system of sources, however, is overwhelmed and upset by the transition from the national to the supranational dimension with communitarization up to globalization. The sixties and seventies of the twentieth century constitute a decisive moment until the nineties with the Treaty of Marrakech and its agreements. The mobile borders of agricultural law have led to profound and revolutionary changes that have drastically shifted the field of investigation of the discipline towards the agri-food sector. This passage is delicate and, although it may seem that the discipline has undergone upheavals, so much so that it has lost its original structure, it emerges that it has maintained its basic identity through the theory of the biological cycle which has accompanied agricultural law since the seventies. This criterion remains and still re-emerges today despite the fact that the agri-food dimension has become prevalent. This results from some provisions of the European legislator which bring back and keep this matter incorporated in the life cycle and however revolutionary and «disorderly» the changes may appear, we always end up recovering a sort of common thread that accompanies the many and varied stages through which a discipline has evolved which is always subject to the progress of science to which it cannot and does not want to remain insensitive. Technological innovation, in agriculture and food, conditions the law and transforms it. This is how we witness the transition from agricultural law to agri-food law, to a new mechanism of sources which necessarily becomes multilevel but nature and life in all forms (human, animal and vegetable) remain the guiding criterion to which to anchor in this continuous and incessant debate between tradition and innovation.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
NICOLETTA FERRUCCI
Osservazioni a margine di una pronuncia giurisprudenziale in materia di taglio di un albero in area urbana [approfondisci]
Traendo spunto da una recente pronuncia del giudice amministrativo, il lavoro pone a confronto il modus operandi adottato dalle amministrazioni comunali in materia di forestazione urbana, con l’evoluzione della ricerca scientifica, con il trend delle indicazioni di hard e soft law sul ruolo strategico e imprescindibile che la forestazione urbana riveste tra le Nature Based Solutions, e con una nuova consapevolezza collettiva del bisogno umano fondamentale di connessione con la natura urbana.
Drawing on a recent decision of the Administrative Court, the work compares the modus operandi adopted by the municipalities in the field of urban forestry with the evolution of scientific research, with the trend of hard and soft law indications on the strategic and essential role that urban forestation plays among Nature Based Solutions, and with a new collective awareness of the fundamental human need for connection with the urban nature.
2022
[approfondisci]Indice fascicolo 3 - 2022
NICOLETTA FERRUCCI
La trama giuridica della sostenibilità nel paradigma del bosco [approfondisci]
È possibile delineare i contorni di una sostenibilità paesaggistica accanto a quella ambientale sullo sfondo della moderna dimensione della sostenibilità? Il Diritto forestale italiano vigente mirato ad armonizzare le funzioni ambientali, economiche, sociali e paesaggistiche del bosco può rappresentare uno stimolante paradigma utile ad una riflessione in questa direzione.
Is it possible to outline a landscape sustainability next to an environmental sustinability on the background of the current aspect of sustainability? The current Italian Forestry Law aiming at balancing the ecological, environmental, economic and cultural values of the wood, may represents an emblematic and challenging paradigm for a reflection on this matter.
STEFANO FIORE
La tutela penale della concorrenza nel settore agroalimentare [approfondisci]
L’assenza di norme incriminatrici, generali o settoriali, della concorrenza sleale non è il solo indice della difficoltà di costruire la concorrenza come oggetto della tutela penale. La collocazione della tutela in ambito civilistico (art. 2598 c.c.) segnala infatti la necessità di utilizzare in questo settore strumenti più flessibili e adattabili di quanto il diritto penale consentirebbe. Dentro e fuori il codice penale esistono tuttavia numerose fattispecie incriminatrici che possono svolgere una funzione di tutela almeno indiretta dell’interesse ad una leale competizione sul mercato. Un ruolo centrale nell’analisi va ovviamente assegnato all’art. 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), la cui contrastata evoluzione giurisprudenziale appare indicativa della difficoltà del diritto penale a rapportarsi con la tutela della concorrenza. Alcune recenti novità legislative in materia di pratiche commerciali scorrette consentono infine una interessante verifica sul piano sistematico del ruolo del diritto penale in questo specifico ambito di tutela.
The absence of general or sectoral incriminating rules of unfair competition is not the only indication of the difficulty in building competition as an object of criminal protection. The placement of protection in the civil field (Art. 2598 of Civil Code) signals the need to use more flexible and adaptable instruments in this sector than criminal law would allow. However, within and outside the Penal Code there are numerous incriminating cases that can perform a function of at least indirect protection of the interest in fair competition on the market. A central role in the analysis must obviously be assigned to art. 513 bis of Penal Code (Unlawful competition with threats or violence), whose contrasted jurisprudential evolution appears indicative of the difficulty of criminal law in dealing with the protection of fair competition. Finally, some recent legislative innovations regarding unfair commercial practices allow an interesting systematic verification of the role of criminal law in this specific area of protection.
MARCO GJOMARKAJ
Alcuni spunti di riflessione sui recenti interventi normativi in materia di benessere e tutela degli animali [approfondisci]
Il presente saggio, alla luce dell’evoluzione del quadro normativo (internazionale, unionale e nazionale) a tutela del benessere degli animali – in grado di convogliare, oggi, nel medesimo intervento, componenti biocentriche e componenti antropocentriche – si occupa di analizzare l’impatto e le ricadute sull’ordinamento nazionale dell’emanazione della legge di revisione costituzionale n. 1/2022. Questa norma, oltre a modificare l’originario assetto dei valori fondamentali costituzionalmente garantiti, tra i quali, oggi, figurano anche la protezione dell’ambiente, dell’ecosistema, della biodiversità, del benessere degli animali e l’attenzione verso le generazioni future, introduce un’esplicita riserva di legge statale quanto ai modi e le forme di tutela degli animali all’art. 9 Cost., di cui verranno indagate la ratio e gli effetti.
This paper, on the basis of the evolution of the regulatory framework (international, Union and national) for the protection of animal welfare – able to convey, today, in the same intervention, biocentric components and anthropocentric components – deals with analyzing the impact and the repercussions on the national legal system of the issue of the constitutional revision Law n. 1/2022. This rule, in addition to modifying the original structure of the constitutionally guaranteed fundamental values, which today also includes the protection of the environment, ecosystem, biodiversity, animal welfare and attention to future generations, introduces an explicit reservation of state law as regards the ways and forms of animal protection to Article 9 of the Constitution, the rationale and effects of which will be investigated.
LUCA LEONE
Soft normativity for food sustainability: an EU Code of Conduct for businesses between collective responsibility and greenwashing [approfondisci]
Gli ultimi due decenni hanno conosciuto il proliferare, nell’ambito della governance alimentare europea, di strumenti di normatività informale volti a veicolare valori pubblici attraverso modalità non giuridicamente vincolanti. Il Codice di condotta adottato nel 2021 dalla Commissione europea come parte integrante della strategia Farm to Fork rappresenta il più recente esempio di questo trend normativo. Lo strumento, pur utile a rafforzare il ruolo svolto dal settore privato nella transizione verso un sistema alimentare sostenibile, desta non poche perplessità nel suo proporsi come agile forma di diritto. La convergenza di principi etici e giuridici indirizzata a promuovere pratiche commerciali responsabili nella filiera alimentare dell’Unione europea solleva, invero, problemi di legittimità e responsabilità collettiva nella mediazione tra valori non negoziabili e strategie di marketing. Il presente contributo illustra i meriti e le criticità del Codice di condotta europeo, e discute il ruolo normativo ad esso assegnato nell’ambito dell’approccio unionale alla sostenibilità alimentare. L’analisi evidenzia come la regolazione soft del Codice rischi di essere retoricamente legittimata in nome della sua presunta cifra democratica, pur mirando, di fatto, a sostenere e a consolidare primariamente il mercato.
In the last two decades, a plethora of instruments conveying informal normativity strongly entered the EU legislative process to define public values softly enforced for food policy purposes. The Code of Conduct for food business adopted in 2021 as an integral part of the ‘Farm to Fork’ strategy has been the last piece of this normative trend. It relies on some general principles to provide a basis for ethical-and evidence-based commitments aimed at achieving a sustainable food system, while guiding market actors in the pursuit of enhanced private-sector accountability. The convergence of ethical and legal principles raises, however, quarrels of legitimacy and responsibility in its mediating between non-negotiable values and marketing strategies. This contribution highlights the merits and pitfalls of the EU Code’s structure and discusses the normative role assigned to it within the EU approach to sustainability dynamics. The analysis posits that a risk remains for the EU Code to being rhetorically legitimized in the name of its purported democratic nature, while primarily pointing to support and strengthen EU food marketplace.
STEFANO MASINI E ALDO NATALINI
Dall’abrogazione (tentata) al meccanismo estintivo (attuato): storia (infelice) delle (redivive) contravvenzioni alimentari (o di quel che resta…) [approfondisci]
Il sistema di estinzione delle contravvenzioni alimentari introdotto dall’art. 70 del decreto legislativo n. 150/2022 (meglio noto come riforma «Cartabia») pone dei grossi dubbi sulla applicazione della speciale causa estintiva e sulla scelta politico-criminale compiuta dal legislatore in questo delicato settore. La principale questione interpretativa riguarda l’impossibilità (materiale o giuridica) di impartire prescrizioni rispetto a reati di danno o di pericolo concreto e attuale di danno per la sicurezza alimentare e la filiera agroalimentare, con particolare riguardo alla salute dei consumatori. Lo scritto, dopo aver ripercorso l’itinerario storico-legislativo che ha condotto all’odierna riforma legislativa, muove dalla casistica giurisprudenziale per dimostrare le difficoltà di applicare la procedura di regolarizzazione amministrativa in conformità alla legislazione di settore.
The extinction system for food crimes envisaged by article No. 70 of decree No. 150 of 2022 (best known as reform «Cartabia») raises serious doubts about the application of the special procedure and about the criminal political choice made by legislator in this delicate sector. The main question of interpretation concerns the impossibility (material or legal) to give prescription with reference to crimes has caused damage or actual damage or danger of damage to the food securety and to the agri-food chain with particular regard to the consumer health. The paper, after having retraced the historical-legal process which led to today’s legislative reform, moves from case law to prove the theoretical and practical difficulties to apply the procedure of administrative regularisation in accordance with sector legislation.
LUIGI RUSSO
Il (mutevole) rapporto tra le esigenze di sicurezza alimentare e la politica agricola comune [approfondisci]
Il lavoro esamina la disciplina della PAC come attuata dalle origini sino a quella del prossimo futuro (ossia quella di cui ai regolamenti destinati ad entrare in vigore per il periodo 2023-2027) per verificare quale è stato, nel corso dei sessant’anni di sua attuazione, il rapporto tra essa e l’esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, conformemente a quanto previsto dall’art. 39, par. 1, lett. d), TFUE. Ed infatti, da qualche tempo la tematica della sicurezza alimentare sembra essere tornata al centro dell’attenzione in ambito politico ed economico, a causa delle difficoltà di approvvigionamento alimentare causate dal diffondersi del COVID-19, da eventi climatici avversi e, da ultimo, dal conflitto in ucraina, che vede coinvolti due Stati tra i più grandi produttori mondiali di grano, di mais e di oli vegetali. In una prima fase, il quadro normativo della PAC incentivante ha costituito l’humus ideale per ottenere un formidabile incremento delle produzioni e della produttività nel settore primario, in ciò aiutato anche dagli sviluppi tecnologici e dalla modernizzazione del settore. Con la prima, vera riforma della PAC del 2003 si è, invece, abbandonato, quasi totalmente, il previgente sistema di aiuti accoppiati alla produzione per sostituirlo con l’erogazione di aiuti disaccoppiati, e dunque erogati ai beneficiari indipendentemente dalle quantità ottenute e, prima ancora, indipendentemente dallo svolgimento di una attività produttiva agricola. Il passaggio dai sostegni accoppiati alla produzione ad aiuti disaccoppiati ha comportato, tra l’altro, una assai minore attenzione agli aspetti quantitativi. L’assetto degli aiuti erogati nell’ambito della PAC non è mutato, nella sostanza, con i regolamenti operanti per il periodo 2014-2022 dai quali, anzi, emerge con evidenza una maggior attenzione sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale dell’attività produttiva agricola, tanto che tra gli obiettivi delineati dal reg. UE n. 1305/2013 per le misure di sviluppo rurale non viene più neppure menzionata la food security. Con la PAC del 2023-2027 la sicurezza alimentare ricompare tra gli obiettivi espressi dell’azione dell’UE nel settore ma, a ben vedere, tale enunciazione sembra più una affermazione di principio che un obiettivo concretamente ed efficacemente perseguito, posto che, ancora una volta, il legislatore unionale sembra privilegiare i profili di pur necessaria sostenibilità ambientale dell’attività agricola, a scapito di quelli concernenti la sostenibilità economica delle imprese del settore e di quelli legati alla food security.
The paper examines the discipline of the CAP as implemented from its origins up to that of the near future (i.e., that referred to in the regulations set to come into force for the period 2023-2027) in order to ascertain what has been, over the sixty years of its implementation, the relationship between it and the need to ensure the security of food supplies, in accordance with the provisions of Article 39 (1) (d) TFEU. And in fact, for some time now, the issue of food security seems to have returned to the center of attention in the political and economic spheres, due to food supply difficulties caused by the spread of COVID-19, adverse climatic events and, most recently, the conflict in Ukraine involving two of the world’s largest wheat, corn and vegetable oil producing states. In the first phase, the incentive CAP regulatory framework provided the ideal humus for achieving a formidable increase in production and productivity in the primary sector, in this helped also by technological developments and modernization of the sector. With the first, real reform of the CAP in 2003, however, the former system of production-coupled supports was abandoned, almost totally, and replaced by the provision of decoupled supports, and thus disbursed to beneficiaries regardless of the quantities obtained and, before that, regardless of the performance of an agricultural production activity. The shift from production-coupled supports to decoupled aids has meant, among other things, much less attention to quantitative aspects. The structure of aid provided under the CAP has not changed in substance with the regulations operating for the 2014-2022 period from which, on the contrary, a greater focus on the need to reduce the environmental impact of agricultural production activity is evident, so much so that among the objectives outlined in EU Reg. No. 1305/2013 for rural development measures, food security is no longer even mentioned. With the CAP of 2023-2027, food security reappears among the expressed objectives of EU action in the sector but, on closer inspection, this statement seems more a statement of principle than an objective that is concretely and effectively pursued, since, once again, the EU legislator seems to privilege the profiles of the albeit necessary environmental sustainability of agricultural activity, to the detriment of those concerning the economic sustainability of businesses in the sector and those related to food security.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
SONIA CARMIGNANI
Società semplice e agrarietà tra eteroamministrazione e composizione sociale [approfondisci]
La disciplina della società in agricoltura è affrontata con specifico riguardo alla società agricola semplice alla luce delle relazioni tra disposizioni della legge speciale, riforma del diritto societario e interpretazioni giurisprudenziali. L’attenzione è rivolta in particolare al tema della amministrazione della società e della composizione della società agricola semplice.
The company law in agriculture is addressed with specific regard to the agricultural partnership in the light of the relationships between the provisions of the special law, reform of company law and jurisprudential interpretations. Particular attention is paid to the issue of the administration and composition of the agricultural partnership.
ALBERTO GERMANÒ
Imprese esercenti attività agricole connesse e aiuti di Stato [approfondisci]
La sentenza ribadisce che sono aiuti di Stato vietati dall’art. 107 del TFUE i vantaggi che sono concessi con risorse pubbliche; che danno una posizione di vantaggio a taluni imprenditori o per talune produzioni; che incidono sul mercato comunitario. Conferma che il termine prescrizionale decennale disposto dall’art. 17, reg. n. 2015/1589 è interrotto dalla richiesta di informazioni della Commissione allo Stato concedente e che in mancanza di rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti non può essere invocato il legittimo affidamento sull’ammissibilità degli aiuti che non vengono immediatamente contestati.
The ruling confirms that the following are State aids prohibited under Article 107 TFEU: benefits which are granted through public resources; benefits favouring certain businesses or the manufacture of certain goods; and benefits affecting the EU market. It also confirms that the ten-year statute of limitations provided for by Article 17, Reg. 2015/1589 is suspended by the Commission’s request for information from the granting State and that lacking clear, unconditional and consistent evidence, legitimate expectations on the admissibility of aid which is not immediately challenged cannot be claimed.
TESTIMONIANZE
LEONARDO PASTORINO
La missione del diritto agrario e le sfide dell’umanità
Indice fascicolo 2 - 2022
FABRIZIO DI MARZIO E STEFANO MASINI
In ricordo di Paolo Grossi
MARIA AMBROSIO
Il recepimento della direttiva Insolvency: verso nuove forme di prevenzione ed assistenza delle imprese agricole in crisi [approfondisci]
La genesi e l’evoluzione normativa del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) volto da ultimo al recepimento della direttiva Insolvency (n. 2019/1023) sollevano questioni relative a svariati profili, tra i quali la peculiarità del sistema italiano, che mantiene ancora una differenza disciplinare all’interno del diritto della crisi tra impresa commerciale e impresa agricola. Nel CCII, per il quale parrebbe prossimo il completamento dell’entrata in vigore in sostituzione della legge fallimentare, trova ampio spazio il tema del recupero e del salvataggio delle imprese grazie a un sistema di assetti organizzativi con conseguente allerta tempestiva, che risulta non agevole per le micro e piccole imprese agricole. Spunti di riflessione al riguardo provengono dal consolidato sistema di Early Warning attuato in Danimarca. Nonostante siano state recepite numerose indicazioni provenienti dal legislatore europeo, permangono per il settore agroindustriale criticità e lacune.
The genesis and the normative evolution of the Italian Insolvency Code aimed at transposing Directive (UE) 2019/1023 raise new issues, such as the disciplinary differences between commercial and agricultural enterprise. The Italian Insolvency Law contains early warning procedures for identifying and remediating early-stage crises which may play a very significant role for micro and small agricultural enterprises. The consolidated experience of Early Warning Denmark may give useful suggestions for the Italian system. Although many procedures and tools suggested by the European legislators have been adopted, the measures regarding the agroindustrial sector still present problems and gaps.
WANDA D’AVANZO
Smart Farming. La quarta rivoluzione industriale e la digitalizzazione del settore agricolo [approfondisci]
Le tecnologie intelligenti sono in grado di supportare l’automazione delle linee di produzione, il controllo qualità dei prodotti, il funzionamento delle macchine e dei robot che le gestiscono, favorendo una programmazione dettagliata e una gestione ottimizzata di ogni fase del ciclo produttivo. Grazie all’interconnessione di apparecchiature tecnologiche e alla condivisione di informazioni, in tempo reale, queste applicazioni sono in grado di raccogliere dati sulla soddisfazione del prodotto e sul suo utilizzo da parte del consumatore finale. E queste funzioni rappresentano una risorsa fondamentale per le aziende che possono finalizzare le proprie prestazioni a soddisfare le aspettative del target di utenti di riferimento, aumentando la competitività. Tra i settori che potrebbero beneficiare maggiormente di questa rivoluzione digitale, il settore agroalimentare rappresenta un esempio molto importante, a fronte dei profondi processi di cambiamento che lo hanno interessato negli ultimi anni. L’introduzione dell’Internet delle cose nel mondo agricolo, che diventa Internet of Farming, potrebbe supportare i processi produttivi in vari modi, sfruttando le potenzialità dell’Internet delle cose e dell’analisi dei big data per raggiungere un migliore livello di sfruttamento delle risorse naturali e con minor impatto ambientale.
Smart technologies are able to support the automation of production lines, product quality control, the operation of the machines and robots that manage them, favoring detailed programming and optimized management of each phase of the production cycle. Thanks to the interconnection of technological equipment and the sharing of information, in real time, these applications are able to collect data on the satisfaction of the product and its use by the end consumer. And these functions represent a fundamental resource for companies that can finalize their performances to satisfy the expectations of the target users of reference, increasing competitiveness. Among the sectors that could benefit most from this digital revolution, the agri-food sector represents a very important example, in the face of the deep processes of change that have affected it in recent years. The introduction of the Internet of Things in the agricultural world, that become Internet of Farming, could support production processes in various ways, exploiting the potential of the Internet of Things and big data analysis to achieve a better level of exploitation of natural resources and with less environmental impact.
MARISARIA MAUGERI
Presunzione di dipendenza e applicazione della disciplina sull’abuso di dipendenza economica nella filiera agroalimentare [approfondisci]
Nel lavoro ci si interroga sulla possibilità o meno di applicare, dopo l’emanazione del d.lgs. n. 198/2021, la disciplina sull’abuso di dipendenza economica, contenuta nell’art. 9 della legge n. 192/1998, all’interno della filiera agricola e alimentare. L’autrice ritiene che, nonostante alcuni indici contenuti nel d.lgs. n. 198/2021 inducano a escludere ciò, si debba ritenere che l’art. 9 continui a essere applicabile. L’autrice ritiene, altresì, che nella filiera agricola e alimentare, possa operare la presunzione di dipendenza prevista dal comma 3 bis dell’art. 9 della legge n. 192/1998.
The paper questions the possibility of applying, after the issue of Legislative Decree no. 198/2021, the discipline on the abuse of economic dependence, provided for by art. 9 of Law no. 192/1998, in the agricultural and food supply chain. The author believes that, despite some indexes contained in Legislative Decree no. 198/2021 lead to exclude this, it must be considered that art. 9 continues to apply. The author also believes that in the agricultural and food supply chain, the legal presumption of dependence, provided for by paragraph 3 bis of art. 9 of the Law no. 192/1998, is applicable.
ANTONIO PAOLO SEMINARA
La disciplina delle piattaforme digitali di ristorazione: profili di tutela tra corretta informazione e privacy [approfondisci]
L’articolo indaga gli istituti e le problematiche giuridiche riguardanti il fenomeno delle piattaforme digitali di ristorazione, proponendo un’analisi di tutte le discipline implicate, sia riguardo ai rapporti P2B, sia ai rapporti B2C, con un focus particolare sulla tutela della scelta alimentare e sulla protezione dei dati personali immessi dagli utenti. Mentre il rapporto P2B coinvolge la normativa di cui al reg. UE n. 1150/2019, a cui si aggiunge la precedente dir. n. 2000/31/CE sul commercio elettronico, per il rapporto B2C l’attenzione è volta alla disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla dir. n. 2005/29/CE e, in particolare, al reg. UE n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari. Sul versante della privacy, viene in rilievo il GDPR (reg. UE n. 679/2016) che ha introdotto importanti novità sulla protezione dei dati personali nell’ambiente digitale, con una particolare sensibilità verso l’attività di profilazione realizzata dai cybermediary, diffusa anche nelle piattaforme digitali del contesto alimentare.
The article investigates the legal issues concerning a digital platform for restaurants, proposing an analysis of all the disciplines involved, both regarding P2B and B2C relationships, with a focus on the protection of food choice and of personal data entered by users. While the P2B report involves the legislation under the Reg. EU no. 1150/2019, to which is added the previous Dir. no. 2000/31/EC on electronic commerce; for the B2C relationship, attention is paid to the regulation on unfair commercial practices referred to Dir. no. 2005/29/EC and, specifically, to Reg. EU no. 1169/2011 on food information. As regards privacy, the GDPR (Reg. EU no. 679/2016) and the protection of personal data in the digital environment are analyzed, with a focus on the profiling activity carried out by cybermediaries, which is also widespread among food-based digital platforms.
GIUSEPPE SPOTO
Le interferenze di competenze tra l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato [approfondisci]
Il saggio esamina l’attuazione della direttiva europea sulle pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare con particolare riferimento alla funzione dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). In Italia, la funzione di «autorità di contrasto» ed il compito di sanzionare le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare sono state affidate all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Ministero dell’agricoltura, ma il legislatore non ha formalmente escluso la competenza dell’Autorità antitrust in materia. Per evitare il problema di interferenze di competenze tra autorità, sarebbe stato preferibile se il legislatore avesse adottato una regola più chiara, ma ogni problema di interpretazione può essere superato, adattando i princìpi della giurisprudenza amministrativa in tema di riparto di competenze tra le autorità indipendenti e ricordando gli obiettivi fissati dalle normative. Secondo il ragionamento svolto, non esiste antagonismo e contrapposizione tra le autorità che sono chiamate a cooperare reciprocamente in funzione degli interessi da proteggere. La tutela del consumatore rimane sotto la protezione dell’Autorità antitrust, mentre la repressione delle pratiche commerciali scorrette tra imprese della filiera agroalimentare è affidata all’ICQRF.
The essay examines the implementation of the European Directive on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain with particular reference to the function of the Central Inspectorate for the protection of quality and fraud repression of agri-food products (ICQRF). In Italy, the function of enforcement authority and the task of sanctioning unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain have been entrusted to the ICQRF of the Ministry of Agriculture, but the legislator has not formally excluded the competence of the Antitrust Authority. In order to avoid the problem of interference between authorities, it would have been preferable if the legislator had adopted a clearer rule, but any problem of interpretation can be overcome by adapting the principles of administrative jurisprudence on the allocation of competences between independent authorities and by recalling the objectives set by the regulations. There is no antagonism or opposition between the authorities, which are called upon to cooperate with each other according to the interests to be protected. According to what is written, consumer protection remains under the control of the Antitrust Authority, while the repression of unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain is entrusted to the ICQRF.
MONICA TORTORELLI
Simbolismo repressivo e strategie premiali nella riforma del reato di incendio boschivo [approfondisci]
La novella legislativa di cui al d.l. 8 settembre 2021, successivamente convertito in legge n. 155 dell’8 novembre 2021, ha rinnovato l’approccio generale in materia di incendi boschivi, intervenendovi oltre che con un rafforzamento delle misure di prevenzione e lotta attiva già previste dalla legge quadro n. 353 del 2000, attraverso una modifica della fattispecie penale ex art. 423 bis c.p. L’obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di introdurre correttivi «emergenziali» volti a contrastare, nella maniera più efficace possibile, la recrudescenza e la gravità dei fenomeni incendiari che hanno flagellato, anche nell’estate passata, la nostra penisola. La riforma, più in particolare, ha modificato la fattispecie delittuosa dell’incendio boschivo introducendo importanti novità nella disciplina del regime circostanziale, in tema di pene accessorie, ma anche dal punto di vista delle misure premiali e più in generale della «non punibilità». Il presente lavoro analizza i contenuti del recente intervento legislativo, valorizzandone i punti di forza, ma evidenziandone al tempo stesso distonie ed aspetti critici.
The legislative reform referred to in the decree-law of 8 September 2021, subsequently converted into law no. 155 of 8 November 2021, renewed the general approach to forest fires, intervening in it as well as strengthening the prevention and active control measures already provided for by framework law no. 353 of 2000, through a modification of the criminal offense pursuant to art. 423 bis c.p. The objective pursued by the legislator was to introduce «emergency» corrective measures aimed at countering, in the most effective way possible, the resurgence and severity of the incendiary phenomena that have plagued our peninsula, even in the summer of 2021. The reform, more specifically, has modified the criminal offense of the forest fire by introducing important innovations in the circumstantial regime, in terms of ancillary penalties, but also from the point of view of reward measures and more general of «non-punishment». This work analyzes the contents of the recent legislative intervention, enhancing its strengths but at the same time highlighting its distortions and critical aspects.
SONIA CARMIGNANI
Concordato preventivo e imprenditore agricolo [approfondisci]
Il tema affrontato riguarda da un lato l’esonero dal fallimento dell’imprenditore agricolo e, dunque, gli indici della relativa qualificazione giuridica e, dall’altro, la questione, in una prospettiva de iure condendo, della applicabilità all’imprenditore agricolo del concordato preventivo e, in particolare, del concordato prenotativo.
The topic dealt with concerns on the one hand the exemption from bankruptcy of the agricultural entrepreneur and, therefore, the indices of the relative legal qualification and, on the other hand, the question, in a de iure condendo perspective, of the applicability to the agricultural entrepreneur of the concordat estimate and, in particular, of the booking agreement.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
Indice fascicolo 1 - 2022
BEATRICE LA PORTA
Riflessioni a margine di un’ordinanza cautelare del Tribunale di Gorizia: greenwashing tra concorrenza sleale e diritto del consumatore all’acquisto consapevole [approfondisci]
La pubblicizzazione sul mercato di prodotti ecofriendly non di rado si è rivelata frutto di pratiche scorrette di c.d. greenwashing, ciò consistendo in ipotesi di concorrenza sleale capaci di alterare i sistemi competitivi del libero mercato e ledere il diritto dei consumatori all’acquisto consapevole. Simili atti sono oggi sanzionati ricorrendo ad inibitorie e a comunicazioni pubbliche in cui l’impresa infedele informa i propri consumatori circa l’ingannevolezza dei comportamenti posti in essere. In tale ambito, che in primo luogo interessa il settore agroalimentare, si inserisce l’ordinanza cautelare del 26 novembre 2021 del Tribunale di Gorizia. Il ricorso a disciplinari di produzione basati su dati scientifici e frutto di accordi interprofessionali che permettano di inserire una regolazione privatistica all’interno di un più ampio quadro pubblicistico, potrebbe rivelarsi idoneo a contrastare simili pratiche sleali, specie se rafforzato dall’uso di sistemi e strumenti innovativi quali la blockchain.
The advertising for eco-friendly products has not infrequently turned out to greenwashing. It is a hypothesis of unfair competition capable of altering the systems of the free market and misleading the consumers. Similar practices are sanctioned. In this context, which primarily concerns the agri-food sector, the provision of November 26, 2021, of the Court of Gorizia enters. The use of production regulations that result from the intersection between private agreements and public regulations and are based on technical-scientific data, could limit unfair practices also by means of innovative IT systems and tools, such as the blockchain.
STEFANO MASINI
«Transizione ecologica» dell’agricoltura [approfondisci]
Già sul finire del ’900, ai fini dell’adeguata sistemazione della materia, si era messa in luce l’importanza del collegamento della produzione con l’uso delle risorse naturali attraverso la riscoperta della dimensione territoriale dell’agricoltura. I primi segnali di inquinamento pretendevano un bilanciamento tra i benefici dello sviluppo e la soglia accettabile del rischio; mentre l’evoluzione delle traiettorie di riforma della politica agricola comune presentavano i vantaggi di una prospettiva geografica dello sviluppo delle attività di coltivazione e di allevamento riconducibili alla attrattività ambientale e paesaggistica dei luoghi e alla promozione delle identità locali. In questa prospettiva, l’evoluzione delle categorie giuridiche matura insieme ai presupposti culturali di un modello aziendale destinato ad affermarsi definitivamente a livello europeo riconoscendo il legame inscindibile tra qualità della vita, equilibrio degli ecosistemi e investimenti produttivi. Il discorso economico è chiamato, infatti, ad integrare natura e società mediante l’attuazione di una serie di provvedimenti che descrivono, da ultimo, la transizione ecologica destinata ad impegnare l’agricoltura in un processo di riduzione delle emissioni e di sviluppo delle energie rinnovabili, che apre a iniziative di sviluppo circolare nelle applicazioni zootecniche e della silvicoltura. Occorre, tuttavia, prendere in considerazione il tema che deriva dalla fallace preoccupazione per gli impatti che possono essere generati dalla filiera di produzione agroalimentare rispetto a cui la proposta alternativa messa in campo prevede un cambiamento radicale delle abitudini di consumo. Tuttavia, l’ingegnerizzazione dell’organizzazione della produzione, recidendo ogni legame con il ciclo biologico, si pone fuori dalla caratterizzazione dello stesso esercizio delle attività definite agricole dall’art. 2135 c.c.
Already at the end of the 20th century, for an adequate refinement of the matter, the importance of linking production with the use of natural resources through the rediscovery of the territorial dimension of agriculture was highlighted. The first signs of pollution demanded a balance between the benefits of development and the acceptable threshold of risk; while the evolution of the trajectories of reform of the common agricultural policy presented the advantages of a geographical perspective of the development of cultivation and breeding activities linked to the environmental and landscape attractiveness of places and the promotion of local identities. In this perspective, the evolution of legal categories matures together with the cultural assumptions of a business model destined to establish itself definitively at European level by recognizing the inseparable link between quality of life, balance of ecosystems and productive investments. The economic aspect is called, in fact, to integrate nature and society through the implementation of a series of measures that describe, most recently, the ecological transition destined to commit agriculture in a process of emission reduction and development of renewable energies, which opens up circular development initiatives in livestock and forestry applications. It is necessary, however, to take into account the issue that arises from the fallacious concern about the impacts that may be generated by the agro-food production chain with respect to which the alternative proposal fielded involves a radical change in consumption habits. However, the engineering of the organization of production, severing any link with the biological cycle, is outside the characterization of the same exercise of activities defined as agricultural by Art. 2135 civil code.
OSSERVATORIO REGIONALE
CLELIA LOSAVIO E AIDA GIULIA ARABIA
La promozione e la valorizzazione del turismo rurale nella legislazione regionale [approfondisci]
Il presente lavoro, dopo essersi soffermato sulla definizione e sulla genesi dell’espressione «turismo rurale», esplora gli spazi di manovra e il ruolo finora ricoperto dal legislatore regionale in tale ambito. Il turismo rurale, infatti, oltre ad essere disciplinato in leggi regionali ad hoc, analizzate nella prima parte del lavoro, trova spazi di regolamentazione anche in leggi ascrivibili ad altre materie di intervento regionale, oggetto della seconda parte dell’articolo. La molteplicità delle iniziative legislative prese in considerazione dimostra l’impegno delle Regioni nel valorizzare le proprie specificità territoriali, comprensive delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e storiche di un luogo, e le potenzialità legate a un settore che, soprattutto negli ultimi anni, ha favorito la riscoperta e la fruizione di luoghi rurali, lontani dai centri urbani e dalle grandi folle.
This paper, after focusing on the definition and genesis of the expression «rural tourism», explores the manoeuvring space and the role played so far by the regional legislator in this area. In fact, rural tourism, in addition to being governed by ad hoc regional laws – analyzed in the first part of the paper – also finds regulatory spaces in laws attributable to other matters of regional intervention – examined in the second part of the article. The multiplicity of legislative initiatives taken into consideration demonstrates the commitment of the Regions in enhancing their own territorial specificities, including the environmental, landscape, cultural and historical resources of a place, and the potentialities linked to a sector that, especially in recent years, has favored the rediscovery and use of rural places, far from urban centers and large crowds.
ALBERTO GERMANÒ
Domini collettivi: il «ruolo sussidiario» del Comune nella gestione del patrimonio collettivo quando la comunità titolare non è costituita in ente [approfondisci]
Ancorché aspetto non rilevante ai fini della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge della Regione Abruzzo – dato che la pronuncia di incostituzionalità è dipesa dall’affermazione della competenza esclusiva statale nella materia dei domini collettivi in quanto «ordinamento civile» – la Corte, con una sentenza in gran parte di alto valore didascalico, ha affermato che il Comune, quando la collettività titolare di proprietà collettive non è costituita in ente di diritto privato, ha un ruolo sussidiario nella gestione del patrimonio collettivo e deve garantirne l’uso riservato ai membri della collettività.
Although this aspect was not relevant to the declaration of the constitutional illegitimacy of a law of the Abruzzo Regional Government – given that the conclusion of unconstitutionality depended on the claim that the State had exclusive jurisdiction over collective domains as a matter of «civil law» – the Court, in a mainly instructive judgment, stated that when the community owning collective property is not constituted as a private law entity, the Municipal Government has a secondary role in the management of such collective property and must guarantee its exclusive use by the members of the community.
Atti del Convegno Le frodi agroalimentari, riciclaggio e fondi europei Firenze 15-16 ottobre 2021
SIRO DE FLAMMINEIS E STEFANO MASINI
Prefazione
ALBERTO GARGANI
I delitti contro la salute pubblica e le contravvenzioni alimentari [approfondisci]
Nello scritto si analizzano in chiave sistematico-evolutiva gli illeciti penali agroalimentari suscettibili di incidere sulla salute individuale e collettiva: da un lato, le fattispecie delittuose contro la salute pubblica previsti nel codice penale, dall’altro, le ipotesi contravvenzionali contemplate nella legge n. 283/1962.
This contribution analyses, in an evolutionary and systemic view, the offences affecting individual and public health in the food sector: on the one hand, the crimes against public health referred to in the Penal Code; on the other hand, the offences provided for by Law n. 283/1962.
FRANCESCO CINGARI
La contraffazione dei marchi industriali e agroalimentari (DOP e IGP) [approfondisci]
Il contributo analizza l’apparato di tutela penale a contrasto della falsificazione dei segni/indicazioni/denominazioni dei prodotti alimentari, funzionali ad «informare» i consumatori sulla provenienza aziendale del prodotto oppure sulle caratteristiche qualitative legate alla origine territoriale di provenienza, mettendo in evidenza alcune delle principali criticità.
The contribution analyzes the criminal protection apparatus in contrast to the «signs»’s falsifications of food products functional to «inform» consumers about the product’s company origin as well as the qualitative characteristics linked to the territorial origin, highlighting, in this way, some of the main criticalities.
CLAUDIO ROSSI, GABRIELLA TAMASI E AGNESE MAGNANI
La determinazione dell’origine geografica degli alimenti. Un nuovo strumento scientifico a disposizione per i processi di certificazione [approfondisci]
Nel presente contributo viene riportato un protocollo scientifico, ampiamente utilizzato e validato da una abbondante letteratura scientifica internazionale, utilizzabile per la certificazione dell’origine geografica delle produzioni agricole e agroalimentari. Il protocollo è strutturato essenzialmente in due fasi una prima parte nella quale sono raccolte le informazioni sperimentali e una seconda fase di elaborazione computazionale delle stesse. L’accettazione internazionale di questo protocollo è dovuta agli univoci risultati ottenuti negli ultimi venti anni, ed è fondata sulla flessibilità delle metodologie utilizzate nella fase sperimentale e durante l’analisi computazionale. La raccolta dei dati sperimentali può essere condotta con differenti metodi strumentali cromatografici, spettrometrici e spettroscopici, ciascuno dei quali è pienamente referenziale per le finalità dell’indagine. È importante sottolineare che l’integrazione dell’informazione sperimentale raccolta con più metodologie, aumenta in modo rilevante il grado di affidabilità della determinazione. Con simile flessibilità possono essere utilizzati specifici metodi computazionali di analisi dei dati sperimentali. Analisi che ha lo scopo di raggruppare le proprietà matematico-statistiche dei dati raccolti in clusters definibili in spazi bi o tridimensionali. L’insieme dei metodi computazionali, indicati come «Analisi Multivariata» o «Analisi Chemiometrica», presenta algoritmi interpretativi differenti, ciascuno dei quali risulta essere particolarmente idoneo per l’analisi dei differenti set di dati sperimentali raccolti. L’approccio combinato sperimentale-computazionale appare ormai completamente maturo per il pieno utilizzo nella certificazione di origine geografica dei prodotti agricoli e agroalimentari. L’affidabilità di questo protocollo è ormai così ampia e dimostrata internazionalmente da poter essere di grande utilità in ambito giudiziario.
This paper presents a scientific protocol widely used and validated by an abundant international scientific literature to certify the geographical origin of agricultural and agri-food products. The protocol is essentially structured in two phases, a first step in which the experimental information is collected and a second phase of computational processing. The international acceptance of this protocol is due to the unambiguous results obtained in the last twenty years, and is based on the flexibility and integrabilty of the methodologies used for both the experimental procedure and computational analysis. Different experimental procedures such as chromatographic, spectrometric and spectroscopic are used, each appearing fully referential for the purposes of the investigation. It should be noted that the integration of the experimental information collected with multiple methodologies also significantly improves the degree of reliability of the determination. With similar flexibility, specific computational methods can be used for the experimental data analysis. Computational methods aim to create well-defined clusters of information described in two and/or three-dimensional spaces. The set of computational methods that are referred to as «Multivariate Analysis» or «Chemometric Analysis», have different interpretative algorithms. Each specific algorithm is self-consistent and suitable for the analysis of the different experimental data sets. The combined experimental-computational approach now appears fully mature for its use in the Certification of Geographical Origin of Agricultural and Agri-food products. The reliability of this protocol is now so broad and internationally proven to be of great utility in the judicial area.
VINCENZO PACILEO
Reati alimentari. Le contravvenzioni e le relative indagini [approfondisci]
Lo scritto vuole offrire un sommario delle contravvenzioni in materia penal-alimentare. L’autore inizia con una breve storia della normativa in relazione agli interessi protetti. L’accento è posto sulla legge n. 283/1962, sottolineando che essa è ispirata a un approccio cautelativo a tutela della salute, sebbene il vero e proprio «principio di precauzione» sia stato introdotto (dalla Comunità europea) solo decenni dopo. L’autore descrive le specifiche fattispecie e riporta passi della relativa giurisprudenza. Sono pure trattati temi procedurali, in particolare l’utilizzo nel processo dei referti di analisi di alimenti.
The paper is intended to offer a summary of the minor offences in food criminal law. The author starts with a short history of the legislation and its protetcted interests. The focus is on the food law n. 283/1962, remarking that it is inspired by a precautionary approach on health, even if the real «precautionary principle» was introduced (by the European Community) decades after. The author describes the specific offences and reports related cases of law. Procedural items are also treated, particularly the use of the analytical results on food as proof in the trial.
GIUSEPPE GATTI
Le strategie di contrasto alle agromafie e alle condotte di riciclaggio [approfondisci]
Il presente lavoro è incentrato sull’analisi del fenomeno dell’agromafia e del riciclaggio e sulle strategie di contrasto giudiziario, con una focalizzazione sull’esperienza foggiana. Nella prima parte si ricostruisce l’evoluzione generale del fenomeno dell’agromafia con il passaggio da un modello parassitario, basato sull’attività estorsiva e con una operatività limitata ad alcuni specifici settori, ad un modello imprenditoriale fondato sull’imposizione di un monopolio commerciale e su una operatività diffusa in molteplici ambiti e livelli. Nella seconda parte si affronta lo specifico fenomeno dell’agromafia foggiana, ripercorrendo il percorso evolutivo delle mafie foggiane e il salto di qualità compiuto negli ultimi anni nell’infiltrazione nel tessuto economico ed amministrativo, con particolare riferimento al settore agroalimentare, principale risorsa della Provincia di Foggia, con il passaggio da un modello tradizionale di tipo predatorio ad un più evoluto diretto protagonismo imprenditoriale. Nell’ultima parte si analizzano le strategie investigative fondate su un modello innovativo che punta alla creazione di un polo unitario di contrasto giudiziario realizzato con la sinergica partecipazione di tutti gli uffici giudiziari coinvolti; al raccordo tra la fase di prevenzione e quella repressiva con circolarità dei circuiti informativi; alla valorizzazione del ruolo dell’antimafia sociale e alla creazione di una comune rete di protezione, sostegno ed inclusione in favore degli imprenditori che sono vittime dell’oppressione mafiosa.
The present work is focused on the analysis of the phenomenon of «agromafia» and money laundering judicial contrast strategies, with a focus on the Foggia experience. The first part reconstructs the general evolution of the «agromafia» phenomenon with the transition from a parasitic model, based on extortion activity and with an operation limited to some specific sectors, to a business model based on the violent imposition of a commercial monopoly and on a widespread operation in multiple areas and levels. The second part deals with the specific phenomenon of the Foggia «agromafia», reconstructs the evolutionary path of the Foggia mafias and the qualitative leap made in recent years in the infiltration into the economic and administrative sector, with particular reference to the agri-food sector, the main resource of the province of Foggia, with the transition from a traditional predatory model to a more evolved direct entrepreneurial protagonism. The last part analyzes the investigative strategies based on an innovative model that aims to create a unitary pole of judicial contrast created with the synergistic participation of all the Prosecutor’s Offices involved; the connection between the prevention phase and the repressive phase with circularity of the information circuits; the enhancement of the role of anti-mafia associations and the creation of a common network of protection, support and inclusion in favor of entrepreneurs who are victims of mafia oppression.
ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
Le condotte di riciclaggio dei proventi delle frodi agroalimentari [approfondisci]
Partendo dall’esame di una sentenza della Corte di cassazione, di cui l’autore è stato relatore, viene ricostruita la figura del delitto di riciclaggio con particolare riferimento alle sue possibili applicazioni nel campo delle frodi agroalimentari.
Through the examination of a Corte di assazione’s judgment, of which the author was rapporteur, the crime of money laundering is reconstructed with particular reference to its possible applications in the field of food fraud.
SONIA CARMIGNANI E GIUSEPPINA PAPINI
Le frodi in agricoltura [approfondisci]
La politica agricola comune viene finanziata principalmente dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale, le cui misure a livello nazionale, vengono implementate dall’AGEA, che svolge al contempo un ruolo di organismo di coordinamento e di organismo pagatore. In quest’ultimo caso per concedere i diritti di aiuto a valere sui fondi europei, riceve le domande dai Centri di assistenza agricola, per conto degli imprenditori agricoli interessati. In questo contesto si registrano diversi casi di danno erariale, anche nel settore della Pesca, la cui giurisdizione appartiene alla Corte dei conti. Il flusso di denaro derivante dalla gestione del PNRR e della nuova PAC impongono un sistema di allerta e di cooperazione ancora più efficace, tra Corte dei conti, forze di polizia nazionali e l’OLAF, da implementarsi in uno scenario multi-livello.
The article analyses how Common Agricultural Policy (CAP) financially works through its principal funds, the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF), and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), and its functioning at the national level. In Italy, the government organisation responsible for granting benefits is the national payment Agency for Agriculture (AGEA), supported by various bodies, called Agricultural Assistance Centre, in order to provide technical advice to farmers. In this context, there is the problem of frauds affecting European Union funds, and, in the second part of the paper, it will be considered also a case law about the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). The final part examines the perspective of Recovery and Resilience Plan (RRP) with regards to the circumstance of preventing the illicit appropriation of indirect or direct funds, possible with a closer cooperation between Italian Corte dei conti and its local police forces, and the European Anti-Fraud Office (OLAF), in a multi-level scenario.
2021
[approfondisci]Indice fascicolo 3 - 2021
FRANCESCO AVERSANO
Controlli ufficiali del Made in Italy e strumenti di tutela [approfondisci]
Nell’elaborato viene proposto un quadro delle problematiche di ordine procedimentale legate alle attività di vigilanza sui prodotti immessi sul mercato sotto la dicitura Made in Italy. Le considerazioni richiamano aspetti della disciplina sostanziale, mediante un esame incrociato di alcune prescrizioni della legislazione agroalimentare e di quella doganale, in raffronto con i modelli normativi dettati a livello interno e con le fonti giurisprudenziali. Saranno toccati profili applicativi riguardanti le fattispecie sanzionatorie e talune questioni sulle caratteristiche del fenomeno in esame, tra cui le sue implicazioni culturali.
The report provides an overview of the procedural problems concerning the control system in order to verify products placed on the market under the name Made in Italy. The considerations refer to aspects of the substantive regulation, through a cross-examination of certain requirements of agri-food and customs legislation, in comparison with regulatory models dictated at internal level and with the sources of case law. It will touch on application profiles relating to penalties and certain questions on the characteristics of the phenomenon, as well as its cultural implications.
SONIA CARMIGNANI
Attività agricola e crisi d’impresa [approfondisci]
Il lavoro affronta il tema dell’impatto della riforma delle procedure concorsuali sull’impresa agricola. In particolare, l’attenzione è rivolta verso l’effettiva applicabilità delle nuove procedure quando ad essere in stato di crisi si trovi l’imprenditore agricolo. La scelta legislativa di accomunare imprenditore agricolo e imprenditore commerciale non pare idonea a salvaguardare l’integrità del complesso aziendale agricolo.
The work addresses the issue of the impact of the reform of insolvency procedures on the agricultural enterprise. Particularly, the focus is on the effective applicability of the new procedures when the agricultural entrepreneur is in a state of crisis. The legislative choice to unite agricultural entrepreneur and commercial entrepreneur does not seem suitable for safeguarding the integrity of the agricultural business complex.
LAURA COSTANTINO
Il ruolo dell’agricoltura nel riutilizzo dei terreni confiscati: analisi e prospettive [approfondisci]
Il complesso disciplinare volto alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni mafiosi è estremamente variegato e abbraccia interventi normativi di ambito europeo e nazionale. Il presente lavoro si concentra sulla disciplina relativa alla gestione dei terreni confiscati, indagando se e in quale misura sia possibile potenziare il ruolo dell’agricoltura, sia in una prospettiva statica, in considerazione del legame dell’attività agricola con il territorio, sia in una prospettiva dinamica, che abbraccia l’intera filiera agroalimentare.
The regulatory framework related to the prevention and suppression of criminal organization is very complex and includes national and European rules. The present paper focuses on the regulation related to the management of agricultural land confiscated, analysing if it is possible to enhance the rule of agriculture, both in a static perspective, with regard of the relationship with the agricultural land, both in a dynamic way, that encompasses the entire agri-food chain.
AMARILLIDE GENOVESE
Comunicazione commerciale dell’impresa alimentare e tutela degli young consumers Il contributo del sistema di autodisciplina pubblicitaria [approfondisci]
Una ricerca dell’Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato che bambini e adolescenti hanno una grande influenza sulle decisioni di acquisto dei genitori, e sono percepiti come dei veri e propri market makers dalle multinazionali del settore alimentare. Lo studio rivela che le giovani generazioni diventano uno specifico «bersaglio» al fine di consolidare l’abitudine al consumo frequente di bevande e fast food, tanto da renderla persistente anche nell’età adulta. Il controllo della pubblicità degli alimenti da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato rivela, in effetti, il diffuso ricorso a strategie comunicative sleali in grado di disorientare le decisioni di acquisto di prodotti alimentari, specialmente insidiose quando riguardino prodotti destinati ad «agganciare» il pubblico dei più giovani. L’analisi della comunicazione d’impresa e delle scelte di consumo nel mercato dei prodotti alimentari destinati ai più giovani costituisce un terreno privilegiato per apprezzare le dinamiche del cambiamento sociale, espresse sia dalle tendenze e dalle propensioni al consumo manifestate dalla popolazione giovanile, sia dalle strategie di marketing «messe a punto» dalle imprese per rendere appetibili i propri prodotti presso questo target group. Il presente studio si è proposto di valutare l’efficacia delle risposte giuridiche alle istanze di tutela degli young consumers, alla luce del quadro disciplinare della materia, stratificato tra normative di diritto interno, regole di fonte europea e istanze autodisciplinari. Al progressivo innalzamento della soglia di attenzione al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, sia in relazione ai messaggi che possano turbare personalità ancora in fieri, sia in relazione a comportamenti e settori merceologici specifici, in cui occorre dimostrare una maggiore responsabilità verso il pubblico dei minori, ha contribuito in modo essenziale l’esperienza dell’autodisciplina pubblicitaria, che peraltro ha svolto un cruciale ruolo di supplenza nei primi anni di vigenza del Codice di lealtà pubblicitaria e fino all’attuazione della direttiva sull’advertising ingannevole, regolamentando in via esclusiva la materia e costituendo un laboratorio innovativo nel panorama internazionale dell’epoca. La recente direttiva 2018/1808/UE sui servizi media audiovisivi, attualmente in fase di recepimento nel nostro ordinamento, sollecita l’adozione di codici di condotta per proteggere i minori dalla pubblicità alimentare ingannevole o aggressiva e promuovere un regime dietetico sano e corretto. Il lavoro analizza gli apporti innovativi della direttiva e i criteri specifici per l’attuazione della delega, che si riferiscono alla promozione di forme di self-regulation dei fornitori di servizi media audiovisivi, nell’ambito specifico delle comunicazioni commerciali relative a bevande alcoliche e alle comunicazioni commerciali che accompagnino programmi per bambini o vi siano incluse, relative a prodotti alimentari e bevande «HFSS» high in fat, salt and sugar, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Anche l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha accolto la sollecitazione del legislatore europeo, adottando un regolamento per la comunicazione relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione, entrato in vigore il 9 febbraio 2021.
A research by the World Health Organization has shown that children and adolescents have great influence over their parents’ purchasing decisions and so they are perceived as market makers by food corporations. The study reveals that the younger generations become a specific «target» in order to consolidate the habit of frequent consumption of beverages and fast food, so much so that it persists into adulthood. The control of food advertising by the National Competition and Market Authority reveals the pervasive recourse to unfair communication strategies capable of disorienting the decisions to purchase food products, especially insidious when they concern products intended to «hook» the younger public. The study of business communication and consumption choices in the market of food products for young people is a privileged field to appreciate the dynamics of social change, expressed both by the trends and the propensity to consume expressed by the young population, and by the marketing strategies «developed» by companies to make their products attractive to this target group. This study aims to evaluate the effectiveness of the legal responses to the protection of young consumers, in the light of the disciplinary framework of the topic, layered between domestic law, EU rules and self-regulation. The progressive raising of the threshold of attention to the world of childhood and adolescence, both in relation to messages that can upset growing personalities, and in relation to specific behaviors and product sectors, in which greater responsibility must be demonstrated towards the public of minors, the experience of advertising self-discipline has made an essential contribution, which moreover played a crucial substitute role in the early years of the Codice della lealtà pubblicitaria and until the implementation of the Directive on misleading advertising, exclusively regulating the matter and constituting an innovative example in the international panorama of the time. The recent EU Directive 2018/1808 on audiovisual media services, currently being transposed into our legislation, calls for the adoption of codes of conduct to protect minors from misleading or aggressive food advertising and promote a healthy and correct dietary regime. The work analyzes the innovative contributions of the directive and the specific criteria for the implementation of the delegation, which refer to the promotion of forms of self-regulation by providers of audiovisual media services, in the specific area of commercial communications relating to alcoholic beverages and commercial communications that accompany programs for children or are included therein, relating to food products and beverages «HFSS» high in fat, salt and sugar, the excessive intake of which in the general diet is not recommended. The Institute of Autodisciplina Pubblicitaria has also responded to the solicitation of the European legislator by adopting a Regulation for the communication of foodstuffs and beverages, in order to protect children and their healthy diet, entered in force on 9th february 2021.
DAL CONVEGNO
ALBINIA CANDIAN
Rischi e responsabilità nella filiera agricola [approfondisci]
Il saggio contiene alcune riflessioni introduttive al Convegno organizzato da CESIFIN e AIDA «Agricoltura, fauna selvatica, caccia e assicurazioni» tenutosi il 23 aprile 2021. Nella premessa si indicano obiettivi del convegno e metodologia adottata, entrambi ispirati ad un criterio del tutto opportuno di multidisciplinarietà, posto che le tematiche affrontate interessano le diverse scienze. I paragrafi 2 e 3 illustrano due rilevanti profili giuridici, ossia il tema della mappatura dei rischi della filiera alimentare e quello delle tecniche di prevenzione e traslazione dei rischi stessi agli assicuratori e al mercato finanziario. Come esempi del primo tipo il saggio contiene riflessioni sulle coperture assicurative più adatte, ovvero polizze indicizzate che consento di dare maggiore efficienza a profili quali i costi di liquidazione, l’efficiente predeterminazione delle perdite anche a fini riassicurativi e la necessaria riduzione di problemi di selezione avversa. Infine, come trasferimento al mercato finanziario, il saggio si riferisce allo strumento dei cat Bonds.
This paper contains some preliminary reflections on the conference organized by CESIFIN and AIDA «Agriculture, wildlife, hunting and insurance» held on April 23, 2021. The introduction outlines the objectives of the conference and the methodology adopted, both inspired by an entirely appropriate multidisciplinary criterion, since the issues addressed concern different sciences. Paragraphs 2 and 3 illustrate two relevant juridical profiles, namely, the theme of mapping risks in the food chain and that of prevention techniques and the transfer of risks to insurers and the financial market. As examples of the first type, the paper contains reflections on the most suitable insurance coverage, i.e., indexed policies that allow to give greater efficiency to profiles such as liquidation costs, the efficient predetermination of losses also for reinsurance purposes and the necessary reduction of adverse selection problems. Lastly, the article refers to the instrument of cat bonds as a transfer to the financial market.
SARA LANDINI
Assicurazione del rischio in agricoltura [approfondisci]
Il contratto di assicurazione rappresenta uno strumento di resilienza finanziaria delle imprese agricole da tempo per quanto non sfruttato adeguatamente dagli operatori. La PAC post 2020 introduce elementi di novità a partire dalla nuova ripartizione tra coperture catastrofali, di frequenza e di rischio. Si nota poi una semplificazione delle procedure e un nuovo meccanismo di calcolo dei parametri ai fini della determinazione del contributo. Nello scenario del mercato assicurativo si evidenzia però la necessità di pensare a strategie per implementare il numero delle coperture attraverso sinergie tra credito all’agricoltura e copertura del rischio agricolo.
The insurance contract represents a tool for the financial resilience of agricultural enterprises although not adequately exploited by operators. The post-2020 CAP introduces new elements starting with the new breakdown between catastrophe, frequency and risk coverage. There is also a simplification of the procedures and a new mechanism for calculating the parameters for the purpose of determining the contribution. In the insurance market scenario, however, there is a need to re-think of strategies to implement the number of coverages through synergies between agricultural credit and agricultural risk coverage.
NICOLA LUCIFERO
La gestione del rischio e i danni da fauna selvatica in agricoltura [approfondisci]
Il saggio affronta il tema dei danni da fauna selvatica in agricoltura nel contesto della gestione del rischio in agricoltura, la cui più recente evoluzione normativa ha ricompreso tale fattispecie di danno nel contesto delle nuove fattispecie di rischio. Il tema pone non pochi problemi di natura ermeneutica anche se, apparentemente, possono sembrare riconducibili ad un medesimo schema normativo in quanto destinati a una gestione dell’evento calamitoso in agricoltura, invece presentano profonde distinzioni non solo per il diverso modello regolatorio adottato, ma prim’ancora per la natura stessa dell’evento pregiudizievole.
The essay deals with the issue of damage from wildlife in agriculture in the context of the risk management in agriculture, which recently has included it in the related applicable law as a new type of risk. The topic poses many problems of a hermeneutic nature despite that, apparently, they may seem attributable to the same regulatory scheme as they are intended for the management of the calamitous event in agriculture, on closer inspection they present several distinctions not only for the different regulatory model adopted, but above all for the very nature of the prejudicial event.
STEFANO MASINI
Prospettive nell’evoluzione dei rapporti tra banche e agricoltura [approfondisci]
Già nell’inchiesta Jacini sull’agricoltura, si rintracciano gli elementi di specialità che contrassegnano la funzione degli istituti di credito agrario non solo in vista delle operazioni effettuate e, cioè, con riguardo agli scopi e alle garanzie, quanto in conseguenza della espressione degli interessi rappresentati dalla borghesia rurale. In proposito, occorre considerare la logica fondiaria che presidiava allo svolgimento delle attività rispetto al cui svolgimento le garanzie reali (privilegio e ipoteca) tutelavano le ragioni dei creditori. Ma anche in seguito, quando l’agricoltura comincia ad affacciarsi sul mercato e, sul piano del credito, viene meno il ritaglio della specialità degli istituti, i margini di una diversa connotazione delle operazioni continuano a caratterizzare la valutazione del merito dell’iniziativa economica e della capacità professionale dell’imprenditore, chiamando in causa le competenze di specialisti. Un supporto all’analisi finanziaria sembra offerto dall’art. 2086 c.c. che, al di là della rilevazione tempestiva della crisi, rende disponibile un quadro organizzativo utile alla rappresentazione dei rischi se bene non venga meno lo stesso interesse per il credito agevolato dal finanziamento pubblico e, sopra tutto, la necessità di tener conto dell’iniziativa economica al cui allestimento si rapportano anche le misure più recenti della legislazione dell’emergenza a partire dalla costituzione del pegno.
Already in the Jacini survey on agriculture, specific elements can be found that characterise the role of agricultural credit institutions not only in view of their operations, i.e. purposes and guarantees, but also as a result of the expression of the interests represented by the rural bourgeoisie. In this regard, we need to consider the land-based logic that governed the performance of the activities against which the real guarantees (lien and mortgage) protected the rights of creditors. But even later, when agriculture was starting to appear on the market and, in terms of credit, the special nature of the institutions was no longer evident, the margins for a different connotation of the operations would continue to characterise the assessment of the worthiness of the business initiative and the professional capacity of the entrepreneur, thus bringing in the expertise of specialists. Art. 2086 of the Italian Civil Code seems to support such financial analysis, which, beyond the timely detection of the crisis, offers a useful organisational framework for the representation of risks, although there is still the same interest in public-funded credit and, above all, the need to take into account the business initiative to which the most recent measures of emergency legislation, beginning with the introduction of pledges, relate.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
NICOLETTA FERRUCCI
Al vaglio della Corte costituzionale le norme regionali sulla ricostituzione del paesaggio olivicolo pugliese post Xylella fastidiosa [approfondisci]
Traendo spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2021, il lavoro ripercorre le diverse tappe nelle quali si è articolato l’intervento derogatorio al regime dell’autorizzazione paesaggistica inerente all’agricoltura, sia di portata generale, sia formulato ad hoc per la ricostruzione del paesaggio olivicolo pugliese distrutto dal batterio Xylella fastidiosa.
The work takes the cue from the judgement n. 74/2021 of the Constitutional Court to retrace the different stages of the regime derogatory intervention of the landscape authorization regarding agricolture, analysing its general applications as well as its most specific aspects aimed at guaranteeing the reconstruction of the olive landscape of Puglia destroyed by the pathogen Xylella fastidiosa.
Indice fascicolo 2 - 2021
GIULIA CHIRONI
Fiscalità nutrizionale: prime esperienze e prospettive di riforma [approfondisci]
Accertata la crescente importanza della fiscalità nutrizionale, il lavoro analizza il ruolo dei tributi alimentari caratterizzati da una funzione fiscale e da una funzione extrafiscale: non limitandosi a procurare entrate, generano effetti positivi sul contenimento della spesa sanitaria, concorrendo al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione ed alla riduzione dell’incidenza di specifiche malattie, con conseguente riduzione della spesa sanitaria. Il lavoro evidenzia come la valorizzazione di tali finalità extrafiscali possa indurre a compenetrarle nella fattispecie imponibile (produzione o consumo di beni) ovvero a lasciarle al suo esterno, prevedendo una destinazione del gettito compatibile con il fine assunto.
After having ascertained the increasing importance of nutritional taxation, this work analyzes the role of food taxes characterized by a fiscal and a non fiscal function: withouth limiting themselves to providing revenue, they generate positive effects on the containment of health costs, contributing to improve of the health conditions of the population and the reduction of the incidence of specific diseases, reducing the health costs. The work highlights how the enhancement of these non fiscal purposes can induce them to be interpenetrated in the taxable case (production or consumption of goods) or to leave them outside, forecasting a destination of the revenue compatible with the purpose assumed.
NICOLETTA FERRUCCI
Il verde urbano sotto la lente del giurista: una prima overview [approfondisci]
L’articolo ripercorre le tracce del dialogo costante tra il diritto ambientale e la scienza, e della risposta offerta dalla legge alle pressanti sollecitazioni del mondo scientifico sul ruolo strategico del verde urbano, soprattutto a fronte delle emergenze legate ai cambiamenti climatici, alla crisi quantitativa e qualitativa della biodiversità, e delle relative ripercussioni sulla salute umana.
The articles retraces the steps of the constant dialogue between Environmental Law and science and the answer given by the law to the pressing requests of the scientific world on the strategic role of urban green, especially in the face of the emergencies linked to climatic changes, quantitative and qualitative crisis of biodiversity and their impact on human health.
FABIO FRANCARIO
L’organizzazione dell’attività amministrativa di contrasto delle pratiche commerciali sleali. Profili di tutela giurisdizionale [approfondisci]
Assicurare maggiori tutele per le imprese del settore agroalimentare contro le pratiche commerciali e le distorsioni del mercato imputabili ai colossi della grande distribuzione è uno degli obbiettivi della dir. UE 2019/633, recepita nel nostro ordinamento nazionale con la legge comunitaria 53/2021, la quale ha disegnato un sistema di tutela giurisdizionale che vede il concorso di giudice ordinario e giudice amministrativo a seconda che siano impugnati provvedimenti dell’AGCM o dell’ICQRF o anche, nei confronti di quest’ultimo, a seconda che si tratti di sanzioni pecuniarie o non pecuniarie.
Ensuring greater protection for companies in the agri-food sector against commercial practices and market distortions attributable to large-scale distribution giants is one of the objectives of the directive UE 2019/633, transposed into our national system with the community law 53/2021, which has designed a system of juridical protection that sees the competition of ordinary judge and administrative judge depending on whether the measures of the AGCM or the ICQRF or also, against the latter, depending on whether they are pecuniary or non-pecuniary sanctions.
BEATRICE LA PORTA
Criticità della tutela dei dati scientifici nel regolamento sui nuovi alimenti anche alla luce della disciplina in materia di benessere degli animali [approfondisci]
Il regolamento (UE) 2283/2015 sui novel food rappresenta un’evoluzione nella protezione dei dati scientifici relativi ai nuovi prodotti alimentari. La normativa, sviluppata sul modello offerto dal regolamento (UE) 1924/2006 in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute, garantisce una protezione quinquennale dei dati scientifici e delle prove prodotte dal richiedente in sede di domanda di autorizzazione di un nuovo prodotto ex art. 10 del regolamento (UE) 2283/2015. La previsione di un termine quinquennale di tutela se, secondo taluni, può risultare troppo breve per rappresentare un vero incentivo per compiere investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese; d’altra parte può risultare un tempo idoneo a limitare la concorrenza, facendo, altresì, emergere criticità sul fronte della tutela degli esseri senzienti utilizzati in sede di sperimentazione. Infine, non considerare tutelabili i dati scientifici previamente pubblicati su riviste accademiche potrebbe portare ad una sottrazione dei risultati scientifici prodotti dal sistema globale di controllo, pure garantito dalla peer-review. A ciò conseguirebbe una rottura delle relazioni sinergiche tra aziende e mondo accademico e una limitazione degli elementi offerti ad EFSA per compiere un processo di valutazione del rischio che sia completo e idoneo a proteggere i consumatori.
Regulation (EU) 2283/2015 on novel food represents an evolution in scientific data protection related to new food products. Based on the regulation on health and nutritional claims, the current regulation on novel foods guarantees five-year protection of the applicant’s scientific data and evidence produced in the occasion of Article 10 of the Regulation (EU) 2283/2015 procedure. The provision of five years of scientific data protection and evidence, on one side, can appear too short to represent a real incentive for companies’ researches; on the other, it can limit real competition from companies on the market. Furthermore, the provision of five years of full scientific data protection could represent a critical issue in light of the legislation on protecting animals used in lab experiments. Finally, not considering protectable scientific data yet published in the academic journals could subtract scientific results from the global scientific panorama and the peer-review process. It could also crack the synergistic relationships between companies and academia and translate into an incomplete risk assessment process by EFSA and, ultimately, less consumer protection.
CARLA LOLLIO
Il trattamento fiscale del compendio unico ovvero quando la premialità positiva cede il passo a interventi di riforma e di razionalizzazione «sfunzionali» [approfondisci]
La complessità della materia delle agevolazioni fiscali richiede, indubbiamente, interventi di razionalizzazione e sistematizzazione. Nel tentativo di operare tali riforme il legislatore può tuttavia realizzare veri e propri tagli lineari, senza prevedere al riguardo alcuna eccezione. Può così accadere che le motivazioni alla base dell’intervento entrino in rotta di collisione con gli scopi extrafiscali del trattamento agevolato e che l’istituto, al quale quest’ultimo si riferisce, sia privato di quell’appeal che proprio i benefici di carattere tributario gli conferivano. Le vicende che hanno interessato il regime fiscale del compendio unico risultano, in proposito, alquanto emblematiche. Infatti, in esito all’intervento di razionalizzazione della disciplina delle imposte d’atto applicabili alle diverse tipologie di trasferimenti immobiliari, operata dall’art. 10 del citato decreto legislativo n. 23/2011, al comma 4 e concernente anche i trattamenti di favore previsti in legge speciali, dal 1° gennaio 2014, sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni, riferite agli atti di costituzione a titolo oneroso del compendio unico. Successivamente l’art. 1, comma 57, l. 28 dicembre 2015. n. 208 ha ripristinato l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo ma soltanto per «(...) gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane». Alcune recenti proposte di legge evidenziano tuttavia che la reintroduzione delle agevolazioni fiscali anche per il compendio unico – non realizzabile in via interpretativa – è indispensabile affinché l’istituto recuperi il suo appeal originario.
The subject of tax benefits is so complex that it undoubtedly requires measures for its rationalization and systematization. However, in the attempt to implement these reforms, law-makers may realize real linear cuts with no exception in this regard. It may occur that the reasons for this intervention clash with the extra-tax purpose of the preferential treatment; thus, the institution to which it is referred, is deprived of the peculiar appeal which tax benefits lent it. In this regard, the events which affected the tax system of «compendio unico» result rather emblematic. In fact, as a result of the intervention di rationalization of the rules governing deed taxes chargeable to the different typologies of real estate transfers, operated by art. 10 of the above-mentioned legislative decree n. 23/2011, sub-section 4 and also concerning special consideration provided for in special laws, all exemptions and benefits referred to title deeds for a consideration of «compendio unico» have been abolished from January 1, 2014. Then Art. 1, sub-section 57, Law n. 208 dated December 28, 2015 put back in force the exemption from registration, mortgage, cadastral and stamp taxes, but only for «(...) acts and measures issued to enforce plans for land recomposition and reorganisation reorder promoted by regions, provinces, municipalities, mountain communities consortia of mountain municipalities». Nonetheless, some recent draft laws highlight that the reintroduction of tax benefits also for «compendio unico» – which is not implementable by way of interpretation – is essential for this institution to recover its original appeal.
NICOLA LUCIFERO
Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare [approfondisci]
Il saggio affronta il tema dei contratti di rete nel contesto delle relazioni delle imprese lungo la filiera agroalimentare, mettendo in luce i profili applicativi dei contratti di rete con l’obbiettivo di verificare se tali modelli contrattuali possono avere rilievo per perseguire il fine auspicato dal legislatore di accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese sul mercato tenendo in dovuta considerazione le peculiarità della filiera agroalimentare. Infatti, il contratto di rete rappresenta un interessante modello per analizzare le interazioni tra il diritto dei contratti e il diritto della concorrenza nel contesto delle relazioni tra gli operatori della filiera agroalimentare.
The essay deals with the issue of network contracts in the context of business relationships along the agri-food chain, highlighting the concrete application of network contracts in the agricultural sector and with the aim of verifying whether these contractual models can be relevant for pursuing the goal desired by the legislator
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
FRANCESCO SCALIA
Dopo la Corte costituzionale, anche la Corte di giustizia promuove la rimodulazione degli incentivi alle fonti rinnovabili [approfondisci]
L’articolo commenta la Sentenza della Corte di giustizia che ha ritenuto compatibile con l’ordinamento europeo l’art. 26, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, di rimodulazione – in senso deteriore per i produttori beneficiari – degli incentivi riconosciuti ad impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e delle relative convenzioni. La sentenza segue quella della Corte costituzionale (la n. 16 del 2017), che aveva già statuito in ordine alla costituzionalità della medesima norma. L’articolo si snoda attraverso un excursus del contenzioso innescato dalla norma oggetto del rinvio pregiudiziale nei diversi ambiti – interno, europeo ed internazionale –; nel commento critico della sentenza della Corte di giustizia e nell’approfondimento del principio del legittimo affidamento, sulla cui interpretazione e applicazione al caso si fonda la decisione. Il paragrafo conclusivo è dedicato al tema dell’applicabilità del Trattato sulla Carta dell’energia agli investitori nel settore energetico di Stati membri, liquidato con poche battute dalla Corte di giustizia, ma che a giudizio dell’autore avrebbe meritato un più ponderato scrutinio.
The article comments on the Judgment of the European Court of Justice, which deemed article 26, paragraph 3 of the Decree-Law No 91/2014 on alteration – to the detriment of the recipients – of the support scheme granted to plants for the production of electricity from solar photovoltaic installations and the related agreements. This ruling follows that of the Italian Constitutional Court (No 16 of 2017), which ruled on the constitutionality of that provision. The paper articulates through an excursus of the litigation triggered by the provision referred for a preliminary ruling which is discussed in various areas i.e. national, European and international. A critical comment on the judgement of the European Court of Justice and a deeper understanding of the principle on protection of legitimate expectations, that is the interpretation and application ruling basis, are also provided. Conclusions are dedicated to the topic related the applicability of the Energy Charter Treaty to energy investors of EU member states on which the European Court of Justice only touched upon it. It is the author’s opinion that this issue would have deserved a more careful assessment.
2021
[approfondisci]Indice fascicolo 1 - 2021
STEFANO MASINI
Oltre la legalità: itinerario dell’affitto di fondi rustici tra rottura e continuità [approfondisci]
Nella ripresa del tema dei contratti agrari, se occorre, senz’altro, tener conto della crisi della armatura negoziale dell’affitto di fondo rustico imposta ex lege, non sfugge la necessità di mettere a punto dal basso nuove istanze di organizzazione del ciclo economico. È, infatti, la rigidità della disciplina a non rispondere più all’ammodernamento aziendale e alle novità del ciclo di produzione, sia pure escludendo di affidare al gioco spontaneo del negoziato la valutazione dell’assetto di interessi, con l’ingresso dell’organizzazione sindacale. Una conferma esplicita è offerta dalla stessa rilevazione empirica e repertoriale delle pronunce della giurisprudenza. Merita, allora, riprendere le fila del discorso, collegandosi all’esperienza attraverso la manipolazione della grezza fattualità di dati reali per gettare uno sguardo alla varietà dei materiali che, in conseguenza dell’innesto normativo della deroga alle norme imperative, apre a forme di tipicità sociale destinate a confrontarsi con l’incidenza dei princìpi costituzionali. Non si realizza, però, un passo indietro verso la libertà dei privati, ma si opera la scelta di salvaguardare le intuizioni maturate nella prassi, in base a zone e ordinamenti produttivi, fino a riproporre la rilevanza delle consuetudini così influenti nella materia come risulta dal rinvio all’indagine storica. Di qui la possibilità di evidenziare anche la resilienza di particolari regimi negoziali che, in quanto diretti a realizzare interessi socialmente meritevoli e a commisurarsi a fattori tecnici, continuano a mostrarsi adeguati al regolamento giuridico dell’impresa agricola.
Regarding agricultural contracts, if we must indeed take into account the crisis of the negotiating framework for the renting of rural property imposed ex lege, the need to put forward new ideas for the organisation of the economic cycle from the bottom up should not be overlooked. It is, in fact, the rigidity of the regulations that no longer corresponds to the modernisation of the farms or to the novelties of the production cycle, while ruling out the possibility of entrusting the evaluation of the interests to the spontaneous game of negotiation, once the trade unions become involved. An explicit confirmation is provided by the same empirical analysis and survey of the rulings in case law. It is therefore worth resuming the discussion, referring to the experience in order to take a look at the variety of documents which, as a consequence of the regulatory incorporation of the derogation from the binding rules, opens up to forms of corporate types designed to be confronted with the incidence of constitutional principles. It is not, however, a step backwards towards the freedom of private individuals, but the choice is made to safeguard the insights gained from practice, based on different areas and production systems, to the point of reaffirming the importance of customs that are so significant in the matter, as can be seen from the reference to historical research. Hence the possibility of highlighting the resilience of particular negotiating regimes which, since they are aimed at achieving socially desirable interests and measuring up to technical factors, are still appropriate to the legal framework of farms.
IRENE CANFORA E VITO LECCESE
Lavoro irregolare e agricoltura. Il Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, tra diritto nazionale e regole di mercato della nuova PAC [approfondisci]
Il saggio analizza il quadro regolativo e le strategie previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022), adottato per fronteggiare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura e completare il quadro nazionale degli strumenti di contrasto allo sfruttamento, con azioni di intervento regolative e operative, che si aggiungono alle sanzioni penali contro il caporalato. Tra queste assumono rilevanza le regole per il corretto funzionamento della filiera agroalimentare. Il saggio si sofferma sugli strumenti giuridici per correggere gli squilibri che causano una compressione dei costi del fattore lavoro e per valorizzare la filiera agroalimentare etica e sostenibile sul piano sociale, in linea con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamento del lavoro, alla luce dell’evoluzione della legislazione nazionale e dei nuovi regolamenti della PAC.
The essay analyses the legal approach and strategies defined by the Triennial Plan against work exploitation and gang-master system (2020-2022), adopted with the goal to tackle the phenomenon of undeclared work in agriculture and complete the national framework of tools to fight worker exploitation, by providing for regulatory and operational measures in addition to the criminal sanction against gang-master system. The relevance of rules aimed at the fairness functioning of the agri-food chain in tackling this phenomenon is clearly outlined by the Plan. The essay focuses on legal tools to correct the imbalances causing a compression of the cost of labour and to enhance an ethical and sustainable agri-food chain from a social point of view, in accordance with the goals of tackling work exploitation, in light of the changes in the national legislation and in the new CAP regulations.
SONIA CARMIGNANI
La salvaguardia dei vigneti eroici e storici nel d.m. 30 giugno 2020 [approfondisci]
In attuazione dell’art. 7 della l. 12 dicembre 2016, n. 238, il decreto ministeriale individua i territori e le tipologie di intervento, dettando la definizione dei vigneti eroici e storici, fissando i criteri per la loro individuazione e i criteri per la definizione delle tipologie di interventi, tra le quali, in particolare, la introduzione di un marchio nazionale.
In implementation of Article 7 of the Law of 12 December 2016, N. 238, the Ministerial Decree identifies the territories and the types of intervention, dictating the definition of heroic and historical vineyards, establishing the criteria for their identification and the criteria for the definition of the types of interventions, including, in particular, the introduction of a national brand.
WANDA D’AVANZO
Blockchain e smart contracts per la gestione della filiera agroalimentare. Potenzialità, progetti e problemi giuridici dell’internet del valore [approfondisci]
Quando si parla di tecnologie dell’informazione e della comunicazione si fa riferimento all’insieme dei sistemi informatici e digitali di raccolta ed elaborazione di dati. Nel loro percorso di evoluzione dagli anni ’70 del ’900 ad oggi, queste tecnologie hanno assunto, man mano, il ruolo di leve strategiche per il cambiamento della società globale e si stanno imponendo come strumenti di management organizzativo avanzato per le imprese. Molte aziende del settore agro alimentare hanno iniziato ad implementare e sperimentare diversi progetti di smart agrifood gestiti attraverso l’uso combinato di applicazione di internet delle cose, di intelligenza artificiale ed, in particolare, degli archivi digitali chiamati blockchain e degli smart contracts ad essa connessi. Le potenzialità di queste tecnologie sono tendenzialmente illimitate e potrebbero apportare notevoli benefici alla catena di valore agroalimentare, puntando ad una maggiore tracciabilità e trasparenza della filiera e a una maggiore valorizzazione del made in Italy.
When we talk about information and communication technologies, we refer to the set of computer and digital systems for collecting and processing data. In their evolutionary path from the 1970s to the present day, these technologies have gradually taken on the role of strategic levers for the change of global society and are establishing themselves as advanced organizational management tools for companies. Many companies in the agri-food sector have begun to implement and experiment with different smart agrifood projects managed through the combined use of the Internet of Things application, artificial intelligence and, in particular, digital archives called blockchain and smart contracts connected to it. The uses of these technologies are potentially unlimited and could bring significant benefits to the agri-food value chain, aiming at greater traceability and transparency of the supply chain and greater enhancement of the made in Italy.
NICOLETTA FERRUCCI
Le declinazioni del bosco nell’ambito della pianificazione paesaggistica alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali [approfondisci]
Si può parlare di sostenibilità paesaggistica del bosco alla luce del T.U.F.F.? Il lavoro ne ripercorre le tracce con particolare riferimento al multiforme ruolo riconosciuto dal provvedimento ai piani paesaggistici.
Is it possible to talk of a Landscape sustainability of the wood on the light of the T.U.F.F.? The paper tracks it with reference to the role played by Landscape Plans.
ALBERTO GERMANÒ
Sul comma 7 dell’art. 3 della legge n. 168/2017 [approfondisci]
Il termine concesso dalla legge n. 168/2017 sui domini collettivi alle Regioni perché la integrassero con proprie disposizioni negli aspetti indicati nei numeri 1-4 della lett. b) del comma 1 dell’art. 3 della precedente legge n. 97/1994 è scaduto. La conseguenza è che ogni Ente esponenziale delle collettività titolari di proprietà collettive può dettare le rispettive disposizioni normative. Il pericolo che si verifichi un modo di procedere in ordine sparso e senza controllo è, però, evitato dalla penultima frase del comma 7 dell’art. 3 della legge n. 168/2017 che stabilisce che i provvedimenti di tali Entri ricevano esecuzione con provvedimento amministrativo della Regione.
The terms set by Law no. 168/2017 on the «domini collettivi» for the Regional Governments to have it integrated with their own provisions as indicated in points 1-4, letter b), paragraph 1 of Art. 3 of the previous Law no. 97/1994 have expired. The consequence is that any exponential Entity of the collectively owned communities can dictate their own regulatory provisions. However, the danger of an uncontrolled and unregulated course of action is averted by the second last sentence of paragraph 7, Art. 3 of Law no. 168/2017, which states that the measures taken by such Entities shall be enforceable by means of an official order issued by the Regional Governments.
ANTONIO FELICE URICCHIO
La costruzione della società ecologica: il Green New Deal e la fiscalità circolare [approfondisci]
Il saggio analizza il c.d. Green New Deal dell’Unione europea, soffermandosi su finalità e stru-menti di economia e fiscalità circolare. Il lavoro evidenzia come tributi ambientali e ecoincentivi fiscali possano promuovere la costruzione della c.d. società ecologica.
The paper analyzes the so called Green New Deal considering the instruments of circular econ-omy and environmental taxation In particular, the paper analysis green taxes and tax expendi-tures, and their positive aspects and critical points.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
LORENZO BAIRATI
Etichettatura d’origine del latte, qualità oggettiva e qualità percepita. Il caso Lactalis contro Repubblica Francese [approfondisci]
La presente nota analizza la sentenza della Corte di giustizia in causa C-485/18, in merito al decreto francese n. 2018-1239, del 24 dicembre 2018, relativo all’indicazione dell’origine del latte nonché del latte e delle carni utilizzati come ingredienti. A tal proposito, l’analisi si concentra sulla posizione della Corte in merito all’interpretazione dell’art. 39, par. 2 del regolamento n. 1169/2011 in relazione alla possibilità per gli Stati membri di «introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza». Il commento si concentrerà sul rispetto, all’interno dell’Unione europea, di princìpi essenziali quali la libera circolazione di alimenti sicuri e sani e la tutela dei consumatori con particolare riguardo al loro diritto all’informazione. In conclusione verranno messe in luce conseguenze e prospettive in merito al ruolo, in questo ambito, di Stati membri e operatori del settore alimentare.
This essay analyzes the judgement of the European Court of Justice C-485/18 regarding French Decree No 2018-1239 of 24 December 2018 with respect to the indication of the origin of milk as well as of milk and meat used as ingredients. The analysis focuses on the Court’s position concerning the interpretation of Article 39(2) of Regulation No 1169/2011 regarding the possibility for Member States to «introduce measures concerning the mandatory indication of the country of origin or place of provenance of foods only where there is a proven link between certain qualities of the food and its origin or provenance». The essay focuses on the adherence, within the EU, to such essential principles as the free movement of safe and wholesome food and consumer protection with particular regard to the right to information. Concluding remarks will stress the consequences and future trends concerning the roles of both Member States and food operators in this sector.
LETTURE
FABRIZIO DI MARZIO
Alla ricerca del diritto. Sul pensiero di Paolo Grossi [approfondisci]
Il saggio ricostruisce gli ultimi sviluppi del pensiero giuridico di Paolo Grossi prendendo spunto dal libro Oltre la legalità. Il diritto non ha una fonte di produzione né esclusiva né previlegiata nella legge. Tuttavia, proprio questa mentalità è ancora oggi estremamente diffusa tra i giuristi in generale, e tra i civilisti in particolare. La riflessione di Grossi è un invito alla riscoperta della ricca realtà del giuridico, fatta non solo di leggi ma anche di orientamenti giurisprudenziali, opinioni dottrinali e prassi operative.
The essay retraces the last developments of the juridic thoughts of Paolo Grossi, taking inspira-tion from his book Oltre la legalità. The law cannot be exclusively traced back to the acts and codes. However, this mentality is still extremely widespread among jurists, in particular in the civil law field. The reflection of Grossi may be considered as an invitation to discover how rich the legal reality is, which is composed of the codifications as well as jurisprudential positions, doctrinal opinions and operating practices.
2020
[approfondisci]Indice fascicolo 3 -2020
PAOLO GROSSI
Un altro modo di possedere (riflessioni storico-giuridiche sugli assetti fondiarii collettivi in Italia) [approfondisci]
Nel saggio si intende ripercorrere l’itinerario storico-giuridico che, dopo tante incomprensioni e persecuzioni da parte dello Stato italiano, giunge a valorizzare il ruolo economico e soprattutto ambientale degli assetti fondiarii collettivi in seno alla società italiana.
This paper is intended to review the historical-legal process which, after so many misunderstandings and acts of persecution on the part of the Italian State, has led to the enhancement of the economic and above all environmental role of public land management in the Italian society.
FRANCESCO AVERSANO
L’agere publicum nelle prospettive del reg. UE n. 625/2017 [approfondisci]
La riforma dei controlli ufficiali, ispirata ai princìpi e alle regole del provvedimento europeo n. 625/2017, propone un quadro armonizzato volto al miglioramento dell’azione amministrativa interna agli Stati membri. Il contributo perciò intende suggerire una lettura del testo che prospetti la composizione di possibili discrepanze, quali talvolta s’intravedono tra lo svolgimento delle attività imprenditoriali e gli interventi della pubblica amministrazione nel comparto agroalimentare.
The reform of official controls, inspired by the principles and rules of the Regulation (EU) 2017/625, proposes a harmonised framework aimed at improving administrative action within the Member States. The contribution is therefore intended to suggest a reading of the text outlining the composition of possible discrepancies, such as are sometimes seen between the conduct of business activities and the interventions of the public administration in the agri-food sector.
ANNA KAPA?A
Legal status of direct marketing in US law [approfondisci]
Il presente studio, volto a determinare lo status giuridico della vendita diretta, esamina come la legge statunitense regola questa attività, se promuove la sua conduzione da parte degli agricoltori e qual è il suo posto nel concetto di attività agricola. Pertanto, è stata analizzata la definizione di attività agricola e di marketing diretto nel diritto statale e federale, nonché nelle normative locali sulla zonizzazione. Il direct marketing è un’attività commerciale non inclusa nel concetto di attività agricola. Gli agricoltori che gestiscono questa attività devono soddisfare una serie di requisiti stabiliti da enti legislativi locali, federali e statali. Tuttavia, molti programmi che forniscono sovvenzioni finanziarie sono mirati al marketing diretto, i quali costituiscono uno strumento principale a sostegno di questa attività.
The present study, aimed at determining the legal status of direct marketing, examines how US law regulates this activity, whether it contributes to its undertaking by farmers and what is its place in the field of agricultural activity. Therefore, the definition of agricultural and direct marketing activities in state and federal law, as well as in local zoning regulations were analyzed. Direct marketing is a business activity not included in the concept of agricultural activity. Farmers running this business must meet a number of requirements set by local, federal and state legislative bodies. However, many programs providing financial grants are targeted at direct marketing which are the main tool supporting this activity.
BEATRICE LA PORTA
Le cooperative di comunità quali potenziale strumento per ripensare e valorizzare gli usi civici nelle aree rurali. Uno spunto di riflessione [approfondisci]
Regolate da frammentate normative regionali, le cooperative di comunità si caratterizzano per inserirsi pienamente nel quadro delineato agli artt. 2511 c.c. ss. e per la tendenziale coincidenza tra i soci di queste ultime e la popolazione insistente in un’area geograficamente limitata. La presenza di gruppi organizzati di individui che svolgono attività di valorizzazione dei territori può rivelarsi potenzialmente capace di stimolare l’attività economica locale e perseguire lo sviluppo comunitario e il benessere collettivo, in un’ottica di relazione sinergica tra interessi pubblici e privati. L’importanza di una dimensione intergenerazionale, tipica dello sviluppo sostenibile e particolarmente legata al lavoro delle cooperative di comunità, si sposa anche con una visione di tutela degli interessi propria della proprietà collettiva e dei beni comuni. Nel caso degli assetti collettivi la predisposizione di misure conservative convive con la necessità di un continuo adattamento all’attività evolutiva di sistemi economia/ambiente in cui centrale è l’attività svolta dai soggetti che li rappresentano, in primis, i Comuni. Alla luce della riforma del 2017 e delle esperienze fallimentari che in passato hanno interessato numerose amministrazioni locali impegnate nell’attività di rappresentanza degli usi civici, la possibilità di individuare le cooperative di comunità quali gestori di assetti collettivi appare una scelta interessante anche in ragione della loro potenziale idoneità a rivalutare, sostenere e proteggere sia tali beni che, a livello più ampio, i beni comuni.
Regulated by fragmented regional regulations, Italian «cooperative di comunità» (literally «community cooperatives») are integrated into the Articles 2511 and follows of the Italian Civil Code. A coincidence between associates and the population insisted in a geographically defined area characterize them. Thanks to a synergistic relationship between public and private interests, these organized groups could stimulate the local economy and generate general well-being. The sustainable intergenerational goal, typical in the «cooperative di comunità», similar exists in the common properties and common goods’ vision. Furthermore, in common properties, representatives able to combine conservative measures with no-stop economic/environmental evolution processes are relevant. Consequently, after the 2017 reform and past negative experiences with local public administrations as common property representatives, the «cooperative di comunità» could represents a solution to protect and manage common properties and common goods.
GIOIA MACCIONI
L’agricoltura sociale: profili di tutela tra sostenibilità, inclusione, esigenze di rinnovamento [approfondisci]
Nel corso del tempo, l’agricoltura sociale si è presentata sotto molteplici forme, confluendo sotto la medesima «etichetta», tuttavia essendo caratterizzata da approcci, relazioni intersettoriali, finanziamenti diversi tra loro. A questo proposito, si pensi solo alle esperienze c.d. di farming for health («agricoltura per la salute»), care farming, green care o green therapies («terapie verdi») riferibili alle cure, al reinserimento, alla riabilitazione o altro; e, da alcuni anni, la discussione si è rafforzata. Di certo, l’agricoltura sociale include un vasto range di attività. La legge italiana 18 agosto 2015, n. 141 («Disposizioni in materia di agricoltura sociale»), «promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole» (art. 1, «Finalità») e il d.m. n. 12550 del 18 dicembre 2018, stabilisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 141/2018. Il saggio esamina le dinamiche europee e nazionali, delineando l’importanza di una regolazione strategica e suggerisce di guardare con attenzione le premesse, le ragioni, le tecniche e le conseguenze della «soft law» (Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie», 2013/C 44/07) o di una «soft regulation» come metodo di governance.
During the past, social agriculture has appeared under many different aspects, all considered in the same way as («social agriculture»), but however being characterized by different approaches, intersectorial relations and forms of funding. About this think of the so-called experiences as «farming for health», «care farming», «green care» and «green therapies» relating to the care, social reintegration, rehabilitation and much more; and, in the last few years the debate has been strengthened. Certainly, social farming includes a broad range of different practices. The italian law 18 agosto 2015, n. 141 («Disposizioni in materia di agricoltura sociale»), «promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole» (art. 1, «Finalità») and m.d. no. 12550 of 18th december 2018 establishes minimum requirements and procedures relating to the social farming activities referred in the art. 1, paragr. 1 of l. no. 141/2015. The essay examines the european and domestic dynamics, outlining the importance of strategic regulation and suggests to consider with attention the premises, the ratios, the technics and the consequences of «soft law» (Opinion of the European Economic and Social Committee on «Social farming: green care and social and health policies», 2013/C 44/07) or a «soft regulation» as a method of governance.
LORENZA PAOLONI
La filiera agroalimentare «etica» e la tutela del lavoro [approfondisci]
Il saggio affronta alcune questioni relative alla certificazione etica della filiera agroalimentare con particolare riguardo alla componente del lavoro. Vengono analizzati alcuni aspetti dell’utilizzo del lavoro irregolare per la produzione di derrate alimentari, in Italia e nel mondo, ed alcune esperienze virtuose. Il consumatore odierno avverte l’esigenza di avvalersi di una filiera agroalimentare sostenibile, anche sotto il profilo del lavoro, ed è disposto a riconoscere il valore aggiunto che la certificazione etica può attribuire al processo produttivo.
The essay addresses some issues relating to the ethical certification of the agri-food chain with particular regard to the work component. Some aspects of the use of irregular work for the production of food, in Italy and around the world, and some virtuous experiences are analyzed. Today’s consumer feels the need to make use of a sustainable agri-food chain, al-so from the point of view of work, and is willing to recognize the added value that ethical certification can attribute to the production process.
TIZIANA RUMI
Il pegno rotativo «agricolo» nel decreto Cura Italia [approfondisci]
Nell’ambito delle misure volte a fornire sostegno economico alle realtà produttive del Paese, il decreto Cura Italia ha dedicato diverse disposizioni al settore agricolo e (a quello) della pesca. Tra le misure volte a garantire la liquidità delle imprese agricole, l’art. 78, comma 2 duodecies del decreto citato prevede il pegno rotativo sui prodotti DOP e IGP, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose. Alla disamina di questo istituto sono dedicate le pagine del saggio che si sofferma, in particolare, sui rapporti tra il nuovo pegno rotativo agricolo e le garanzie similari preesistenti (pegno sui prosciutti e sui prodotti lattiero-caseari a lunga stagionatura, pegno agricolo disciplinato dal d.lgs. n. 102/2004) e sulla possibilità ed opportunità di applicare al nuovo pegno, quale species del genus pegno non possessorio, anche la disciplina introdotta dalla legge n. 119/2016.
In the context the measures aimed to provide economic support to the productive realities of the State, the Cura Italia decree has dedicated various provisions to the agricultural and the fishing sector. Among the measures aimed to ensure the liquidity of agricultural enterprises, the Art. 78, Paragraph 2 duodecies of the mentioned decree provides for the revolving pledge on PDO and PGI products, including wine products and spirit drinks. The essay dedicated to the analysis of this institute, which focuses, in particular, on the relationship between the new agricultural revolving pledge and the similar pre-existing guarantees (pledge on hams and long-matured dairy products, agricultural pledge governed by the Legislative Decree N. 102/2004) and on the possibility and opportunity of applying to the new pledge, as a species of the genus not possessory pledge, also the discipline introduced by the Law N. 119/2016.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
SONIA CARMIGNANI
Sulla persistente validità del consumatore medio [approfondisci]
L’obiettivo del legislatore europeo di perseguire un elevato livello di tutela del consumatore, pone la questione del parametro di riferimento per gli obiettivi di tutela, ovvero il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. E ciò non perché tale parametro rappresenti certo una novità nel contesto della tutela del consumatore in generale e del consumatore di alimenti in particolare, quanto per riflettere sulla persistente validità del consumatore di alimenti come consumatore medio quale categoria monolitica di riferimento, o se non piuttosto sia possibile individuare diverse e differenti declinazioni di consumatore di alimenti, tali da spezzare la monoliticità della categoria.
The objective of the European legislator to pursue a high level of consumer protection raises the question of the reference parameter for the protection objectives, namely the average consumer, who is normally informed and reasonably attentive and circumspect. And this not because this parameter certainly represents a novelty in the context of the protection of the consumer in general and of the food consumer in particular, but to reflect on the persistent validity of the food consumer as an average consumer as a monolithic category of reference, or if not rather it is possible to identify different variations of food consumer, such as to break the monolithic nature of the category.
2020
[approfondisci]Indice fascicolo 2 - 2020
FRANCESCO AVERSANO
Sul controllo ufficiale nella filiera agroalimentare: antiche questioni e nuovi modelli [approfondisci]
Il saggio affronta alcune questioni relative al controllo ufficiale e, in specie, alle procedure di analisi su matrici alimentari; nel contempo tende a reperire un metodo che possa reggere una visione di princìpi e regole, aperta al sistema del diritto agroalimentare. In tale prospettiva verrà proposta una lettura del reg. UE n. 625/2017 nel contesto delle fonti, trattandosi di un provvedimento destinato a produrre significativi effetti sulle relazioni di filiera, con implicazione dei modelli di responsabilità e della protezione di beni e interessi coinvolti.
The essay deals with some issues related to the official control and, in particular, to the analysis procedures on food matrices; at the same time it tends to find a method that can withstand a vision of principles and rules open to the system of agri-food law. In this perspective, a reading of Reg. EU 2017/625 will be proposed in the context of the sources, as it is intended to produce significant effects on supply chain relations, with the implication of models of responsibility and protection of goods and interests involved.
MARGHERITA BRUNORI
Which pathways for agrobiodiversity in the new CAP reform? [approfondisci]
Il presente contributo riporta una riflessione su come la futura politica agricola comune (PAC) dell’Unione europea possa promuovere la conservazione e l’uso della diversità genetica in agricoltura e la promozione delle varietà agricole locali e tradizionali. A tal fine, lo studio parte dalla definizione di agrobiodiversità e risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (GRFA), quindi offre una panoramica del quadro giuridico internazionale ed europeo che disciplina le GRFA. La parte centrale dell’articolo analizza, alla luce del quadro normativo definito in precedenza, come l’attuale PAC 2014-2020 ha affrontato l’argomento e con quali risultati, per poi confrontarlo con le proposte per la nuova PAC 2020-2027. Il contributo conclude illustrando le necessità di miglioramento della proposta nonché alcune opportunità e buone pratiche per promuovere efficacemente la conservazione e l’uso sostenibile del GRFA.
The present contribution aims to reflect on how the future EU Common Agricultural Policy (CAP) will promote the conservation and use of genetic diversity and local and traditional agricultural varieties. To do so, it will first set the definition of agrobiodiversity and genetic resources for food and agriculture (GRFA), then it will give an overview of the international and European legal framework governing GRFA. The central part of the article will analyse, in the light of the regulatory framework set before, how the current CAP 2014-2020 has addressed the topic, and with what results, then compare it with the proposals for the new CAP 2020-2027. The paper will conclude by illustrating ways for improvement as well as opportunities to effectively promote the conservation and sustainable use of GRFA.
SONIA CARMIGNANI
Ambiente, etica e doverosità [approfondisci]
Il tema della qualificazione giuridica dell’ambiente è affrontato dal punto di vista del dovere della collettività e del singolo, non tanto come dovere di protezione in ossequio all’obbedienza a norme di tutela, quanto piuttosto come obbligo morale prima ancora che giuridico. Le norme prescrittive devono essere accompagnate dall’educazione dei cittadini, perché la tutela ambientale diventi insita nel sistema indipendentemente dall’essere prodotto dell’aderenza a regole di comportamento imposte dal legislatore.
The issue of the legal qualification of the environment is dealt from the point of view of the duty of the community and of the individual, not so much as a duty of protection in respect of obedience to protection rules, but rather as a moral rather than legal obligation. The prescriptive rules must be joined to citizen education, so that protection becomes inherent in the system regardless of whether it is product of adherence to rules of conduct imposed by law.
ANTONIO JANNARELLI
Il mercato agro-alimentare europeo [approfondisci]
Il saggio analizza la moderna problematica relativa alla disciplina dei mercati agro-alimentari nella prospettiva del diritto comparato. A tale fine, in premessa, il saggio ripercorre le vicende economico-giuridiche degli ultimi decenni: il rilievo fondamentale che attualmente riguarda la c.d. food security in relazione alla food safety che dal 2008 ha costituito il nuovo fronte della competizione tra i diversi food regimes a livello planetario. La riattenzione per l’agricoltura, quale fonte primaria della produzione alimentare, evidenzia la necessità di confermare e meglio assicurare il c.d. eccezionalismo agricolo al fine di proteggere i produttori agricoli e, al tempo stesso, permettere che vi sia una produzione agricola sufficiente per la crescente domanda alimentare. Su questa premessa che permette di evitare confusioni tra diritto agrario e diritto alimentare, il saggio imposta i problemi relativi alla tutela dei farmers nella catena alimentare ponendo l’accento sulla esigenza di rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori.
The essay analyzes the modern problems relating to the regulation of agro-food markets in the perspective of comparative law. To this end, in the introduction, the essay traces the economic and juridical events of the last decades: the fundamental importance that currently concerns the so-called food security in relation to food safety which since 2008 has constituted the new front of competition between the various food regimes at a global level. The re-attention for agriculture, as the primary source of food production, highlights the need to confirm and better ensure the so-called agricultural exceptionalism in order to protect agricultural producers and, at the same time, allow for sufficient agricultural production for growing food demand. On this premise that allows to avoid confusion between agricultural law and food law, the essay sets the problems related to the protection of farmers in the food chain by placing the emphasis on the need to strengthen the bargaining power of farmers.
STEFANO MASINI
Profili di responsabilità dell’imprenditore agricolo: dall’economia corporativa a quella circolare [approfondisci]
L’esame della responsabilità estesa del produttore, incardinata nella disciplina europea in materia di economia circolare, consente di individuare profili peculiari di applicazione con riguardo alle modalità di progettazione eco-compatibile che definiscono l’organizzazione della filiera agroalimentare. È da ritenere che sull’imprenditore agricolo debba gravare il dovere di tener conto del maggior rischio della attività, che si traduce in determinati costi ambientali – a partire da quelli di fine vita dei prodotti – così da rendersi disponibile ad un orientamento sostenibile del ciclo biologico. Piuttosto che una risposta ad una lesione dell’altrui interesse tutelato, la messa a punto di un sistema di controllo ecologico risponde, dunque, alla realizzazione di forme di cooperazione nella filiera e all’intervento sul versante del consumo. Così come, il richiamo alla disciplina sulla sicurezza alimentare consente di scorgere una fonte di responsabilità che origina dalle scelte del processo economico attraverso l’obbligo di un costante monitoraggio delle condizioni di rischio dell’alimento e di comunicazione e informazione lungo i rapporti di filiera, la rivisitazione in chiave ecologica dell’istituto civilistico della responsabilità dell’imprenditore agricolo fornisce, pertanto, l’occasione per rafforzare la rilevanza sociale della sua attività elevandone, al contempo, il ruolo di custode dei beni ambientali. Su questo piano è possibile, allora, operare il recupero della previsione dell’art. 2088 c.c. e, prima ancora, dell’art. 2137 c.c. che, ponendo un preciso dovere di relazione con l’aspetto collettivo della vita comune, si arricchisce di valori diversi da quelli corporativi, con la definizione di limiti alla libertà di iniziativa economica, dilatando la consapevolezza del modo di produrre e, cioè, stimolando l’adesione ad una gestione doverosa in senso conforme a istanze sociali.
The review of the extended responsibility of the producer, which is embedded in the European regulation on circular economy, allows to identify peculiar implementation profiles with regard to the eco-compatible design methods that define the organization of the agro-food supply chain. It is to be considered that the farmer must bear the duty to take into account the greater risk of the activity, which translates into certain environmental costs – starting from those arising at the end of a product’s life – so as to make themselves available for a sustainable orientation of the organic cycle. Rather than a response to a violation of the protected interests of others, the development of an ecological control system is therefore a reflection of the implementation of forms of cooperation in the supply chain and intervention on the consumption side. In the same way, the reference to the discipline on food safety allows to see a source of responsibility that originates from the choices of the economic process through the obligation of a constant monitoring of the risk conditions of food and of communication and information throughout the supply chain relationships, the ecological review of the Civil law system of the farmer’s responsibility provides, therefore, the opportunity to strengthen the social relevance of their activities while simultaneously elevating their role as guardian of environmental assets. On this level, then, it is possible to refer to the provisions of Article 2088 of the Civil Code and, even before that, of Article 2137 of the Civil Code which, by setting a precise relationship with the collective aspect of common life, is enriched with values other than corporate values, with the definition of limits to the freedom of economic initiative, extending the awareness about production methods and, that is, stimulating the compliance with a rightful management in accordance with social demands.
FILOMENA PRETE
Le attività dell’agricoltura sociale in Italia, tra legislazione regionale e decreto di attuazione della legge nazionale [approfondisci]
Il contributo affronta il tema dello sviluppo dell’agricoltura sociale in Italia alla luce dell’emanazione del d.m. n. 12550 del 18 dicembre 2018, che ha stabilito i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale di cui all’art. 2 comma 1, della legge n. 141/2015. Quest’ultima ha avuto il merito di ricomporre la frammentazione del fenomeno a livello regionale e costruire una cornice di riferimento per le molteplici esperienze di agricoltura sociale sviluppatesi sul territorio nazionale, in particolare negli ultimi venti anni. Il sostegno al fenomeno dell’agricoltura sociale, in assenza di riferimenti normativi specifici, ha preso avvio in Italia nell’ambito dei Piani di sviluppo rurale regionali 2007-2013. Proprio il riconoscimento dell’agricoltura sociale nell’ambito dei PSR e la crescita delle esperienze sul territorio hanno innescato un processo normativo a livello regionale che ha portato diverse Regioni a introdurre una disciplina del settore, anticipando quella statale (all’epoca) ancora in via di definizione. Se da un lato, i provvedimenti normativi emanati a livello regionale offrono una soluzione univoca nel definire il contenuto delle attività di agricoltura sociale, dall’altro, le figure legittimate a svolgere dette attività rappresentano invece un elemento discordante nelle varie normative regionali, e non sempre sono individuate con chiarezza. In questo quadro si procede all’analisi del contenuto del nuovo d.m. n. 12550/2018 e anche a qualche considerazione prospettica in ordine alle proposte relative alla programmazione UE 2021-2027, che prevedono il rafforzamento del tessuto socioeconomico delle zone rurali tra gli obiettivi della nuova politica di sviluppo rurale e sembrano incoraggiare (attraverso il c.d. «nuovo modello di attuazione» o new delivery model) una dimensione di programmazione e governance multilivello e multi-stakeholder che coinvolge tutte le tipologie di attori, sia pubblici che privati, a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
The paper tackles the topic of social farming development in Italy in light of the enactment of M.D. no. 12550 of 18th December 2018, establishing minimum requirements and procedures relating to the social farming activities referred to in Art. 2, Par. 1, of Law no. 141/2015. The latter has recomposed the fragmentation of the phenomenon at regional level and built a frame of reference for the manifold social farming experiences developed on the national territory, particularly in the last twenty years, thanks to a vast network of public and private subjects. This complex and fragmented legislative framework has made it difficult to give a realistic estimate of their development. In fact, in the absence of specific legal references, support to the social farming phenomenon has started in Italy within the 2007-2013 regional Rural Development Plans. Indeed, it was the acknowledgement of social farming in the context of RDPs and the growth of the related experiences on the territory that triggered a legislative process at regional level which lead many Regions to introduce a specific discipline, thus anticipating the national one (still being defined, at the time). If on one side, the regulatory measures issued regionally offer a univocal solution when defining the content of social farming activities, on the other, the subjects entitled to carry out said activities represent a discordant element in the various regional legislations, and are not always identified clearly. In this context, the analysis of the new M.D. no. 12550/2018 is carried out as well as some perspective observations with regard to the proposals for the EU 2021-2027 planning period, which contemplate «strengthening the socio-economic fabric of rural areas» among the objectives of the new rural development policy and seem to encourage (through the adoption of the so called «new delivery model») a multi-level and multi-stakeholders planning and governance dimension, involving all types of actors, both public and private, at EU, national, regional and local levels.
LUIGI RUSSO
Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno [approfondisci]
L’azione di contrasto alle pratiche commerciali scorrette nei contratti della filiera agroalimentare (su cui, a ben vedere, manca una definizione tanto a livello di diritto UE quanto di diritto interno) è stata tendenzialmente lasciata all’attenzione dei legislatori degli Stati membri dell’Unione europea, dal momento che, fino a pochissimo tempo fa, il diritto unionale non contemplava tra le sue priorità un intervento in materia. Fino alla recente dir. UE n. 2019/633 le disposizioni di diritto dell’UE ricollegabili ad una azione di contrasto alle p.c.s. nella filiera agroalimentare hanno assunto, infatti, carattere sporadico e asistematico. In presenza di un concorso di competenze e di un intreccio di disposizioni normative, che verrà presumibilmente ad aumentare a seguito dell’implementazione della dir. UE n. 2019/633 appare, così, opportuno interrogarsi – con specifico riguardo alla normativa italiana – se la disciplina interna volta ad assicurare la parte debole da abusi della controparte possa dirsi conforme a quella unionale, e ciò tanto con riferimento alla normativa UE attualmente vigente, quanto a quella che verrà tra breve ad applicarsi in forza della dir. UE n. 2019/633. Per rispondere a tale quesito, di rilevanza tutt’altro che teorica, come dimostrato dalla recentissima decisione della Corte di giustizia relativamente ai rapporti tra normativa lituana in tema di p.c.s. nel settore lattiero e art. 148, reg. UE n. 1308/2013 (sentenza 13 novembre 2019, in causa C-2/18), occorre, peraltro, primariamente accertare la portata delle norme di diritto UE, alla luce della loro natura gerarchicamente sovraordinata rispetto alle norme nazionali.
The action to combat unfair commercial practices in the agri-food supply chain contracts (on which, in hindsight, there is no definition both at EU and domestic law level) has tended to be left to the attention of the legislators of the Member States of the European Union, since, until very recently, Union law did not include an intervention in this matter among its priorities. Until the recent dir. EU no. 2019/633 the provisions of EU law related to an action to contrast the u.c.p. in the agri-food chain have assumed, in fact, sporadic and asystematic character. In the presence of a shared competence and a mix of regulatory provisions, which will presumably increase following the implementation of the dir. EU no. 2019/633, it seems appropriate to verify – with specific regard to Italian legislation – whether the internal regulations aimed at ensuring the weaker party from abuse by the counterparty can be said to comply with the Union one, and this both with reference to the EU legislation currently in force, as to the one that will shortly be applied under the dir. EU no. 2019/633. To answer this question, with not only theoretical relevance, as demonstrated by the recent decision of the Court of Justice regarding the relations between Lithuanian legislation on u.c.p. in the dairy sector and art. 148, reg. EU no. 1308/2013 (judgment of 13 November 2019, C-2/18), it is also necessary, first of all, to ascertain the scope of EU law rules.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
GIUSEPPE FERRARA
L’apporto della qualifica di IAP alle società agricole: i contrastanti orientamenti della Corte di cassazione [approfondisci]
La disciplina dell’apporto della qualifica di IAP alle società agricole è giustificata, nel caso delle società di persone, dalla contitolarità dell’impresa da parte del socio; nel caso delle società di capitali, dall’esclusiva spettanza all’amministratore del compimento degli atti gestori funzionali all’esercizio dell’impresa agricola. Pertanto, atteso che l’art. 1, comma 3 bis del d.lgs. n. 99/2004 esclude che il solo amministratore possa apportare la propria qualifica di IAP a più società e che tale disposizione deve essere interpretata in coerenza col fondamento della disciplina dell’apporto della qualifica di IAP, necessitata è la conseguenza: la disposizione opera limitatamente alle società di capitali. Dunque, l’IAP che sia socio di una società agricola ed amministratore di una società di capitali agricola, può conferire la propria qualifica ad entrambe le società.
The legislation on the contribution of the IAP qualification at the agriculture companies depends, in the case of companies of persons, from the ownership of the business by the shareholders; in the case of companies limited, from the exclusive responsibility of the administrator about the business manger acts. The Art. 1, subparagraph 3 bis, Legislative Decree n. 99/2004 must be interpreted in accordance with this assumption. Therefore, the rule has to be applied only for limited companies, so that the IAP who is shareholder in a company of persons and administrator in a limited farm company, can make his status to both companies.
ALBERTO GERMANÒ
La ricognizione dello stato della legislazione e della giurisprudenza sugli «usi civici» secondo la Corte costituzionale [approfondisci]
Oltre all’affermazione di illegittimità della legge della Regione Calabria n. 34/2010 per avere dichiarato cessati gli usi civici che insistevano sulle aree comprese nel piano territoriale regionale di sviluppo industriale, la sentenza della Corte costituzionale n. 71/2020 si caratterizza perché, in applicazione della legge nazionale n. 168/2017, afferma che la valenza pubblicistica dei beni collettivi non incide sulla facoltà che gli enti esponenziali delle collettività titolari di detti beni abbiano personalità giuridica di diritto privato: sicché le modalità di gestione dei beni di uso civico sono quelle proprie del diritto privato, ma esse sono legittime soltanto se rientrano nel perimetro fissato dal particolare regime parademaniale degli assetti fondiari collettivi. L’incidenza del rilievo paesistico-ambientale nella disciplina dei domini collettivi e il superamento del principio che essi servivano perché cives ne fame pereant, imprimono alle modalità della loro gestione una dinamicità coerente con l’attuale evoluzione dell’economia agraria.
In addition to the claim of illegality of Law No 34/2010 of the Regional Government of Calabria for having declared that the public use of the areas included in the regional territorial plan for industrial development had been ended, ruling No 71/2020 of the Constitutional Court, in accordance with National Law No 168/2017, states that the public nature of collective assets does not affect the right of the representative bodies of the communities owning those assets to have a private-law legal personality, so that the rules governing the management of assets for public use comply with private law, but they are lawful only if they fall within the scope laid down by the particular state-controlled regime for public property assets. The impact of the importance for landscape and environment in the rules governing public property and the overcoming of the principle whereby they were used because cives ne fame pereant, make their management practices dynamic and consistent with the current development of the agricultural economics.
ALDO NATALINI
Contraffazione di DOP o IGP agroalimentari, tra processo e sostanza: «doppiabilità» del sequestro e rilevanza penale (anche) della violazione del disciplinare [approfondisci]
La nota a sentenza (adesiva) analizza la decisione di legittimità che, intervenendo in fattispecie cautelare reale «sovrapposta» al sequestro a fini di prova di prodotti vitivinicoli IGP (in tesi d’accusa) contraffatti, ribadisce l’autonomia dei due vincoli e, soprattutto, la loro «convertibilità»: evenienza, quest’ultima, rilevante nei procedimenti penali per frode e contraffazione alimentare, la cui complessità spesso non consente al P.M., nelle fasi embrionali dell’indagine, di (richiedere e) ottenere il sequestro preventivo (a fini impeditivi o di confisca) per insufficienza del richiesto standard indiziario, donde la necessità di ricorrere al più agile vincolo probatorio (mantenibile, a rigore, solo fino al completamento delle analisi sull’alimento), trasformabile in misura cautelare solo quando la messe d’accusa si consolida, a meno di non optare per l’alternativa – da preferire, ove possibile, in quanto meno «impattante» sulla res produttiva – del dissequestro «condizionato», declinabile nelle forme del c.d. declassamento merceologico o della regolarizzazone amministrativa in conformità alla legislazione di settore, sempreché la parte interessata vi acconsenta. Viene poi approfondita la parte di diritto sostanziale della pronuncia, ove la Cassazione si sofferma – sia pure ai limitati fini del fumus commissi delicti – sull’esegesi dell’ormai «decenne» delitto di cui all’art. 517 quater c.p., rara avis nella giurisprudenza di legittimità: ampliandone l’ambito applicativo, qui la Corte rassegna un inedito principio di diritto (già affermato nella pregressa giurisprudenza in tema di frode in commercio) che valorizza, a fini punitivi, anche la violazione del disciplinare di produzione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche agroalimentari.
The note to the ruling (attached) analyses the decision of legitimacy which, acting in cases of real precautionary measures «overlapping» with the seizure for the purposes of proof of counterfeit PGI wine products (in the prosecution's case), reaffirms the autonomy of the two constraints and, above all, their «convertibility»: the latter is relevant in criminal proceedings for food fraud and counterfeiting, whose complexity often does not allow the Prosecutor, in the preliminary stages of the investigation, to (request and) obtain the preventive seizure (for impediment or confiscation) due to the inadequacy of the required standard of evidence, hence the need to resort to the most agile evidentiary constraint (maintainable, strictly speaking, only until all food tests have been completed), convertible into a precautionary measure only when the indictment is confirmed, unless opting for the alternative – to be preferred, where possible, as it is less «impacting» on the productive res – of the «conditional» release from seizure, applicable in the forms of the so-called downgrading or administrative regularisation in accordance with sector legislation, provided that the party concerned consents to it. The substantive law part of the ruling is then examined in depth, where the Supreme Court dwells – albeit for the limited purposes of fumus commissi delicti – on the interpretation of the now «ten-year-old» crime referred to in Article 517 quater of the Criminal Code, a rare avis in the jurisprudence of legitimacy: extending its scope of application, here the Court reviews a new principle of law (already affirmed in the previous jurisprudence with respect to the subject of trade fraud in commerce) which values, for punitive purposes, also the violation of the production regulations of the designations of origin and geographical indications for agricultural and food products.
STORIA E DOCUMENTI
FABRIZIO DI MARZIO
Varrone, magistrato e agricoltore [approfondisci]
Questo articolo presenta le relazioni tra la cultura giuridica di Varrone e la sua concezione della vita e dell’agricoltura.
This paper presents the relations between Varro’s juridical culture and his conception of life and agriculture.
2020
[approfondisci]Indice fascicolo 1 - 2020
IRENE CANFORA
I giovani agricoltori e l’obiettivo del rinnovo generazionale nella politica agricola comune 2021-27 [approfondisci]
Uno degli elementi che caratterizzano la Politica agricola comune 2021-27, tuttora in corso di elaborazione, impostata sulla nuova figura dei piani strategici, è rappresentato dall’esigenza di contemperare la competitività dell’agricoltura sul piano globale con le esigenze sociali di conservazione delle attività agricole nelle aree rurali. In questa prospettiva, l’UE identifica alcune categorie di agricoltori, in particolare i giovani agricoltori e i piccoli agricoltori, quali destinatari di speciali misure di sostegno. Il saggio analizza in particolare l’evoluzione delle misure previste per i giovani agricoltori nella proposta di riforma, dal primo e dal secondo pilastro della PAC, focalizzando il ruolo del diritto europeo e degli Stati membri in sede di attuazione nazionale delle misure di sostegno, nella prospettiva di raggiungere gli obiettivi sociali dello sviluppo sostenibile previsti dalla PAC.
One of the key points of Common Agricultural Policy 2021-27, laid down in the draft of the new Strategic Plan regulation is to manage the competitiveness of agriculture with the maintenance of the activities in the rural areas, combining both economic and social issues within the special regulative frame of agriculture. In this perspective, the EU identifies some typology of farmers, in particular young farmers and small farmers as special category, worthy of attention by the EU regulation. The essay analyses the financial measures provided by the draft regulation within the 1st and 2nd Pillar for young farmers, pointing out the role of the EU legislation as well as the Member States implementation, with the aim to reach the social sustainability goals outlined by the CAP.
MARIARITA D’ADDEZIO
Vendita a distanza e altre modalità di vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari: molteplicità di questioni giuridiche e di interessi coinvolti [approfondisci]
Lo scritto considera le forme più attuali di vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari e concentra l’attenzione sui contratti conclusi a distanza attraverso l’impiego di strumenti digitali. L’analisi evidenzia la pluralità di interessi coinvolti, che vanno oltre quelli delle parti negoziali, e le istanze per la tutela di diritti fondamentali individuali e collettivi.
The paper focuses on the most current forms of direct sales and on distance contracts concluded in electronic form concerning agri-food products. The analysis highlights the plurality of interests involved, which go beyond those of the contracting parties, and the requests for protection of individual and collective fundamental rights.
ALESSANDRA DI LAURO
Segni e territorio: quale co-design per quali modelli giuridici? [approfondisci]
Il lavoro delinea una prospettiva di ricerca e di riflessione sui modelli giuridici emergenti nella progettazione dei segni che nel settore agro-alimentare esprimono la qualità e i legami con il territorio (segni del territorio). I modelli esaminati, tra i quali quelli francesi del c.d. sesto segno di qualità Agriculture biologique locale et équitable e quello Haute Valeur Environnementale (HVE), insieme ad altri segni che abbracciano scelte etiche-ecologiche-giuridiche legate alla sostenibilità, consentono contributi creativi di co-produzione e co-design dei modelli, che modificano profondamente i processi di progettazione della norma e i quadri normativi classici della normatività giuridica invitando a superare alcune dicotomie come quelle fra hard law e soft law e/o fra pubblico e privato e inducendo ad interrogarsi sui livelli di governo, le espressioni della democraticità, i luoghi e le modalità di formazione del consenso, le scelte. Il cambiamento dei modelli regolatori in atto induce a chiedersi quale prospettiva regolatoria sia preferibile perché maggiormente capace di accompagnare il cambiamento, di assicurare maggiore democraticità, di esprimere maggiori saperi, di forgiare costrutti più chiari e definiti.
This research work deals with emerging legal models in matter of labels and signs in the agro-food sector that express quality and links with the territory (signs of the territory), including French signs as the so-called sixth sign of quality Agriculture biologique locale et équitable and Haute Valeur Environnementale (HVE), together with other signs that embrace ethical-ecological-legal choices related to sustainability.The models examined are based on innovative co-production and co-design processes that profoundly modify the construction of the norm and the classic regulatory frameworks of legal normativity. This new design process of the norm invites to overcome some dichotomies, like hard law and soft law and/or public and private Law, and leads to question the levels of government, the expressions of democracy, the role of the consent, how it is formed and how choices are made. The change in regulatory models is underway and it is necessary to ask which regulatory perspective is preferable, which is the most able to support change, to ensure greater democracy, to express more knowledge, to forge clearer and more defined rules.
STEFANO MASINI
Dieta e salute. Profili della responsabilità del biologo (nutrizionista) [approfondisci]
L’attribuzione di un significato positivo alla salute inerente alla ricerca di uno stile di vita adeguato anche con riguardo all’apporto soddisfacente di alimenti, concorre a promuovere una domanda di conoscenza che si pone alla base della prestazione del biologo (nutrizionista), le cui competenze risultano più estese rispetto a quelle del medico – quando si tratta di elaborare profili nutrizionali diretti a migliorare lo stato di benessere di persone in salute – ma complementari qualora siano coinvolti stati patologici. Si propongono, dunque, elementi per approfondire profili di responsabilità in conseguenza della perturbazione dei processi fisiologici dell’organismo dipendenti dall’assistenza prestata. In ogni caso, il trattamento dietetico richiede una consapevole collaborazione tra medico e biologo (nutrizionista) ai fini della diagnosi di malattie e del soddisfacimento di bisogni che rendono più complesse le modalità di esecuzione della prestazione rispetto al controllo dei rischi ed alla eliminazione dei disturbi, con evidenti conseguenze sul piano delle responsabilità. Al fine di stabilire l’efficienza causale della condotta rispetto al danno subìto dal paziente si può, dunque, procedere ad una ricostruzione della responsabilità medica, già collaudata nella disciplina vigente, a partire dalla elaborazione di apposite linee guida attraverso cui verificare l’addebito di imperizia anche del biologo (nutrizionista). Tanto più in uno scenario sociale reso più complesso dalla diffusa percezione di rimedi impropri e dalla comune disponibilità al consumo di alimenti che presentano dichiarati effetti salutistici.
Attaching a positive meaning to one’s health as regards the attempt to promote an adequate lifestyle, also in terms of ensuring a suitable food intake, helps to promote demand for knowledge that underpins the role of a biologist (nutritionist), whose skills are more comprehensive than those of a doctor - when it comes to drawing up nutritional profiles aimed at improving the wellbeing of healthy individuals - yet supplementary when pathological conditions are involved. Therefore, the following information is provided to further investigate responsibility profiles as a result of the disruption of the physiological processes of the body which depend on the care provided. In any case, a dietary approach calls for a responsible collaboration between doctors and biologists (nutritionists) for the purpose of diagnosing illnesses and meeting needs that make the provision of the service more complex than controlling risks and treating disorders, with obvious consequences in terms of responsibility. To establish the causal efficiency of such conduct with respect to the damage suffered by the patient, it is therefore possible to reconstruct medical responsibilities, already tested in the current discipline, starting from the elaboration of specific guidelines to verify the burden of inexperience also for biologists (nutritionists). All the more so in a social scenario made more complex by the widespread perception of unsuitable remedies and by the common willingness to consume food with stated health effects.
GEORG MIRIBUNG
Cooperative di lavoro e Regole cadorine: somiglianze e differenze in un confronto [approfondisci]
Il fatto che un regoliere che partecipi con altri regolieri al taglio del bosco della propria Regola riceva il compenso del suo lavoro e goda poi, come membro della collettività regoliera, degli utili della vendita del taglio del bosco spinge a chiedersi se e quanta somiglianza esso abbia con il fatto del socio di una cooperativa di lavoro. Tuttavia, fin dall’inizio è necessario precisare che le somiglianze sono secondarie se messe a confronto con le essenziali differenze tra la Regola e la cooperativa. Partendo dagli elementi identificativi delle cooperative, la parte generale di questo contributo analizza e confronta il rapporto tra persona – cioè socio e regoliere – e organizzazione – cioè cooperativa e Regola – mettendo in luce somiglianze e differenze. Di particolare rilevanza è che entrambi gli istituti si avvalgono di patrimoni appositamente vincolati allo scopo principale perseguito dall’organizzazione. Una differenza fondamentale si trova nel titolo di partecipazione del singolo all’organizzazione, ossia titolo di credito (cooperative) e proprietà (Regola). Nella parte specifica di questo contributo, questa differenza aiuta a mettere in luce le diverse concezioni adottate dal legislatore e le particolarità connesse ad esse. Infatti, nelle cooperative di lavoro troviamo una contrapposizione dell’interesse del socio come lavoratore subordinato, da un lato, e del socio come membro della cooperativa, dall’altro lato, favorendosi la posizione e l’interesse della cooperativa, la quale agisce in nome proprio e gestisce in nome proprio il patrimonio cooperativo, ovverosia le riserve indivisibili. Diversa è la concezione nelle Regole, dove il patrimonio è di proprietà dei regolieri, mentre l’ente gestore compie atti in nome proprio ma sempre atti che hanno effetto sul patrimonio antico e dunque che rientrano nella sfera giuridica dei singoli regolieri. Da questo si evince che l’interesse del regoliere è sempre legato al suo interesse come comproprietario alla conservazione del patrimonio regoliero (che è – per l’esplicito riconoscimento da parte della legge n. 168/2017 – nell’interesse dell’intera collettività nazionale). Dunque, sebbene vi siano sovrapposizioni di funzioni, ciò non deve far dimenticare che questi due istituti giuridici sono fondamentalmente diversi, in quanto una cooperativa, per la sua struttura di base – e con questo intendo il rapporto tra soggetto e oggetto –, si basa sulla volontarietà (che in linea di principio si applica ad ogni rapporto negoziale di diritto privato), mentre le relazioni nella Regola tra oggetto (ambiente) e soggetto (regoliere) sembrano essere indissolubili.
The fact that a Regoliere, who participates with other Regolieri in the cutting of the forest of his own Regola (specific type of commons), receives the remuneration for his work and then enjoys, as a member of the community, the gains from the sale of the cut of the forest, raises the question of whether and how similar this is to the membership of a working cooperative. However, from the outset it is necessary to point out that the similarities are secondary when compared with the essential differences between the Regola and the cooperative. Starting from the identifying elements of cooperatives, the general part of this contribution analyses and compares the relationship between the person – i.e., member and Regoliere – and the organization – i.e., cooperative and Regola – highlighting similarities and differences. Of particular importance is that both institutions make use of assets specifically linked to the main purpose pursued by the organization. A fundamental difference is found in the entitlement of the individual to participate in the organisation, i.e. equity (cooperatives) and ownership (Regola). In the specific part of this contribution, this difference helps to highlight the different concepts adopted by the legislator and the peculiarities related to them. In fact, in worker cooperatives we find a contrast between the interest of the member as an employee, on the one hand, and the member as a member of the cooperative, on the other hand, favouring the position and interest of the cooperative, which acts in its own name and manages the cooperative assets, i.e. the indivisible reserves. There is a different conception in the Regole, where the patrimony is owned by the Regolieri, while the managing body carries out acts in its own name; yet, these have an effect on the patrimony and therefore fall within the legal sphere of the single Regolieri. From this it follows that the Regoliere’s interest is always linked to his interest as owner in the conservation of the patrimony (which is – for the explicit recognition by Law no. 168/2017 – in the interest of the entire national population). Therefore, although there are overlapping functions, it must be kept in mind that these two legal institutions are fundamentally different, since a cooperative, because of its basic structure – and by this I mean the relationship between subject and object – is based on voluntariness (which in principle applies to any negotiated relationship under private law), while the relationships in the Regola between object (environment/patrimony) and subject (Regoliere) tend to be indissoluble.
FEDERICO RASI
L’affitto di azienda agricola, tra tassazione catastale e tassazione analitica [approfondisci]
Il presente contributo analizza il contratto di affitto di azienda agricola per mettere a confronto il suo trattamento fiscale con quello di altre ipotesi contrattuali: l’affitto di fondo rustico e l’affitto di ramo d’azienda. Si coglie così l’occasione per delineare i confini tra redditi fondiari (determinati forfetariamente) e redditi diversi (determinati analiticamente). All’atto pratico la distinzione tra le due ipotesi non presenta contorni così netti come ci si sarebbe potuti attendere e mette in luce profili potenzialmente critici.
The present work examines farm lease contracts to compare their tax treatment with that of other contractual arrangements: the rent of farmland and the rent of a branch of business. This is an opportunity to analyse the differences between cadastral income (determined on the basis of a forfeit regime) and the so-called «other» income (determined analytically). In substance, the distinction between these two cases does not appear to be as clear-cut as it might have been expected and presents some potentially critical issues.
ANTONIO FELICE URICCHIO
Fiscalità alimentare e circolare: problemi e opportunità a seguito dell’introduzione di sugar tax e plastic tax [approfondisci]
Con la l. 27 dicembre 2019, n. 160 sono stati istituiti due nuovi tributi: l’imposta sul consumo di bevande analcoliche (meglio nota come sugar tax) e l’imposta sui manufatti di plastica monouso (meglio conosciuta come plastic tax). Per entrambi i tributi, prevalente rispetto allo scopo di procurare entrate è la finalità extrafiscale la quale va apprezzata soprattutto nella dimensione di limitare o prevenire danni a salute e ambiente, orientando consumo e produzione e rendendolo più consapevole e responsabile. Essi possono ritenersi tributi disincentivanti nei quali l’efficacia nel perseguimento del fine extrafiscale (correzione degli stili alimentari e strategia di produzione) può determinare la riduzione del prelievo, rendendolo persino nullo. Ove, invece, il tributo venga applicato e riscosso, le entrate acquisite possono essere anche utilizzate valorizzando il fine extrafiscale con precisi vincoli di destinazione. Il lavoro illustra le prime disposizioni, ricostruendo natura e funzione dei due nuovi tributi.
With Law no. 160 of 27 December 2019, two new taxes were introduced: the tax on the consumption of soft drinks (better known as sugar tax) and the tax on disposable plastic products (also known as plastic tax). For both taxes, the main purpose rather than generating revenue is a non-fiscal one, which should be appreciated above all for limiting or preventing damage to health and the environment, by directing consumption and production and making them more self-conscious and responsible. These can be considered as disincentives whereby effectiveness in the pursuit of the non-fiscal purpose (adjustment of eating habits and production strategy) can lead to a tax reduction, and even reduce it to zero. If, on the other hand, such taxes are levied and collected, the revenue thus generated can also be used to enhance their non-fiscal purpose with specific allocation constraints. This work illustrates the preliminary provisions, with a description of the nature and function of these two new taxes.
OSSERVATORIO
PRECEDENTE
MARIA AMBROSIO
Sulla «fallibilità» dell’impresa agricola [approfondisci]
Il decreto del Tribunale di Cagliari offre l’occasione per ripercorrere dal punto di vista normativo la questione, risalente, circa la fallibilità dell’impresa agricola e delle storiche ragioni di esenzione da quest’ultima, esaminata alla luce degli orientamenti dottrinali che si sono susseguiti nel tempo fino alla prossima istituzione del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Inoltre, il decreto in esame ha fornito un utile spunto per la trattazione dell’onere probatorio in capo all’imprenditore che intende far valere l’assenza dei presupposti di cui all’art. 1, legge fall.
The decree of the Court of Cagliari offers the opportunity to retrace from a regulatory point of view the question, dating back, regarding the fallibility of the agricultural enterprise and the historical reasons for exemption from the latter, examined in light of the doctrinal guidelines that have followed over time until the next institution of the «corporate crisis and insolvency code». In addition, the abovementioned decree provided a useful starting point for dealing with the burden of proof on the entrepreneur who intends to assert the absence of the conditions set out in Art. 1, Bankruptcy Law.
VITO RUBINO
Ancora sul conflitto fra marchi, indicazione di origine in etichetta e DOP/IGP: il marchio consortile «Altopiano di Asiago» al vaglio della Corte di cassazione [approfondisci]
Questo commento analizza la sentenza della Suprema Corte di Cassazione italiana sul marchio «Altopiano di Asiago», nella quale vengono affrontati due temi fondamentali per la tutela delle indicazioni geografiche nel diritto nell’ordinamento UE: la questione della «evocazione» e quella della sopravvivenza di marchi registrati anteriormente a una DOP/IGP. Con riferimento al primo profilo la Corte richiama la complessa evoluzione della giurisprudenza UE in materia e conclude che il marchio «Altopiano di Asiago» è da considerarsi senz’altro evocativo della DOP «Asiago» in base a tutti i criteri enunciati dalla Corte di giustizia UE. Con riferimento al secondo aspetto, la Corte, preso atto della anteriorità del marchio, ne dichiara possibile la sopravvivenza ex art. 14, regolamento (CE) n. 510/06 affermando che sussiste un interesse anche del singolo operatore a poter vantare l’origine delle proprie merci attraverso l’etichettatura (interesse preso in considerazione anche dal legislatore UE e nazionale, ove si considerino le numerose recenti norme sull’etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari), in ragione del quale si giustifica la registrazione del marchio e la sua salvezza rispetto alla successiva protezione del toponimo come DOP, fatto salvo l’accertamento della buona fede (rimesso al giudice di merito). Il commento finale trae spunto da questo passaggio per sottolineare come la forza crescente della nozione di «evocazione» stia innescando una serie di conflitti sul territorio, a causa della mancanza nella normativa sulla tutela dei prodotti agroalimentari di qualità di una esplicita clausola di flessibilità che consenta l’uso leale e professionalmente corretto del toponimo come mera indicazione di provenienza. La tendenza a leggere la disciplina sulle indicazioni geografiche in chiave monopolistica induce gli operatori del settore a una elevata cautela (id est: ad astenersi anche solo dall’accostamento concettuale dei prodotti generici con quelli DOP/IGP), sacrificando la concorrenza e numerosi diritti fondamentali quali la libertà di espressione e le libertà economiche. L’attuale struttura normativa induce, inoltre, una elevata conflittualità sul territorio stesso di origine, con esiti spesso incerti a causa delle diverse sensibilità dei giudici nazionali sul tema. L’Autore conclude, quindi, la sua analisi auspicando un intervento «manutentivo» delle norme in esame che tenga conto dei diversi interessi in giuoco e, traendo ispirazione dalla giurisprudenza e dalla normativa sui marchi, possa operare un corretto bilanciamento dei diritti e degli interessi in giuoco.
This article analyses the judgment of the Italian Supreme Court (Cassazione) on the trademark «Altopiano di Asiago», that tackles two fundamental issues regarding the protection of geographical indications of food in European Union law: the topic of «evocation» and the conflict between a trademark and a PDO/PGI. Concerning the first point, the Italian Court refers to the ECJ case-law on the notion of «evocation» and concludes that the trademark «Altopiano di Asiago», used for a cheese produced in the specific area of «Asiago» a town in the north-east of Italy, must be considered as an evocation of the PDO «Asiago» based on all the criteria stated by the European Court of Justice in its case-law on the matter. Concerning the second point, given that the trademark «Altopiano di Asiago» was registered before the PDO «Asiago», the Italian Court states that its use can continue in accordance with article 14 of the EC Regulation No. 510/06, also because there is a specific interest of food business operators in showing the origin of their food products, as emerges from the many recent national and EU rules on the origin of foodstuff and/or food ingredients. This specific interest could be protected also through a trademark if it had been registered in good faith before the PDO/PGI in question. The Author’s final remark highlights that the increase in the protection of geographical indications in EU law (and, in particular, the expanding area of application of the concept of «evocation») is leading to many conflicts within the same territory, considering the lack of a clear «flexibility» clause in the general rules on the protection of PDO/PGI related to the fair and lawful use of a toponym in the labelling to give a general indication of the provenance of the foodstuff. The «monopolistic» reading of the GI regulations leads food business operators to change their behaviour (i.e.: to refrain from any possible juxtaposition with PDO/PGI) but this effect can lead to a limitation of some fundamental rights, such as freedom of expression and economic freedoms, or can increase judicial conflicts to safeguard the economic interests of competitors (with uncertain results, considering the different approaches of national judges to this topic). Finally, the Author remarks that it appears desirable a regulatory solution to this problem, which implies an update of the current regulatory framework in the same direction of trademark case-law and regulatory experience.
2019
[approfondisci]Indice fascicolo 3 - 2019
MARIAGRAZIA ALABRESE
La prospettiva internazionale della tutela dei vini di qualità [approfondisci]
Il settore vitivinicolo italiano negli ultimi due lustri si è caratterizzato per una importante crescita tanto nella produzione che nella commercializzazione. A tale successo corrisponde un notevole utilizzo delle indicazioni geografiche dei nostri territori da parte di un sempre più grande numero di produttori stranieri. Sui mercati esteri, dunque, non è inconsueto trovare vini che usano una denominazione d’origine del nostro Paese pur non provenendo dal territorio richiamato da tale denominazione. Ciò avviene non solo e non sempre in maniera fraudolenta, dal momento che, in virtù della normativa presente in alcuni Paesi, tali pratiche possono qualificarsi come pienamente legittime. L’articolo affronta la nota problematica della protezione internazionale delle indicazioni geografiche dei vini attraverso il riferimento agli strumenti giuridici multilaterali (e in particolare l’Accordo TRIPs) e agli accordi bilaterali conclusi dall’UE con tale obiettivo. Esso riflette sul cambio di strategia, rinvenibile nella politica commerciale dell’Unione che persegue la finalità di proteggere le indicazioni geografiche nell’ambito di trattati di libero scambio molto più ampi rispetto agli accordi bilaterali concernenti solamente la protezione di vini e liquori, ponendo la questione se le recenti modalità rispondano meglio all’ottenimento di una protezione più efficace.
The Italian wine sector in the last decade has been characterized by an important growth in both production and marketing. This success corresponds to a considerable use of the EU geographical indications by an increasingly large number of foreign producers. On foreign markets, therefore, it is not unusual to find wines that use a denomination of origin even though they do not come from the area referred to by this denomination. This happens not only and not always in a fraudulent manner, since, by virtue of the legislation present in some countries, such practices can qualify as fully legitimate. The article deals with the well known issue of international protection of geographical indications of wines through the reference to multilateral legal instruments (and in particular the TRIPs Agreement) and to bilateral agreements concluded by the EU. It reflects on the change of strategy of the Union’s trade policy which pursues the aim of protecting geographical indications in the context of much wider free trade treaties than bilateral agreements concerning only the protection of wines and spirits, raising the question if the new approach better respond to obtaining more effective protection.
LUC BODIGUEL
I sistemi alimentari territoriali e il vino: la scelta del «locale» nel contesto della «mutazione ecologica» del diritto e della politica agricola [approfondisci]
In un momento in cui la discussione sulla necessità di mangiare localmente sta assumendo una nuova dimensione con l’emergenza climatica, non è del tutto escluso che alcuni viticoltori facciano la scelta del «locale». Questa scommessa, basata sulla fattibilità di un sistema di produzione e di commercializzazione viticola fortemente incentrato sul consumo locale, fa parte dell’attuale pensiero sui «Sistemi Alimentari Territorializzati» (SAT). Il suo successo sembra assicurato a priori, dati i legami inscindibili tra il territorio, il terroir, la comunità rurale e il vino. Tuttavia questo legame tra vino e territorio è più ambivalente di quanto sembri. In questo contesto, dobbiamo chiederci come e perché integrare il vino nei SAT.
Whereas the discussion on the need to eat locally is taking on a new dimension with the climate emergency, it is not totally excluded that some winegrowers make the choice of «local». This bet, based on the viability of viticulture production and marketing system firmly focused on local consumption, is part of the current thinking on Territorialized Food Systems. Its success seems a priori assured given the undetachable links between the territory, the terroir, the rural community and wine. Yet, in analysis, this link between wine and territory is more ambivalent than it seems. In this context, we must ask how and why to integrate wine in the SAT.
SONIA CARMIGNANI
Vino e nuove biotecnologie [approfondisci]
La mutagenesi e la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018 pongono all’attenzione le relazioni tra scienza, diritto e sostenibilità, soprattutto in un settore, quale quello vitivinicolo, dove particolarmente sentite sono le nuove sfide legate ai cambiamenti climatici e alla prodizione sostenibile.
The mutagenesis and the sentence of the Court of Justice of 25 July 2018 bring to the attention the relations between science, law and sustainability, especially in a sector, such as the wine business, where the new challenges linked to climate change and sustainable production are particularly felt.
ELOISA CRISTIANI
Dal vino biologico al vino sostenibile? [approfondisci]
Il legislatore europeo qualifica l’agricoltura biologica come un modello di gestione sostenibile dell’azienda agricola. Nel settore vitivinicolo, appena entrata in vigore la normativa sul vino biologico che essenzialmente si richiama ad una sostenibilità di tipo ambientale, sono stati elaborati numerosi disciplinari, sia di carattere privato che con l’intervento di organismi pubblici, che mirano a mettere in luce e garantire anche la sostenibilità economica e sociale dei prodotti o dei processi produttivi. Il contributo mira ad analizzare le caratteristiche di tali iniziative nell’ottica di giungere ad un unico standard di sostenibilità Definire un protocollo unico, che armonizzi le certificazioni esistenti con un linguaggio comune, consentirà ai produttori un migliore posizionamento sui mercati sempre più attenti ai valori della sostenibilità e offrirà maggiori tutele ai consumatori.
European Agricultural law provides the directive for the correct implementation of the organic agriculture model of sustainable farm management. In the wine sector, the legislation on organic wine principally revolves around an environmental sustainability perspective. However, as soon as it came into force, a number of related regulations have been drawn up by both private and public institutions. Differently from the original legislation, the subsequent regulations focus on the economic and social sustainability aspects of wine as a product and of its production process. The present contribute is intended to analyze the characteristics of these initiatives and to suggest a unifying sustainability protocol able to harmonize existing certifications by adopting a shared language; to improve producers position in increasingly sustainability-oriented market; and to increase consumer protection.
ALBERTO GERMANÒ
Usi civici alias domini collettivi: la storia si è fatta e continua a farsi diritto [approfondisci]
L’argomento degli usi civici, altrimenti (ora) detti domini collettivi, ha in sé qualcosa di intrigante, perché conferma che è la «storia» che si fa «diritto». Se la legge n. 168/2017 riconosce che le «norme» che le comunità titolari di domini collettivi si sono date per disciplinare l’uso dei propri beni comuni costituiscono «ordinamenti giuridici primari» – e, quindi, dà conferma che il diritto non è solo quello dello Stato – è la storia degli usi civici che consente di rilevare come il diritto alternativo rappresentato dall’autonormazione di «comunità originarie» si sia formato nel tempo e come oggi esso rappresenti «il punto di una lunga linea che nasce ieri, tocca l’oggi e prosegue spedita verso il domami» (P. Grossi). Più precisamente, il fatto della necessitata sopravvivenza delle comunità che, nell’anno mille o giù di lì, apprendevano e coltivavano disabitati territori soprattutto montani, dette luogo ad una storia di godimento indivisibile e inalienabile di detti terreni che garantivano, appunto, con la loro estensione e la loro intatta trasmissione alle generazioni future, che «i cives ne fame pereantur». E questa storia si tradusse, attraverso «statuti», «laudi», «fabule», nel diritto parademaniale dell’indivisibilità, inalienabilità, inusucapibilità e imprescrittibilità che ha sempre disciplinato e che ancora oggi disciplina i domini collettivi. Siffatto diritto, però, per la storia del duraturo rapporto di solidarietà intergenerazionale intercorrente fra i membri attuali e successivi di tali comunità, oggi in cui il fatto della sopravvivenza fondamentalmente è venuto meno, risulta impregnato dal fatto della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni comuni, sicché si caratterizza per essere un diritto che garantisce il paesaggio e l’ambiente.
The question of civic uses, otherwise (now) called collective domains, has something intriguing in itself, because it confirms that it is «history» that becomes «law». If Law no. 168/2017 recognizes that the «norms» that the communities holding collective domains have adopted to regulate the use of their common goods constitute «primary legal systems» – and, therefore, confirms that the law is not only that of the State – it is the history of civic uses that allows us to note how the alternative law represented by the self-regulation of «original communities» has been formed over time and how today it represents «the culmination of a long line that was initiated yesterday, touching on the present and continuing towards the future» (P. Grossi). More precisely, the circumstance of the necessary survival of the communities that, in the year one thousand or so, acquired and cultivated uninhabited territories, especially in the mountains, gave rise to a history of indivisible and inalienable enjoyment of these lands that guaranteed, precisely, by their extension and their intact transmission to future generations, that the « cives ne fame pereantur». And this history was translated, through «statutes», «laudi», «fabulae», into the para-formal right of indivisibility, inalienability, non-adverse possession and imprescriptibility that has always governed and that still today governs collective domains. Such law, however, given the long-lasting relationship of intergenerational solidarity between the current and subsequent members of these communities, today in which the matter of survival has fundamentally failed, is influenced by the perpetual agro-forestry-pastoral destination of common goods, so that it is characterized by being a right protecting the landscape and the environment.
STEFANO MASINI
Le indicazioni geografiche [approfondisci]
La tutela dei nomi geografici assume, nel settore del vino, una importanza decisiva per lo sviluppo territoriale. Attraverso il riconoscimento di una privativa diffusa, i segni di qualità consentono di sfruttare la serie delle risorse reperibili allo stato di beni comuni e valorizzano gli elementi di identità dei luoghi. Il titolo di protezione risulta, anzi, regolato inizialmente soltanto per i vini di qualità e, diventa oggetto di una continuativa attività di revisione, da parte del legislatore – non più solo domestico – nella prospettiva di rafforzare il valore dei prodotti in termini di rapporto tra territorio e comunità. Assai incisivo è anche l’intervento compiuto dal giudice europeo al fine di rafforzare l’affidamento commerciale fondato sulla qualità nelle fasi della filiera successive alla produzione. In sostanza, i segni di appartenenza sono diventati la leva essenziale di uno sviluppo localmente affidato ad una comunità di produttori capace di intrecciare una rete di iniziative che la società percepisce utile per promuovere benessere e salute. Va detto, peraltro, che l’apertura non regolamentata degli scambi a livello globale produca il rischio di ridurre l’originalità del modello di sviluppo, a fronte del moltiplicarsi di atti di pirateria commerciale, che richiedono una diversa attenzione nel ripristinare il ruolo strategico delle indicazioni geografiche in chiave di identità produttiva e culturale.
The protection of geographical names in the wine sector is of crucial importance for local development. Through the recognition of a broad-based right, quality labels make it possible to exploit the range of resources available as common goods and enhance the identity of places. The protection title is, indeed, initially regulated only for quality wines and, it is subject to ongoing review by the legislator – no longer just domestic – in order to strengthen the value of products in terms of the relationship between the territory and the community. The European Court's intervention to strengthen commercial trust based on quality throughout the post-production chain is also very important. In essence, identification labels have become the fundamental lever for local development entrusted to a community of producers capable of intertwining a network of initiatives that society perceives as useful for promoting well-being and health. It must be said, however, that the unregulated opening up of trade at a global level poses the risk of reducing the uniqueness of the development model, given the proliferation of commercial piracy acts, which require greater attention in restoring the strategic role of geographical indications in terms of productive and cultural identity.
EDOARDO MAZZANTI
La disciplina sanzionatoria vitivinicola fra sussidiarietà e duplicazione [approfondisci]
Il contributo si sofferma sulle sanzioni previste nel Testo Unico del vino alla luce dell’impianto sanzionatorio penale in materia di alimenti. Dall’analisi, emerge la disarmonia tra piano teorico – ove è sancita la prevalenza degli illeciti penali – e piano pratico – che vede la netta predominanza delle sanzioni amministrative. Seguono alcune brevi note su questo rapporto apparentemente invertito.
This paper deals with the sanctions encompassed in the Wine Act in the light of food crimes’ regime. The analysis shows the contrast between the theoretical prevalence of criminal sanctions and the practical preponderance of administrative penalties. A few remarks on this seemingly inverted relationship conclude the work.
SILVIA ROLANDI
Cambiamento climatico e vino. Spunti di riflessione per l’adattamento [approfondisci]
Il riscaldamento climatico esiste e sta velocemente peggiorando. Il comparto agricolo ha una alta incidenza sul cambiamento climatico. Allo stesso tempo, l’innalzamento delle temperature provoca effetti negativi su molte produzioni agricole. Il settore vitivinicolo subisce particolarmente gli effetti del cambiamento climatico, sia per l’innalzamento che per la variazione delle temperature. Per questo motivo è il caso di studio esaminato in questo articolo dove si considerano in dettaglio gli impatti del cambiamento climatico, si identificano possibili aree di intervento per politiche tese all’adattamento della produzione alle variazioni attese della temperatura, e si suggeriscono interventi legislativi mirati.
Global warming exists, it is accelerating, and the magnitude and variability of its impacts will rapidly increase over time. The agricultural sector considerably contributes to climate change. At the same time, raising temperatures poses a threat to vines and wine cultivation and production. This sector is likely to be particularly exposed to the impacts of climate change as both temperatures increases and variations affect vines and wine growing and transformation. In this work, we consider the vines and wine sector as a case study, dissecting the consequences of global warming, analyzing the possible adaptation policies and suggesting possible solutions that can be achieved throughout targeted legislative interventions.
ANDREA SABA
Blockchain e vino: una nuova frontiera [approfondisci]
Le nuove tecnologie possono offrire un supporto al settore vitivinicolo per rispondere alle sfide che si appresta ad affrontare nel prossimo futuro. La tecnologia blockchain permette di creare un registro distribuito e architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tale da consentire la registrazione di dati, non alterabili e non modificabili. Il presente lavoro esplora l’impiego della tecnologia blockchain nel settore vitivinicolo e le potenzialità offerte dalla tecnologia in termini di trasparenza e di miglioramento nelle relazioni commerciali.
New technologies can support the wine sector in addressing the challenges that it is facing in the near future. The blockchain technology allows to create a distributed and architecturally decentralized ledger on cryptographic basis, such as to allow the recording of data, which cannot be altered or modified. This work explores the use of blockchain technology in the wine sector and the emerging opportunities in terms of transparency and improvements in commercial relations.
GIULIANA STRAMBI
Dalle «strade del vino» all’enoturismo alla ricerca della qualità [approfondisci]
Con decreto del 12 marzo 2019 il MIPAAFT ha emanato «Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica», in attuazione della legge di bilancio 2018 che ha definito normativamente l’enoturismo. Considerando che fin dagli anni 1999-2000 nell’ordinamento italiano esiste una disciplina statale sulle «strade del vino» come forma di «offerta enoturistica», in seguito dettagliata a livello regionale, l’articolo individua gli elementi caratterizzanti tale disciplina al fine di esaminare le motivazioni che hanno indotto il legislatore statale a intervenire nuovamente nel settore del turismo del vino regolando l’attività enoturistica e gli effetti che ne possono derivare sul sistema delle «strade».
The Agricultural Ministerial Decree of 12 March 2019 established Guidelines on the requirements and minimum quality standards of «enotourism activities» to implement the «2018 Budget law» which legally defined «enotourism». Considering that since 1999-2000, «wine roads» as a form of «wine tourism» has been regulated under Italian state legislation and subsequently also regulated at regional level in detail, the article examines the elements characterizing the legislation to identify the reasons for new wine tourism legislation and their potential consequences on the Italian «wine roads».
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
ANDREA GRECO
Il caso dei sorbetti contenenti champagne [approfondisci]
L’intervento affronta il tema dell’impiego commerciale dei segni di qualità rispetto ad alimenti composti, partendo dalla sentenza della Corte di giustizia dell’UE sul caso «Champagner Sorbet». Ai fini della legittimità dell’impiego commerciale di una denominazione di origine, nella denominazione di vendita di alimenti composti, non conformi al disciplinare della DO, occorre che l’ingrediente di qualità conferisca all’alimento finale una caratteristica essenziale, valutabile in genere in termini di qualità organolettiche.
The speech addresses the topic of commercial use of quality terms in case of compound foodstuff, starting from the CGUE judgment «Champagner Sorbet». The use of a designations of origin as part of the name under which a foodstuff is sold, and where that foodstuff does not correspond to the product specifications for that protected designation of origin, is lawful when the ingredient which does corrispond to those specifications give to the final product essential characteristics evaluable as organoleptic qualities.
STEFANO MASINI
Perdurante rilevanza penale della vendita di cannabis: funzione nomofilattica e orientamento di un «giudice a Berlino» [approfondisci]
Chiamate a risolvere il contrasto apertosi, in seguito all’entrata in vigore della l. 2 dicembre 2016, n. 242 Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, in ordine alla natura stupefacente dei prodotti derivanti, in particolare, da resine e infiorescenze, le Sezioni Unite penali approdano ad una interpretazione sostanzialmente sterilizzante che lascia irrisolto il problema del necessario raccordo con le norme del testo unico in materia, per quanto riguarda la percentuale di principio attivo (THC) reinvenuto non nelle piante oggetto di coltivazione, bensì negli stessi prodotti immessi in commercio. L’orientamento pare suscettibile di alcune critiche in ragione della frammentazione dell’iniziativa economica intrapresa a seguito dell’innovazione disciplinare, che registra il modificarsi di diffuse istanze economiche e sociali anche tenuto conto del palese contrasto con lo schema organizzativo dell’impresa agricola, limitando la sfera di liceità operativa allo sfruttamento delle risorse naturali, ma impedendo l’accesso al mercato delle produzioni ottenute. D’altra parte, si obietta che l’utilizzo di un criterio tabellare possa legittimamente determinare la qualificazione dei prodotti della cannabis quali sostanze stupefacenti al di là della stessa misurazione del principio attivo; mentre occorre promuovere la verifica della reale attitudine a provocare effetti del genere al fine di ammettere la rilevanza penale di ogni singola condotta in ragione della concreta offensività. Altrimenti, la ricerca della colpevolezza finisce per emergere come un intervento che sia soltanto simbolo di lotta.
Called upon to settle the dispute resulting from the entry into force of Law No 242 of 2 December 2016 on the promotion of the hemp cultivation and agro-industrial chain, with respect to the narcotic nature of the products deriving from, in particular, resins and flowers, the Italian Criminal Court has reached an essentially sterile interpretation which leaves the question of the necessary correlation with the rules of the relevant Consolidation Act unresolved, in so far as the percentage of active ingredient (THC) found not in the plants being cultivated, but in the same products placed on the market, is concerned. The approach would seem to be subject to some criticism because of the fragmentation of the economic initiative undertaken as a result of the regulatory changes, which is reflecting the change of widespread economic and social demands also taking into account the obvious contrast with the organization of the farm, limiting operational legitimacy to the exploitation of natural resources, but preventing access to the market of the products thus obtained. On the other hand, it is also claimed that the use of specific criteria can legitimately determine the classification of cannabis products as narcotic substances regardless of the measurement of the active ingredient; while it is necessary to encourage the assessment of the real ability to cause such effects in order to admit the criminal relevance of each individual conduct because of a concrete infringement. Otherwise, finding guilt would end up being a mere symbol of struggle.
2019
[approfondisci]Indice fascicolo 2 - 2019
SONIA CARMIGNANI
Viticoltura e ambiente. La stirpe eroica e storica [approfondisci]
La viticoltura eroica e storica presenta caratteristiche di peculiarità sia sul versante ambientale, paesaggistico e culturale, sia sul versante imprenditoriale, dove la sinergia tra attività economica, ambiente, paesaggio e tutela del patrimonio storico assume connotazioni significative che si riflettono sulla gestione dell’attività di viticoltura.
Heroic and historical viticulture presents characteristics of peculiarity both on the environmental, landscape and cultural side, and on the business side, where the synergy between economic activity, environment, landscape and protection of the historical heritage assumes significant connotations that are reflected in the management viticulture activity.
EDOARDO GAMBARO E PIETRO MISSANELLI
La tutela dei prodotti agroalimentari tra disciplina italiana ed europea: pratiche commerciali sleali e concorrenza estera [approfondisci]
I prodotti agricoli e alimentari tradizionali ed i relativi processi di produzione sono giuridicamente tutelati sia in ambito europeo, tramite la disciplina UE in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche agroalimentari, sia a livello interno, dalla normativa nazionale in materia di proprietà industriale, dal Codice del consumo e dalle norme in materia di concorrenza sleale. Il contributo si propone di illustrare la disciplina della tutela dei prodotti agroalimentari italiani, tramite l’esame della giurisprudenza civilistica rilevante e delle decisioni di autorità amministrative indipendenti. In particolare, verranno affrontati i temi dell’Italian sounding e della tutela offerta dall’ordinamento agli operatori del comparto agroalimentare nei confronti dei fenomeni di «dumping».
Traditional agricultural and food products and related manufacturing process are legally protected both at EU level, through the rules on designation of origin and geographical indications, and at internal level, through national rules on intellectual property, the Consumer Code and rules on unfair competition. The purpose of this work is to illustrate the rules on the protection of Italian agricultural and food products, by means of the analysis of the relevant civil case-law and of decisions of independent administrative authorities. In particular, this work will focus on the topics of Italian sounding and the protection offered to the operators of the agricultural and food sector towards «dumping» phenomena.
ALBERTO GERMANÒ
Alle «soglie» della formulazione dell’art. 2135 del codice civile del 1942 [approfondisci]
Il saggio è la ricostruzione storica delle discussioni dottrinali e delle decisioni giurisprudenziali sulla produzione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli nel periodo a cavallo fra il codice di commercio del 1882 e il codice civile del 1942, nonché sulle considerazioni sottostanti ai progetti di riforma del codice commerciale predisposti, in tempi successivi, dalle Commissioni Vivante (1922), D’Amelio (1925) e Asquini (1940) sino alla formula dell’art. 2135 del nuovo codice civile che è rimasta vigente fino al 2001.
The essay offers a historical overview of the discussions held by legal experts in the literature and of the case law rulings on the production, transformation and sale of agricultural products in the period going from the Trade Code of 1882 up to the Civil Code of 1942. The essay also reports the considerations underlying the draft reforms of the Trade Code made over time by various Commissions: the Vivante (1922), the D’Amelio (1925) and the Asquini Commissions (1940), up to the wording of Article 2135 of the new Civil Code which remained in force until 2001.
MARIA ATHENA LORIZIO
I domini collettivi e la legge n. 168/2017 [approfondisci]
Lo scritto ha per oggetto l’analisi delle tematiche svolte durante il Convegno tenutosi a Colonna di Roma in data 22 settembre 2018 nel quadro della nuova legge n. 168/2017 sui domini collettivi ed in particolare sull’evoluzione dell’istituto nelle diverse aree geografiche italiane, nel passato e nella realtà socio economica attuale.
The script analyze some issues that have been discussed during the meeting in Colonna di Roma, the September 22, 2018, as part of rule n. 168/2017 about «Domini Collettivi» and especially the evolution of institute in different geographic areas in Italy, in the past and in the contemporary society/economy.
STEFANO MASINI
L’abuso nella contrattazione di imprese nella filiera agroalimentare [approfondisci]
L’interesse dell’Unione europea ad esaminare più a fondo le pratiche commerciali e il loro legame con le asimmetrie del potere negoziale nell’ambito della filiera agroalimentare si presenta inizialmente in ragione della verifica dell’andamento dei prezzi dei prodotti capaci di mostrare una diversa e più accentuata vulnerabilità degli imprenditori agricoli rispetto alle parti contraenti responsabili di imporre accordi contrattuali a proprio vantaggio con ripercussioni anche sulla fiducia dei consumatori nel corretto funzionamento del mercato. La dialettica dei rapporti di filiera risulta regolata attraverso accordi così detti verticali, assumendo come protagoniste le organizzazioni di rappresentanza delle categorie, senza correggere le asimmetrie di potere contrattuale tra gli operatori. Mentre più incisivo appare il successivo intervento di contrasto delle condotte sleali ordinate a rimuovere le condizioni di soggezione in cui l’operatore agricolo si trova in mancanza di valide alternative di mercato. La svolta impressa dal legislatore europeo va, tuttavia, nella direzione di guardare al programma contrattuale in termini conformi alla razionalità oggettiva del mercato, in modo da ripristinare la regolare dinamica della filiera. Il rinvio ad una serie di strumenti in grado di rimuovere l’abuso derivante dalla posizione di dipendenza economica risponde all’obiettivo più generale di costruire adeguate condizioni di sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e di equità nella formazione della catena del valore.
The European Union’s interest in examining commercial practices more closely and how they relate to the uneven negotiating powers of the actors within the agro-food chain appears to be due initially to the verification of the price trends of products that show that agricultural entrepreneurs are in a more vulnerable position compared to the other contracting parties responsible for imposing contractual agreements to their own advantage with repercussions also on consumer confidence in the proper functioning of the market. The dialectic of supply chain relations is regulated through the so-called vertical agreements, where the protagonists are the organizations that represent the various categories, without correcting the asymmetries in the contractual power of the operators. However, the subsequent intervention to contrast unfair conduct aimed at removing the unfavourable conditions for farmers in the absence of valid market alternatives, appears to be more incisive. The action of the European legislator seeks to restore the regular dynamics of the supply chain by considering the contractual program in terms that are consistent with the objective rationality of the market. The reference to a series of instruments that can remove the abuse deriving from the position of economic dependence responds to the more general objective of constructing adequate conditions of food supply security and equity in the formation of the value chain.
LORENZA PAOLONI E MARIANITA GIOIA
Terra e migranti [approfondisci]
Il contributo intende favorire una riflessione sia sulle problematiche generali, di natura globale e locale, relative all’accesso alla terra da parte dei migranti, sia su altri argomenti strettamente connessi al rapporto lavoro-migranti-agricoltura. L’obiettivo è quello di condurre una breve analisi dalla quale possano essere messi in luce criticità e inadeguatezze della normativa vigente ma anche casi virtuosi, con un focus particolare sulla Regione Molise.
The contribution aims to encourage a reflection both on the general problems, of a global and local nature, related to the access to the land by migrants, and on other topics closely related to the labour-migrant-agricultural relationship. The objective is to conduct a brief analysis from which critical issues and inadequacies of the current legislation can be highlighted, but also virtuous cases, with a particular focus on the Molise Region.
VITO RUBINO
Sulle ragioni dell’incoerenza fra il dire e il fare: l’indicazione dell’origine degli alimenti, il mercato interno e il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/775 [approfondisci]
Questo articolo affronta il tema del rapporto fra obblighi di trasparenza sull’origine delle merci e regole del mercato interno dell’Unione europea, assumendo come paradigma giuridico la vicenda dell’esecuzione dell’art. 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, con particolare riferimento al regolamento della Commissione (UE) n. 2018/775 sull’origine dell’ingrediente primario. L’Autore, dopo aver ricostruito il quadro giuridico d’insieme nei suoi presupposti storico-evolutivi, analizza le lacune e le numerose contraddizioni dell’esecuzione del regolamento del 2011, espressione di una mai superata resistenza culturale ed economica degli Stati nord-europei verso la piena discovery delle fasi della filiera nell’etichettatura dei prodotti alimentari. L’analisi consente, peraltro, di far emergere le innumerevoli ambiguità delle istituzioni europee, strette fra il «dire» e il «fare» in una paralizzante incertezza politica e giuridica. L’articolo si conclude, quindi, con una più ampia riflessione sui motivi per i quali questa lettura stereotipata del mercato interno dovrebbe essere abbandonata una volta per tutte, in favore di un approccio più moderno ai problemi di equità sociale e sostenibilità territoriale. L’auspicio è, dunque, un ripensamento della posizione attendista della Commissione (e di numerosi Stati membri), a partire proprio dalla discussione ancora pendente sull’implementazione dell’art. 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che potrebbe conoscere nuovo impulso per effetto del rinnovamento delle principali istituzioni dell’Unione a seguito delle elezioni dello scorso mese di Maggio.
This article analyses the relationship between transparency rules (with regard to country of origin labelling) and the European Single Market regulation, taking as the juridical paradigm the implementation of art. 26 of the EU regulation 1169/2011 (in particular: the regulation of execution of the EU Commission No. 2018/775 laying down rules for the application of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food). The Author, after a description of the historical and evolutionary juridical framework, focuses on the regulatory gap and the many contradiction of the execution of the 2011 regulation on food information to consumers, that are the expression of a cultural resistance of Member States that has not been overcome (in particular: the North European States) to a complete understanding of the steps required in food labelling. The analysis exposes the numerous ambiguities of the European Institutions, with the contrasts between what is «said» and what is «done» which leads to a stalemate of political and juridical uncertainty. The article ends, therefore, with a wider reflection on the reasons for a stereotyped interpretation of the Internal market, that should be abandoned as soon as possible, in favour of a more modern approach with regard to social equity and territorial cohesion. The hope is, in the end, that the EU Commission (and the Member States) will rethink its (their) position, starting from the pending discussion on the execution of article 26 of the EU Regulation No. 1169/2011, that could give a new impulse to the issue after the renewal of the European Institutions this year.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
ALDO NATALINI
Irripetibilità dei rilievi fotografici allegati ai verbali di p.g.: quali ricadute sulla prova dei reati alimentari? [approfondisci]
La nota a sentenza (adesiva) analizza la decisione di legittimità che ha sancito la diretta allegabilità al fascicolo del dibattimento – e, quindi, la piena utilizzabilità a fini di prova – delle fotografie allegate al verbale ispettivo, qualificandoli essi stessi come «atti irripetibili». Dopo una rapida rassegna della giurisprudenza di riferimento, il contributo si conclude con una riflessione sulle potenzialità applicative dell’odierno dictum in tema di prova delle ipotesi di reato alimentari accertabili ictu oculi.
The (adherent) note to the ruling analyzes the decision of legitimacy that established the admissibility of the photographs attached to the inspection report – and, therefore, the possibility of full use as evidence – to the file of the hearing, classifying them as «unrepeatable acts». After a quick review of the jurisprudence of reference, the note ends with a reflection on the potential application of today’s dictum in terms of proof of the hypothesis of food crime ascertainable ictu oculi.
Indice fascicolo 1 - 2019
Atti del Convegno Giovanni Galloni, giurista organizzato a Roma il 16 ottobre 2018
PAOLO GROSSI
Introduzione ai lavori
FRANCESCO ADORNATO
Riflessioni sulla Costituzione
MARCO GOLDONI
Integrazione dell’oggetto con ambiente e alimentazione
2018
[approfondisci]Indice fascicolo 3 - 2018
FRANCESCO AVERSANO
Prodotti del tabacco e alimenti: alla ricerca di simmetrie disciplinari e di princìpi comuni [approfondisci]
A fronte delle differenze, ben note, tra food law e prescrizioni cui è sottoposta la filiera del tabacco nonché dei distinguo per struttura e funzione tra alimenti e derivati del tabacco, ad una più attenta lettura del dato positivo sembra potersi scorgere un tratto affine tra le due legislazioni poste a confronto. L’ipotesi di legami pare giustificata dalla reciproca centralità della persona e dalla utilizzazione di sistemi di protezione (tracciabilità, etichettatura, ecc.) che a ben guardare sono orientati alle medesime finalità. Nondimeno, sintomatico di una connessione tra le discipline è il campo di applicazione delle regole in tema di controllo ufficiale condiviso sulla fase agricola. L’evocazione di una coincidenza dei rispettivi beni tutelati consentirebbe una lettura uniforme delle due aree normative e, al contempo, la possibilità di applicare ad entrambe gli stessi princìpi, primo tra tutti quello di precauzione.
In spite of the differences, well known, between food law and regulations where the tobacco and distinction for structure and function between food and tobacco, it’s fair to behold, upon closer reading of positive, a common trait between two legislations confronted. The hypothesis of links seems justified by the mutual centrality of the human person and the use of protection systems (traceability, labelling, etc.) that ultimately are geared to the same purposes. Nevertheless, symptomatic of a connection between the disciplines is the shared scope of rules on official control on agricultural phase. The evocation of a coincidence of the respective goods protected area regulations would enable a uniform reading and, at the same time, the possibility to apply to both the same principles, first of all the precautionary principle.
SONIA CARMIGNANI
Imprenditore agricolo e prospettive di riforma delle procedure concorsuali [approfondisci]
Nell’ambito delle procedure concorsuali ha da sempre animato la dottrina commercialistica l’esenzione dal fallimento riconosciuta all’imprenditore agricolo, per il quale residuano gli ordinari strumenti civilistici di esecuzione individuale. Il presente articolo prende in esame la proposta di riforma delle procedure concorsuali con l’obiettivo di verificare se e, eventualmente, entro quali limiti il regime di specialità che fino ad oggi ha caratterizzato il mondo dell’impresa agricola è destinato a scomparire in favore di un modello unitario. Nella prima parte sono riportate le motivazioni alla base della differenziazione tra le due figure di imprenditore, evidenziando alcuni profili problematici connessi all’evoluzione che, a quasi ottanta anni dalla codificazione, ha trasformato il volto tradizionale dell’attività agricola, rendendone anacronistica la presunzione di irrilevanza pubblicistica, soprattutto avuto riguardo ai diritti fondamentali, quali la salute e la sicurezza alimentare e ambientale, di cui l’impresa agricola è garante. Nella seconda parte è analizzata la legge delega di riforma delle procedure concorsuali, sottolineando come, sebbene quest’ultima elimini il distinguo delle insolvenze in base allo status – civile, commerciale o agricolo – del debitore, la valutazione della complessità e pluralità dei valori che ruotano intorno all’attività agricola induce a confermare la specificità dell’imprenditore agricolo in tema di modelli di gestione della crisi; specificità che, però, non si traduce più nell’estraneità dell’impresa agricola dalle procedure concorsuali ma nella preferenza di strumenti che assicurino la conservazione dell’azienda. La parte finale dell’elaborato, prendendo atto dell’impatto che l’attività agricola ha sulla collettività, riflette sull’opportunità di promuovere un intervento del legislatore volto ad indurre l’imprenditore a comporre la crisi prima che essa conduca alle conseguenze estreme derivanti dall’irreversibilità dello stato di decozione, segnando così il passaggio da un «diritto di fallire» ad un obbligo di accesso alle procedure concorsuali, che permetta di rintracciare la peculiarità dell’imprenditore agricolo non più soltanto nella perpetuata sottrazione alla liquidazione giudiziale ma anche nell’obbligo ad addivenire ad una composizione assistita della crisi nell’ottica di salvaguardare il complesso aziendale e, di riflesso, gli interessi della collettività.
In the context of the bankruptcy proceedings doctrine discussed at length about the exclusion of farmer from failure, remaining for him only the ordinary individual execution. This work analyzes the test of reform of bankruptcy proceedings, trying to verify if the specific discipline for farmer will be replaced by a common model, able to make more similar the regulation about these two figures of entrepreneur. In the first part are listed the reasons behind this differentiation, highlighting issues linked to evolution of agricultural world, especially in consideration of the new public relevance of agricultural enterprise due to fundamental rights, such as health and food safety and environmental security, defended by agriculture. The second part is focused on reform law of bankruptcy, underlining how, although the elimination of differences about kinds of insolvency, the complexity and variety of values ensured by agricultural enterprise lead to confirm the specialty of farmer about crisis management; specialty not in terms of strangeness but in terms of preference for those instruments that allow to assure the conservation of enterprise, excluding completely all forms of judicial liquidation. In conclusion, this work, taking note of the importance of agriculture for the community, reflects on the advisability of imposing manage the crisis to avoid irreversibility of the state of insolvency. For these reasons we witness the transition from a «right to fail» to an obligation to access to bankruptcy proceedings.
LUCIANA FULCINITI
I domini collettivi tra archetipi e nuovi paradigmi [approfondisci]
Il saggio contiene una lettura critica della legge n. 168/2017 sui «domini collettivi», evidenziando le contraddizioni che introduce nella materia. L’esame della legge è concentrato sulle forme organizzative, distinguendo i nuovi organismi collettivi da quelli precedenti, anche in riferimento alla Costituzione. L’analisi approfondisce la relazione dei domini collettivi quali ordinamenti giuridici particolari, con l’ordinamento generale dello Stato. Il saggio esamina infine la struttura costitutiva dei domini collettivi che si presentano come enti ibridi, dotati di personalità giuridica privata, ma svolgenti attività amministrativa per la gestione pubblicistica dei beni in proprietà collettiva.
The essay contains a critical reading of the law n. 168/2017 on «collective domains», highlighting the contradictions that it introduces in the subject. The examination of the law is focused on the organizational forms, distinguishing the new collective bodies from the previous ones, also with reference to the Constitution. The analysis deepens the relationship of collective domains as particular legal systems, with the general system of the State. Finally, the essay examines the constitutive structure of collective domains that present themselves as hybrid bodies, endowed with private juridical personality, but carrying out administrative activity for the public management of the assets in collective ownership.
PIETRO MASI
La filiera alimentare, l’operatore alimentare, l’alimento [approfondisci]
Lo scritto presenta una angolazione di diritto commerciale in un contesto interdisciplinare attento alla tutela penale degli alimenti. Segnala un quadro normativo articolato e tendente alla transnazionalità, con funzione spesso «promozionale» delle regole, interesse per sicurezza e prevenzione, importante ruolo del dato non giuridico. I tre termini della intitolazione si caratterizzano rispetto alle figure note della produzione e dell’offerta di cibo (l’imprenditore, il professionista, il distributore) ed a quella dei fruitori di alimenti, «deboli» in logica differenziata rispetto alla categoria generale dei consumatori. Si analizzano l’alimento (ad esempio confrontato con il prodotto agricolo), l’operatore alimentare (soggetto rilevante fra l’altro in termini di imputazione di obblighi e di responsabilità), la filiera alimentare (catena in cui si esprime la vita del prodotto collegando soggetti diversi nel confronto con il mercato). Dal collegamento tra i termini medesimi nascono spunti in tema di informazione e tracciabilità, di standard e qualità, di definizione e tutela dell’origine, di rapporti tra alimentazione e salute e di contrasto ad abusi nei comportamenti. Questi ultimi si esprimono anche con contraffazione ed appropriazione di pregi e la vigilanza comporta difficoltà e cautele diverse nel caso dell’«industria alimentare» ed in quello degli altri operatori spesso minori e tecnicamente meno organizzati.
This article investigates the food supply chain, food suppliers and food from a point of view of commercial law, in an interdisciplinary context which regards the legal protection of food. It shows a detailed legal framework, tending towards transnationality, often with a «promotional» function of the rules, an interest in security and prevention, an important role of data which is not of a legal nature. The three terms in the title are characterized by the well-known professional figures in the areas of production, the offer and sales of foods (entrepreneurs, professionals and distributors) and the end users of food, the latter being «weak» in a differentiated logic in comparison to the general category of consumers. The text analyses food products in comparison to for example agricultural products, food operators, which are important players in terms of attribution of obligations and responsibilities, the food supply chain, in which the life cycle of a product is expressed, and that connects various subjects in relation to the marketplace. Connecting these terms, ideas and suggestions arise with respect to information and traceability, standards and quality, defining and protecting origins, the relation between food and health and protection against abusive behavior. Sometimes expressed in counterfeit and misappropriation of qualities, and monitoring this abuse involves different problems and precautions for the food industry compared to other operators who are often smaller and technically less organized.
STEFANO MASINI
«Agromafie»: tipologia criminale e connotazione normativa dell’associazione per delinquere [approfondisci]
L’infiltrazione nel sistema agroalimentare delle attività criminali sollecita un approfondimento della rilevanza del profilo organizzativo e del programma degli autori dei reati. A fronte della necessità di intervenire in sede di riforma della disciplina, facendo emergere la sussistenza di attività delittuose supportate da elementi tipici dell’apparato associativo emerge come i vantaggi competitivi acquisiti da organizzazioni imprenditoriali siano da collocare piuttosto che in chiave tradizionale di controllo del territorio in quello di gestione della filiera, alterando la gara concorrenziale e minacciando i consumatori. Metodo mafioso e tipologie intimidatorie chiedono dunque, di essere ridefinite in un aggiornamento dei criteri di valutazione dell’influenza della criminalità organizzata sul mercato agroalimentare fino a recuperare la prospettiva di perseguire obiettivi di sicurezza attraverso la selezione di adeguati strumenti di intervento.
The infiltration of criminal activities into the agrifood sector commands deeper knowledge about the organizational profile and programme of perpetrators. While it is necessary to introduce reforms in the discipline of this sector so as to bring to light the criminal activities supported by elements that are typical of the structure of associations, it is on the other hand clear that the competitive advantages acquired by business associations are not aimed at the traditional endeavour to gain market share, but at managing the entire supply chain, thus distorting competition and posing threats for consumers. It is therefore most urgent to redefine mafia methods and intimidation modalities so as to gain update the criteria used for assessing the influence of organized crime on the agrifood sector and pursue safety objectives by selecting adequate means of intervention.
PIETRO NERVI
I dominii collettivi nella condizione neo-moderna [approfondisci]
La legge n. 168 del 20 novembre 2017, approvata con votazione unanime sia dall’assemblea del Senato della Repubblica, sia da quella della Camera dei deputati, adottando il termine «ordinamento», colloca definitivamente i dominii collettivi in una situazione politico-giuridica diversa da quella della legge n. 1766/1927. Sembra allora opportuno richiamare l’attenzione sul fatto per cui la legge n. 168/2017 colloca i dominii collettivi nella condizione della «nuova modernità», dal momento in cui il legislatore, ha abbandonato il tradizionale paradigma del sistema degli usi civici posto a fondamento nell’applicazione della legge n. 1766/1927 e propedeutico ad una auspicata fase liquidatoria degli «usi civici», per accogliere, in materia, una nuova concezione che essenzialmente significa rispetto dell’autentico concetto del diritto di uso civico e dell’autonomia delle scelte da parte delle unità familiari e delle imprese nonché delle decisioni nella gestione dei dominii collettivi da parte delle collettività titolari del possesso come sempre sostenuto nella loro longevità storica plurisecolare. In questa sede, sarà esaminata la legge n. 168/2017 sotto quattro diversi profili: il dominio collettivo come entità unitaria; il concetto di autonormazione e tipologia dell’attività amministrativa; il patrimonio collettivo e la gestione patrimoniale; i dominii collettivi come soggetti neo-istituzionali.
By adopting the term «ordinamento» (regulation), Act no 168 of 20 November 2017, which was approved unanimously by the assembly of the Senate of the Republic and by the Chamber of Deputies, unquestionably attributes a different political and juridical status to «domini collettivi» (common property) compared to that set out in Act no 1766/1927. It is worth noticing that with Act no 168/2017 the legislator has modernized the status of common property, bringing it in line with modern times, and abandoned the traditional concept of collective use which lies at the heart of Act 1766/1927. This is the first step towards the elimination of the notion of collective use to replace it with a new concept which acknowledges the authentic meaning of collective use rights and gives recognition to the households, businesses and communities that have exercised ownership rights over such common property for centuries and to their autonomy in managing such property. Act no 168/2017 is examined here from four standpoints: common property as a single entity; the concept of self-regulation and type of administrative activity; common property estates and their management; common property as a new institutional subject.
GIUSEPPINA PISCIOTTA
Brevi riflessioni sul «contratto di affiancamento» in agricoltura [approfondisci]
Il presente lavoro affronta i diversi profili di indagine sollecitati dai commi 119 e 120 della legge n. 205 del 2017 (c.d. legge di stabilità) che introducono nel nostro ordinamento un nuovo tipo contrattuale: il contratto di affiancamento in agricoltura. L’inquadramento della nuova fattispecie contrattuale come contratto a causa mista è, da una parte, il punto di arrivo dell’analisi che ha osservato i singoli elementi essenziali del nuovo contratto e, dall’altra, il punto di partenza sul quale fondare le possibili soluzioni necessarie per colmare le avvistate lacune normative.
The present work deals with the different survey profiles requested by paragraphs 119 and 120 of Law 205 of 2017 (the so-called Stability Law) which introduce a new type of contract into our legal system: Towing contract in agriculture. The classification of the new contractual case as a mixed agreement is, on the one hand, the point of arrival of the analysis that has observed the single essential elements of the new contract and, on the other, the starting point on which to base the possible solutions needed to fill evident regulatory gaps.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
ALBERTO GERMANÒ
La disciplina degli usi civici-domini collettivi nella ricostruzione della Corte costituzionale [approfondisci]
La sentenza n. 113/2018 della Corte costituzionale merita essere segnalata per quattro motivi. Innanzitutto la Corte torma a riesaminare il potere ufficioso del Commissario liquidatore degli usi civici, già da essa dichiarato di eccezionalità transitoria. In secondo luogo afferma che la natura dei beni in proprietà collettiva li fa appartenere all’ordinamento civile, mentre lo scopo della loro tutela paesaggistica li fa rientrare sotto la lett. s) del comma 2 dell’art. 117 Cost. e, quindi, ribadisce che la loro disciplina è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato. In terzo luogo chiarisce il rapporto fra la nuova legge sui domini collettivi e la normativa della legge n. 1766/1927 con riguardo all’assegnazione a categoria dei beni civici, riconoscendo che gli artt. 11 e 12 della legge n. 1766/1927 non hanno più motivo di trovare applicazione in quanto oggi la quotizzazione dei terreni coltivabili è incompatibile con la conservazione ambientale dei domini collettivi. In quarto luogo dichiara l’illegittimità della legge della Regione Lazio n. 1/1986 sulla sostanziale trasformazione in allodio del demanio su cui erano state edificate costruzioni, peraltro condonate oltre i limiti previsti dalla legge nazionale di sanatoria degli abusi edilizi.
The ruling No 113/2018 of the Constitutional Court is worth mentioning for four reasons. First of all, the Court is once again reviewing the unofficial power of the Commissioner responsible for liquidating public-use authorisations, already declared by the Court to be of a transitional exceptional nature. Second, it states that the nature of the goods in collective ownership is such that they are subject to civil law, while the purpose of their landscape protection is to fall within the scope of subparagraph 2, letter s) of Article 117 of the Constitution and, therefore, reiterates that their discipline is the exclusive competence of the State. Thirdly, it clarifies the relationship between the new law on collective domains and the provisions of Law No 1766/1927 with regard to the categorisation of civic property, recognising that Articles 11 and 12 of Law No 1766/1927 no longer have any reason to apply, since today the quotization of arable land is incompatible with the environmental conservation of collective domains. Fourth, it declares unlawful Law No 1/1986 of the Regional Government of Lazio on the substantial conversion into allodion of the State property on which buildings had been built, which has been pardoned beyond the limits laid down by the national law on the amnesty of unauthorized building.
ALBERTO GERMANÒ
Le vicinie del Carso come domini collettivi [approfondisci]
Con la sentenza n. 24978/2018 la Suprema Corte riconosce che le Comunelle-Vicinie dell’altopiano carsico-triestino sono, come organizzazioni familiari montane, titolari di proprietà collettiva dei discendenti degli antichi originari e, perciò, esse, anche in applicazione della legge n. 168/2017 sui domini collettivi, sono sottratte alla legge n. 1766/1927.
With judgement no. 24978/2018, the Supreme Court recognizes that, the mountain family organizations living in the Comunelle-Vicinie of the Trieste-karstic plateau are the owners of the collective property of the descendants of the ancient original owners and, therefore, also in application of Act no. 168/2017 on commons, such property is not subject to the provisions of Act no. 1766/1927.
Indice fascicolo 2 - 2018
STEFANO MASINI
Giovanni Galloni: metodo e insegnamento del diritto agrario [approfondisci]
Galloni ha sempre unito la sua sincera passione politica con la costan-za dell’impegno del giurista. Lo ha fatto, da studioso e, sopra tutto, da docente, mettendo in campo una pregiudiziale di fondo per le norme scritte: le fonti tradizionali della teoria normativa, che non esauriscono la comprensione dei fatti – dei rapporti di forza, dell’etica sociale, dell’evoluzione economica – e so-no matrice autentica di produzione del diritto. Questa scelta diventa assai felice riguardo alle questioni agrarie messe al centro tra passato ed avvenire con uno studio – sono le Sue parole nell’assumere la direzione della rivista Giurispruden-za agraria italiana nel 1984 – che tende ad immettersi direttamente nella ricerca del diritto come vive. Senza la pressione dei casi della vita l’interpretazione del di-ritto sarebbe una operazione meramente meccanica. Così, quando alle soglie del secolo nuovo pulsioni e sollecitazioni delle componenti più attive e respon-sabili della società manifestano per il riconoscimento dei nuovi diritti ad un ambiente sano, a frequentare luoghi ed aree protette, a consumare prodotti che non siano dannosi per la salute, sa mettere in campo, ancora una volta, mezzi e strumenti per orientare la conseguente e coerente interpretazione/applicazione di regole e raggiungere gli scopi che sono già nel solco della nostra Costituzio-ne.
Giovanni Galloni has always combined his sincere political passion with the unwa-vering commitment of a jurist. He did so, as a scholar and, above all, as a teacher, put-ting in place a basic preliminary ruling for written norms: the traditional sources of normative theory, which do not exhaust the understanding of facts – of power rela-tions, social ethics, economic evolution – and are the authentic matrix of law making. This choice became rather favourable with regard to the agricultural issues put at the center of past and future by a study – these were his words when he took over the di-rection of the magazine Giurisprudenza agraria italiana in 1984 – which tends to be a direct input into the search for the law as it is applied. Without the pressure of the cases of life, the interpretation of the law would be a purely mechanical operation. So, when at the dawn of the century new impulses and pressures from the most active and responsible components of society demonstrate for the recognition of the new rights to a healthy environment, to frequent protected places and areas, to consume products that are not harmful to health, he knows how to put in place, once again, means and tools to guide the consequent and consistent interpretation/application of rules and achieve the goals that are already in line with our Constitution.
NICOLETTA FERRUCCI
Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali: una prima lettura [approfondisci]
Il recente d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali ha incisivamente modifico la precedente disciplina della materia per adeguarla alla mutata conformazione della realtà forestale italiana e delle attività ad essa inerenti, oltre che agli impegni assunti in sede UE e internazionale. Il lavoro intende offrire un quadro descrittivo delle novità introdotte dal Testo Unico, in attesa della approvazione dei decreti ministeriali attuativi e della Strategia forestale nazionale.
The recent Act no. 34 of 3rd April 2018, i.e. the Consolidated Text on forests and forest industry, has substantially amended the previous regime of the matter in order to adapt it to the changed structure of Italian forest reality and its relevant activities, as well as to the commitments undertaken at EU and international level. The paper means to provide a picture of changes brought about by the Consolidated Text, as we are still waiting for the approval of ministerial instruments of enforcement and the National Forest Strategy.
ERIC JANSSEN
The agricultural cooperative and its members as a single economic entity from a Dutch perspective [approfondisci]
On 19 June 2017, the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) published a press release on its site stating that «guidance» has been given to the Coöperatieve Neder-landse Bloembollencentrale (CNB). The aforementioned «guidance» is contained in a letter of the same date addressed to CNB . In this letter, the ACM writes: «In short, the request in-cluded a description of the so called Current Trading Method by CNB members working in the flower bulb sector. According to the request, there may be competition risks associated with the Current Trading Method, whereby CNB’s proposal is to discontinue the Current Trading Method and organise the cooperation between growers of flower bulbs in a different way». On the basis of the information provided by CNB and the information known to the ACM about the competitive process in the flower bulb sector, the letter then confirms «that the current practice indeed entails risks of competition law». These risks are, however, greatly reduced by the discontinuation of the «Current Trading Method» and the implementation of the «Pro-posed Trading Method» by CNB. The letter of the ACM is intriguingly vague. What are we talking about? From an interview with two directors of CNB in the «Bloembollenvisie», it can be concluded that the «Current Trading Method» relates to the «current activities within producer organisations». According to the interview, this refers to agreements made by flower bulb growers within producer organisations «about price and area under cultivation», as well as sales of flower bulbs by growers together with other growers. The competition law risks that may be associated with these activities are removed «by establishing a single economic entity in which affiliated growers partially transfer their power of control» . According to the website of CNB, this single economic entity is formed by a «sales company». Acting upon instructions from the affiliated growers, the sales company organises the production with regard to a certain flower bulb cultivar, bundles the supply and sells the flower bulbs produced by the affiliated growers . The «guidance» given by the ACM to CNB is a reason to examine the conditions under which producers of primary agricultural products can form a single economic entity together with the agricultural cooperative of which they are members. This is relevant from a competition law point of view. After all, agreements concluded within a single economic entity are not subject to the cartel prohibition. Firstly, the competition rules in agriculture are briefly discussed. In this context, consideration is also given as to whether agricultural cooperatives receive preferential treatment. Subse-quently, a general description is given as to when a single economic entity exists. After that, the present practice in Dutch agriculture will be examined. Subsequently, it is ex-plained how a single economic entity in the agriculture sector can be shaped. The article ends with a conclusion.
Il 19 giugno 2017, l’autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM) ha pubblicato sul suo sito un comunicato stampa in cui affermava di aver fornito «indicazioni» alla Coöpera-tieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB). Tali «indicazioni» sono contenute in una lettera recante la stessa data indirizzata alla CNB . In tale lettera, l’ACM scrive: «In breve, la richiesta riportava una descrizione del cosiddetto metodo commerciale attuale da parte dei mem-bri della CNB che operano nel settore dei bulbi da fiore. Secondo la richiesta, l’attuale metodo commerciale potrebbe comportare rischi per la concorrenza, in quanto la CNB propone di abolire tale metodo e di organizzare in modo diverso la cooperazione tra i produttori di bulbi da fiore». Sulla base delle informazioni fornite dalla CNB e di quelle di cui dispone l’ACM in merito al processo concorrenziale nel settore dei bulbi da fiore, la lettera conferma «che la prassi attuale comporta effettivamente rischi per il diritto della concorrenza». Tali rischi sono tuttavia fortemente ridotti dalla cessazione del ricorso al «metodo commerciale attuale» e dall’applicazione del «metodo commerciale proposto» da parte della CNB. La lettera dell’ACM è stranamente vaga. Di che cosa stiamo parlando? Da un’intervista con due direttori della CNB sulla «Bloembollenvisie» si può concludere che il «metodo commerciale attuale» riguardi le «attività correnti all’interno delle organizzazioni di produttori». Secondo l’intervista, si tratta di accordi conclusi dai coltivatori di bulbi da fiore nell’ambito di organizzazioni di pro-duttori «riguardanti il prezzo e la superficie coltivata», nonché le vendite di bulbi da parte dei coltivatori unitamente ad altri coltivatori. I rischi derivanti dal diritto della concorrenza che possono essere associati a tali attività sono eliminati «costituendo un’unica realtà econo-mica nella quale i coltivatori affiliati trasferiscono parzialmente il loro potere di controllo» . Se-condo il sito web della CNB, quest’unica realtà economica sarebbe costituita da una «società di vendita». Su indicazione dei coltivatori affiliati, la società di vendita organizza la produ-zione di un determinato cultivar di bulbi da fiore, raggruppa la fornitura e vende i bulbi da fiore prodotti dai coltivatori affiliati . Le «indicazioni» fornite dall’ACM alla CNB offro-no un motivo per esaminare le condizioni alle quali i produttori di prodotti agricoli pri-mari possono costituire un’unica realtà economica unitamente alla cooperativa agricola di cui fanno parte. Si tratta di un aspetto rilevante dal punto di vista del diritto della concor-renza. Dopotutto, gli accordi conclusi nell’ambito di un’unica realtà economica non sono soggetti al divieto di costituire cartelli. In primo luogo, si esaminano brevemente le regole di concorrenza in agricoltura. In tale contesto, si valuta altresì se le cooperative agricole beneficino di un trattamento preferenziale. Successivamente, viene fornita una descrizione generale dell’eventuale esistenza di un’unica realtà economica. In seguito verrà esaminata l’attuale prassi dell’agricoltura olandese. Inoltre, si illustra come si possa formare un’unica realtà economica nel settore agricolo. L’articolo termina con una conclusione.
FRANCESCA LEONARDI
Società benefit nell’angolazione «agro-ambientale» con particolare attenzione a immagine, reputazione e comunicazione [approfondisci]
Nella società benefit l’angolazione agro-ambientale acquista un ruolo pilota. Scopo del lavoro è analizzare i sostanziali vantaggi in termini di immagine e di reputazione derivanti dall’impiego del modello che fa registrare un momento di innovazione nella considerazione della teoria della responsabilità sociale di impresa con la possibilità di realizzare in modo stabile e non occasionale finalità di beneficio comune. Per scongiurare comportamenti scorretti derivanti dall’utilizzo della denominazione «benefit» sono state attribuite all’A.G.C.M. funzioni di controllo in grado di conservare il bilanciamento di interessi fra shareholders e stakeholders.
In the benefit Corporation the agro-environmental angle acquires a pilot role. The purpose of the paper is to analyze the substantial advantages in terms of image and reputation deriving from the use of the model that records a moment of innovation in the consideration of the Corporate Social Responsibility Theory with the possibility of achieving in a stable and non-occasional common benefit. To avoid unfair behavior deriving from the use of the «benefit» designation, the A.G.C.M. has been assigned control functions capable of maintaining the balance of interests between shareholders and stakeholders.
STEFANO MASINI
Il giusto equilibrio tra alimentazione e salute. Dinamica delle regole giuridiche e valore della persona nel consumo [approfondisci]
Nel ripercorrere in chiave storica le diverse declinazioni del termine salute a partire dalla letteratura medica, emerge la complessità di una definizione che, nell’oggi, richiede attenzione per la persona come centro unico ed affatto pecu-liare di interessi, valori e conoscenze maturati non tanto in qualità di consuma-tore destinatario delle regole del mercato, ma come individuo proteso a ricer-care un modello alimentare idoneo a preservare lo stato di salute e, sopra tutto, a migliorare la qualità della vita. Il termine salute inteso come benessere globale può essere individuato partendo dall’analisi del concetto di incolumità pubblica enucleato nel diritto penale per soffermarsi, poi, sugli sviluppi tecnologici e sul-la conseguente diffusione di alimenti funzionali i cui benefici per l’organismo vanno oltre il contenuto nutrizionale. La necessità che sia assicurato ad ogni persona il diritto a vedere soddisfatte le proprie aspettative di consumo sugge-risce, infine, una rilettura della stessa nozione, in chiave costituzionale come di-ritto sociale in grado di fornire gli strumenti utili a riconoscere gli effetti del consumo di alimenti sul singolo individuo.
In going over the different aspects of the word «health» from a historical point of view, beginning from the medical literature, the complexities of a definition become apparent which, in the present day, requires attention for the person as the sole and not at all peculiar focus of interests, values and knowledge acquired not so much as a consumer who is the beneficiary of the rules of the market, but as an individual who aims to look for a suitable nutritional model to preserve his/her state of health and, above all, to improve the quality of his/her life. The word «health», understood as global well-being, can be identified starting from an analysis of the concept of public safety, as set out in criminal law, to then focus on technological developments and the consequent distribu-tion of functional foods whose benefits for the body go beyond their nutritional con-tent. The need for every person to be guaranteed the right to have their expectations of consumption fulfilled suggests, finally, a reinterpretation of the same notion, from a constitutional point of view as a social right able to provide useful tools to recognize the effects of food consumption on the individual.
FABIOLA MASSA
Spigolature sulla normativa in tema di protezione giuridica delle varietà vegetali derivate [approfondisci]
Con la revisione del 1991 della Convenzione UPOV l’ambito di protezione conferito con la privativa al costitutore di una nuova varietà vegetale è stato notevolmente ampliato, venendo a ricomprendere anche il diritto di sfruttamento di tutte le varietà derivate da quella sviluppata e protetta. Tale dilatazione costituisce una peculiarità propria della tutela sui generis accordata alle varietà vegetali, che non trova equivalenti o analogie neanche nel sistema brevettuale, e ha delle ricadute e dei riflessi in termini sia giuridici che pratici su cui il presente studio cerca di fare chiarezza.
With the revision of UPOV Convention realised in 1991 the scope of protection conferred to the breeder developed a new plant variety has been significantly enlarged. It includes now not only the exclusive rights to exploit the variety but also the same rights referred to the varieties derived by the first. This improvement is a peculiarity of the Plant Variety Protection System, not present even in the Patent Protection System, and it has some juridical and practical consequences and effects that this study deeply analyses.
FEDERICO RASI E MARIALUISA DE VITA
La tassazione delle attività enoturistiche: un «sobrio» intervento del legislatore [approfondisci]
La legge di bilancio 2018 estende all’enoturismo il regime fiscale previsto per l’agriturismo vale a dire un regime di tassazione forfetaria sia ai fini IRPEF sia a fini IVA. L’intervento normativo suggerisce non solo l’opportunità di verificare la legittimità di tale equiparazione, ma offre anche l’occasione di analizzare i regimi di tassazione riservati dal legislatore alle attività agricole. L’analisi del T.U.I.R. offre, infatti, un quadro abbastanza frastagliato del quale si vuole analizzare la coerenza, delineando i confini tra i casi in cui appare legittimo il ricorso alla tassazione su base catastale, rispetto a quelli in cui, invece, appare corretto l’utilizzo di metodi forfetari e, infine, rispetto a quelli in cui il reddito deve essere determinato analiticamente. Analoga riflessione merita la disciplina IVA ove, pure il legislatore ha riservato alle attività agricole e a quelle ad esse assimilate regimi speciali di detrazione forfetaria dell’imposta assolta sugli acquisti.
The Budget Law 2018 extends the special tax regime set out for agritourism (i.e. a special forfeit tax regime for both income taxes and VAT purposes) also to wine-tourism. Such new provision offers not only the opportunity to verify if such extension is legitimate and adequate, but also that of examining in depth the taxation regime reserved by the legislator to agricultural activities. The analysis of the Income Tax Act shows, in fact, a jagged framework in which some agricultural activities are taxed on the basis of cadastral values (i.e. figurative income), others on the basis of a forfeit income and some others are taxed on actual income values. It is consequently necessary to understand whether all such possibilities are coherent with the entire tax system. The VAT rules deserve a similar analysis since a flat rate approach is applied to determine the amount of deductible VAT.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
ALBERTO GERMANÒ
L’IRPEG e gli enti gestori di domini collettivi [approfondisci]
Gli enti gestori di domini collettivi anche se soggetti di diritto privato e con beni goduti non dalla generalità dei cittadini del Comune ma dalla comunità dei discendenti degli antichi originari godono dell’esenzione dall’IRPEG? La contraria decisione della Suprema Corte è qui oggetto di critica.
Is there exemption of payment of the IRPEG tax for the bodies that manage collective property even though such bodies are governed by private law and have assets that are enjoyed not by all the citizens of the Municipality but by the community of descendants of the ancient native families? The unfavourable decision of the Supreme Court is criticized here.
NOVITÀ
DONATO CASTRONUOVO
Aldo Natalini, 231 e industria agroalimentare
Indice fascicolo 1 - 2018
SONIA CARMIGNANI
Agricoltura, beni comuni e Terzo settore [approfondisci]
La considerazione dell’attività agricola funzionalizzata all’interesse pubblico in quanto gestore di risorse naturali, cioè di beni comuni, nella prospettiva aperta dagli artt. 118 e 43 Cost. sembra ri-mandare al quadro normativo tessuto dal legislatore europeo e nazionale sul Terzo settore. La disciplina del Terzo settore sembra ricalcare le orme dell’imprenditore agricolo e del suo ruolo non tanto produttivo quanto marcatamente sociale e ambientale. Una simile osservazione non deve, tuttavia, indurre ad equiparare ambiti diversi. La disciplina del Terzo settore, di attuazione degli artt. 118 e 43 Cost., ripercorre la strada già percorsa dall’imprenditore agricolo nella sua emersione come soggetto prestatore di un servizio pubblico, ed estende alla cittadinanza, dun-que ad un contesto estraneo all’imprenditorialità o comunque alle attività economiche svolte per il mercato, il modello agricolo.
The consideration of the agricultural activity functionalized to the public interest as a manager of natu-ral resources, that is of common goods, in the perspective opened by the Art. 118 and 43 of the Constitu-tion seems to refer to the legal framework established by the European and national legislator on the Third sector. The discipline of the Third sector seems to follow in the footsteps of the agricultural entre-preneur and of his not so productive but markedly social and environmental role. Such an observation must not, however, lead to the equation of different fields. The discipline of the Third Sector, of the im-plementation of the Art. 118 and 43 Cost., traces the path already traveled by the agricultural entrepre-neur in its emergence as a lender of a public service, and extends to the citizenship, therefore to a context unrelated to entrepreneurship or in any case to economic activities carried out for the market, the agri-cultural model.
GIUSEPPE FERRARA
I limiti oggettivi e soggettivi dell’attività agrituristica [approfondisci]
L’attività di ricezione ed ospitalità svolta dall’imprenditore agricolo dà luogo all’esercizio dell’agriturismo, quando sono soddisfatti i parametri di connessione della «prevalenza» e «nor-malità» di cui all’art. 2135, comma 3 c.c., oltre che l’ulteriore requisito della «prevalenza dimen-sionale» dell’attività agricola principale fissato dall’art. 4 della legge n. 96/2006. Il criterio di con-nessione dell’art. 2135, comma 3 c.c. implica che anche la società agricola dedita all’agriturismo – art. 2 della legge n. 96/2006 – può utilizzare beni non prevalentemente propri dei soci imprendi-tori agricoli. La legislazione regionale non può ampliare il perimetro di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica fissato dalla normativa statale, pena la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
The receiving and hospitality activities carried out by the farmer, agrees to the agriturismo when satis-fied the connection parameters of the prevalence and normality referred to in Art. 2135, c. 3 c.c., over that the further requirement of the dimensional prevalence of the main agricultural activity ex Art. 4, Law n. 96/2006. The connection criteria of Art. 2135, c. 3 c.c. implies that also the agricultural companies dedi-cated to agriturismo – Art. 2, Law n. 96 – can use no prevalently properties of the agricultural entrepre-neur partner. Regional legislation can’t exploit the connection perimeter between agricultural activity and agrituristic activity fixed by the state legislation, because the violation of Art. 117, c. 2 Cost.
VALERIO FICARI - PAOLO BARABINO
L’impresa agricola e la ristrutturazione dei debiti tributari [approfondisci]
Le modifiche apportate dal legislatore all’art. 182 ter della legge fallimentare sono state l’occasione per valutare come l’imprenditore e le società agricole possano risolvere il proprio indebitamento tributario e previdenziale. In particolare, se da un lato la transazione fiscale ammette ora anche la falcidia dell’IVA e delle ritenute, dall’altro le soluzioni per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale percorribili dall’imprenditore «non commerciale» conservano delle incoerenze quali l’ammissibilità alla ristrutturazione ex art. 182 bis e ter della l.f. pur in assenza del requisito soggettivo della fallibilità e il mancato adeguamento normativo della disciplina della crisi da sovraindebitamento per recepire i più ampi margini di riduzione del debito.
The new Art. 182 ter L.F. represents an opportunity to assess how the entrepreneur and the agricultural companies can settle their tax and social security debt. In particular, now the tax transaction also allows for the reduction of VAT and deduction, but solutions for the agricultural entrepreneur do not always appear coherent with access to solutions conceived for the fallible subject or in the absence of updating of the over-indebtedness crisis.
ALBERTO GERMANÒ
I domini collettivi [approfondisci]
Il saggio contiene un commento ai punti fondamentali della legge n. 168/20127 sui «domini col-lettivi», in particolare rispetto all’art. 2 della Costituzione sulle «formazioni sociali», alla titolarità delle proprietà collettive, alla complessa natura pubblica e privata di siffatte proprietà, al ruolo di tutela del patrimonio naturale nazionale svolto dalle proprietà collettive. Vengono anche formu-late osservazioni in merito: a) al compito delle Regioni di completare il diritto statutario degli en-ti esponenziali di domini collettivi e ciò entro un anno dall’entrata in vigore della legge; b) al compito delle Regioni di prevedere e regolare il procedimento a seguito del quale le comunità titolari di proprietà collettive non ancora organizzate possano assumere la qualità di enti espo-nenziali dei titolari delle dette proprietà e chiedere ed ottenere la personalità giuridica di diritto privato; c) alla necessità che le Regole del Cadore modifichino i loro statuti là dove la qualità di regoliere è riservata ai maschi discendenti delle famiglie degli antichi originari.
The article contains a comment on the fundamental aspects of Act no. 168/2017 on «collective property», in particular with respect to Article 2 of the Constitution concerning «social groups», the ownership of collective property, the complex public and private nature of such properties, and the role that collective properties have in protecting the national natural heritage. Remarks are also made on: a) the task of the Regions to complete the statutory provisions of the exponential bodies of collective property within one year from entry into force of the law: b) the task of the Regions to provide for and regulate the procedure to be followed by the communities that are the owners of collective properties to take on the status of ex-ponential bodies of the owners of said properties and apply for legal personality under private law; c) the need that the Rules of the Cadore Area amend their statutes where they state that the role of Regoliere is reserved to the male descendants of the ancient native families.
ANTONIO JANNARELLI
Dal caso «indivia» al regolamento omnibus n. 2393 del 13 dicembre 2017: le istituzioni europee à la guerre tra la PAC e la concorrenza? [approfondisci]
Il saggio analizza l’evoluzione delle norme contenute nei regg. nn. 1234/2007 e 1308/2013 ed il recente reg. n. 2393/2017 a proposito delle organizzazioni dei produttori e del rapporto tra la lo-ro attività e la disciplina antitrust. Questa evoluzione deriva sia dalla controversia e dalla sentenza sul caso indivia C-671/15 sia dal conflitto sempre più aperto tra il Parlamento europeo e la Commissione in merito al rapporto tra la PAC e la politica di concorrenza.
The essay analyzes the evolution of the rules contained in regg. nn. 1234/2007 and 1308/2013 and the recent reg. n. 2393/2017 concerning producer organizations and the relationship between their activities and competition law. This development stems from both the dispute and the judgment on the endive case C-671/15 and the increasingly open conflict between the European Parliament and the Commission on the relationship between the CAP and competition policy.
PAOLO PASSANITI
La tutela del paesaggio agrario tra conservazione e mutevolezza. Le premesse storiche di un problema attuale [approfondisci]
Il saggio analizza le origini di una questione al centro dell’odierna riflessione del diritto agrario riguardante il paesaggio agrario. Una riflessione che si sviluppa a partire dalla Convenzione europea sul paesaggio del 2000 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, il c.d. Codice Urbani. I nodi concettuali sul paesaggio agrario sono una conseguenza della storia giuridica del paesaggio. All’inizio del Novecento, giuristi pratici amanti dell’estetica iniziano a occuparsi della natura minacciata dalla modernità industriale. La vera svolta normativa avviene con la legge Bottai del 1939 sulle bellezze naturali. Una legge in grado di influenzare anche la lettura dell’art. 9 della Costituzione. Per lungo tempo infatti il paesaggio coincide con le bellezze naturali. Un vero cambiamento avviene soltanto tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, quando matura la coscienza ambientalista. Il paesaggio a questo punto è collegato con la dimensione storico-culturale del territorio. Vi è proprio nel periodo della crisi della civiltà contadina, una prima comprensione del rapporto tra agricoltura e paesaggio. Una comprensione evidenziata anche dall’attenzione per il paesaggio rurale nella tutela paesaggistica in Toscana, nel segno di un distacco rispetto alla concezione estetica.
The essay examines the origins of a matter at the heart of today’s reflection of agricultural law on the agricultural landscape. A reflection which develops from the European Landscape Convention of 2000 and from the «Cultural Goods and Landscape Code» of 2004 «Codice Urbani». Conceptual issues on the agricultural landscape are a consequence of the legal history of the landscape. In the early 1900s, practical Jurists with a particular interest in aesthetics began to take care of nature as it was threatened by industrial modernity. The first legislative milestone was the Bottai Law (1939) on the protection of the natural beauties. A law also able to influence the interpretation of Art. 9 of the Constitution. For a long time, in fact, «landscape» and «natural beauties» were considered to be meaning the same. A real change takes place only during the 1960s and 1970s, when the environmental awareness spreads largely. The landscape at this point is related to the historical and cultural dimension of the land. It is during the crisis of peasant civilization, that an initial understanding of the relationship between agriculture and landscape takes place. An understanding also made visible by the attention to the rural landscape found in landscape protection laws in Tuscany, a clear sign that the mere aesthetical conception was left behind.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
GIANGIORGIO CASAROTTO
L’estensione del diritto di prelazione del confinante qualora il fondo compravenduto sia intersecato da strada poderale [approfondisci]
Il criterio della contiguità materiale tra il fondo oggetto di compravendita e quello del proprietario confinante, escludente l’interposizione di qualsiasi elemento territoriale quali, nello specifico, strade vicinali o canali di irrigazione, assunto dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto di prelazione, non può applicarsi anche per delimitare l’oggetto del diritto nell’ipotesi di vendita di un fondo attraversato da detti elementi territoriali, in quanto ciò condurrebbe a una frammentazione del fondo assolutamente contraria alle finalità perseguite dalla prelazione del confinante.
The criterion of material contiguity between the ground object of the sale contract and the one of the neighbouring owner, that excludes the interposition of any territorial element such as, specifically, private roads or irrigation channels, assumed by the jurisprudence for the recognition of the right of pre-emption, can’t be applied also to delimit the object of the right in the hypothesis of a sale of a ground that is crossed by the aforesaid territorial elements, as this would lead to a fragmentation of the ground that is absolutely contrary to the aims pursued by the pre-emption right of the neighbour.
RICERCHE
ALBERTO GERMANÒ
Pratiche commerciali relative a segni di prodotti agroalimentari [approfondisci]
Si riferiscono sette decisioni di varie Autorità giurisdizionali aventi per oggetto segni identificati-vi di prodotti agroalimentari. Il fil rouge che le lega è il non-rispetto/rispetto del diritto che disci-plina i segni e quindi l’illegittimità/legittimità della pratica commerciale relativa. Così si riferisce del marchio e della sua confondibilità, rispettivamente, fonetica (sentenza IV) o figurativa (sen-tenza VII) con altro marchio anteriormente registrato; dell’ampiezza del pubblico dei consuma-tori di riferimento con riguardo al quale va determinata la distintività o descrittività del segno (sentenza II); della natura di alimento o di medicinale e del legittimo segno del relativo prodotto (sentenza I); dell’italiano sound di un prodotto realizzato all’estero da parte di un imprenditore italiano, del diritto di costui di produrlo fuori dei confini dell’Italia, ma del diritto dei sindacati italiani di criticare siffatta condotta senza timore di commettere diffamazione (sentenza V); della responsabilità dell’imprenditore che diffonde false indicazioni sulla salute, e della non-responsabilità dell’imprenditore che si limita a smerciare i relativi prodotti (sentenza III); del non-rilievo della mancanza di danno economico dei consumatori in caso di falsa certificazione biologica del prodotto agroalimentare (sentenza VI).
Seven rulings on the distinctive signs used to identify food products issued by various judicial authori-ties are reported here The element the rulings have in common is the non compliance/compliance with the law that regulates the use of distinctive signs and hence the unlawfulness/ lawfulness of the relevant trade practice. The rulings concern trademarks that may be confused phonetically (ruling IV) or figura-tively (ruling VII) with a previously registered trademark; the way the distinctiveness or descriptiveness of the sign is determined in targeting consumer groups (ruling II); the nature of the food or medicinal product and the sign that is legitimately used for the relevant product (ruling I); the Italian sound of the name of a product produced abroad by an Italian entrepreneur, the latter’s right to produce it outside of Italy, but the right of the Italian trade unions to criticize such conduct without the fear of incurring in the offence of slander (ruling V); the accountability of the entrepreneur who spreads false information about health and the non-accountability of the entrepreneur who limits himself to selling the products (ruling III); the failure to highlight the economic damage for consumers in case of false certificates stating that an agrifood product is organic (ruling VI).
2017
[approfondisci]Indice fascicolo 3 - 2017
GUSTAVO ZAGREBELSKY
Un concetto costituzionale: sovranità alimentare [approfondisci]
È ormai in moto una rivoluzione del modo di pensare e vivere dell’Occidente industrializzato basato sulla pianificazione delle produzioni e dei consumi alimentari che integra la riappropria-zione del legame tra la vita e la terra. Nella rivendicazione della sovranità alimentare si tracciano, in particolare le linee di un progetto di riorganizzazione dal basso dell’ordine politico ed eco-nomico coerente al riconoscimento della dimensione locale del mercato e delle nuove relazioni delle filiere al fine di garantire non solo equità nella distribuzione dei redditi, ma l’affermazione di diritti sociali delle comunità. Questo percorso non deve, tuttavia, proporsi di sperimentare una soluzione in termini di olismo, alimentando spinte egoistiche e totalitarie entro una logica di liberismo, ma affidarsi all’apertura degli scambi, alla promozione di esperienze collettive, all’indicazione delle diverse responsabilità senza che le singole componenti compromettano l’unità del disegno e senza che l’attuazione uniforme dello stesso spenga le singole specificità.
Once again there is now a revolution underway in the way of thinking and living in the industrialized West based on the planning of food production and consumption that integrates the recognition of the ties between life and land. In claiming food sovereignty a bottom-up reorganization project is being traced of the political and economic order consistent with the local dimension of the market and with the new relationships of the supply chains in order to ensure not only fairness in the distribution of income, but also the assertion of the social rights of the communities. This approach, however, must not set the goal of testing out a solution in holistic terms fuelling selfish and totalitarian drives within a free trade logic but should entrust themselves to the opening up of trade, promotion of collective experiences, indi-cation of the various responsibilities without the individual components undermining the unity of the design while avoiding that uniform implementation may extinguish individual specificities.
ANTONIO BELLIZZI DI SAN LORENZO
Il bene giuridico alimentare [approfondisci]
Questo studio mira a ricostruire le caratteristiche strutturali e funzionali di acqua e cibo quali beni oggetto di diritto indispensabili per soddisfare bisogni essenziali della persona nel quadro della scarsità delle risorse: ne scaturisce una gerarchia di valori vitali, in cui, immediatamente dopo l’aria si trovano l’acqua e il cibo. Ma tali beni essenziali sono esaminati altresì sotto il profi-lo della rilevanza giuridica degli aspetti simbolici e morali coinvolti.
This study aims to reconstruct the structural and functional characteristic of water and food, like things object of right indispensable for satisfying essential needs of person, in the framework of the scarcity of re-sources: water and food results immediately after air in a hierarchy of vital values. But these essential things are examined too from the point of view of the legal relevance of symbolical and aspects involved.
FABRIZIO DI MARZIO
Crisi aziendali e limiti del «diritto fallimentare» [approfondisci]
Il lavoro teorizza il limite del diritto della crisi d’impresa dato dalla secolare evoluzione giuridica del fallimento come esecuzione patrimoniale collettiva sui beni del debitore. In questa visione non è ricompresa la realtà dell’impresa che invece assume un ruolo centrale dipendendo l’insolvenza dell’imprenditore proprio dal malfunzionamento dell’attività di impresa. Una migliore impostazione del diritto della crisi d’impresa dovrà fondarsi sull’impresa come attività e sulla tutela dei diversi interessi che la crisi delle attività economiche mette in pericolo.
This paper theorizes the limits of company bankruptcy law resulting from the century old legal evolution of bankruptcy as «collective enforcement» on the assets of the debtor. This viewpoint does not include the reality of the company, which, instead, takes on a central role since the insolvency of the entrepreneur depends on the malfunctioning of the business activity. A better definition of company bankruptcy law will have to be based on the company as a business and on the protection of the various interests that the crisis of economic activities endangers.
NICOLETTA FERRUCCI
Le attività agro-silvo-pastorali alla luce del nuovo regime dell’autorizzazione paesaggistica (d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31) [approfondisci]
L’incidenza della normativa paesaggistica sull’agricoltura ha da sempre rivelato profili di complessità nella ricerca di strumenti idonei a contemperare la protezione del paesaggio con la tutela dell’attività agricola: ambiguità e atecnicismo hanno connotato le soluzioni adottate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella sua versione originaria e nelle sue modificazioni e integrazioni, tradotte nella esenzione condizionata di alcune tipologie di attività dal regime dell’autorizzazione paesaggistica, o nella soggezione al regime dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. Sull’onda della nuova stagione legislativa che all’insegna della semplificazione mira a snellire l’iter dei procedimenti amministrativi e ad evitare impasse decisionali il legislatore interviene di nuovo in materia con disposizioni che coinvolgono anche le attività agricole al fine di delineare contorni più precisi delle fattispecie esenti dall’autorizzazione e ampliare la gamma di quelle soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Il lavoro analizza le nuove disposizioni per verificarne la idoneità a superare le difficoltà interpretative e applicative legate alle norme previgenti.
The incidence of the landscape law on agriculture always revealed profiles of complexity in the research of suitable instruments to conciliate the landscape protection and the safeguard of the agricultural activity: ambiguities and lack of techniques mainly connoted the solutions adopted by the Code of cultural goods and landscape, in its original version and in its following integrations, traduced in the conditioned exemption of some types of activities from the landscape authorization, or in the subjection to the simplified landscape authorization. In the contest of the new legislative season, whose aim is to simplify the iter of the administrative procedures and to avoid decisional problems, the legislator intervenes again on the dispositions involving also the agricultural activities, in order to outline more precise profiles of the different cases exempt from the authorization, and to enlarge the group of the ones subject to the simplified landscape authorization. This paper analyses the new dispositions to verify their suitability to overcome the interpretation and application difficulties connected to the preceding rules.
SARA LANDINI
Tensioni e innovazioni nel credito agricolo. Una riflessione giuridica. [approfondisci]
Il saggio considera il quadro evolutivo di quelle che sono state indicate nel tempo come le caratteristiche del credito in agricoltura: intervento pubblico, obbiettivi meta-finanziari, rilevanza dello scopo del finanziamento. Vengono evidenziate in particolare alcune tensioni con riferimento al cresciuto livello del rischio creditizio nel settore, legato all’incidenza delle calamità naturali e alla volatilità dei prezzi.
The essay considers the evolutionary framework of those that have been pointed out over time as the characteristics of credit in agriculture: public intervention, meta-financial objectives, relevance of the purpose of funding. In particular, there are some tensions with reference to the increased level of credit risk in the sector, a phenomenon related to the incidence of natural disasters and price volatility.
LUIGI RUSSO
Il contratto di rete tra imprenditori agricoli: un passo avanti e due indietro? [approfondisci]
Dopo un sintetico esame delle specificità normative previste per i contratti di rete in cui partecipino imprese agricole il lavoro si sofferma sul contenuto di un recente parere giuridico adottato dall’Agenzia delle Entrate in ordine a quanto disposto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge n. 116 dell’11 agosto 2014, il quale, all’art. 1 bis, comma 3, ha stabilito che per i contratti di rete costituiti da piccole e medie imprese agricole la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma di rete, «può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete». Le conclusioni contenute nel ricordato parere, infatti, pur se aventi ad oggetto questioni di carattere fiscale, e segnatamente l’individuazione del corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, della fattispecie in esame, risultano conseguenza di un inquadramento di carattere generale, tale da fuoriuscire dai ristretti confini del solo settore fiscale. A questo riguardo il parere evidenzia la ritenuta necessarietà di requisiti ulteriori – rispetto a quelli espressamente delineati dal legislatore – per la sua concreta applicabilità, tali, però, da rendere quest’ultima quale evento del tutto residuale, con conseguente depotenziamento della previsione normativa volta a favorire l’aggregazione in rete delle imprese agricole.
After a short examination of the specific regulations on network contracts for agricultural enterprises, the paper dwells on the contents of a recent legal opinion adopted by the Revenue Agency in pursuance of Legislative Decree no 91 of 24 June 2014 converted into Act 116 of 11 August 2014 with amendments. Article 1-bis, paragraph 3, states that for the network contract set up by small and medium sized agricultural enterprises, the agricultural production deriving from the joint running of activities according to the network program, “can be shared among the parties ion kind with the attribution to each, the quota of product originally agreed in the network contract”. Indeed, the conclusions contained in the mentioned opinion, albeit referring to tax issues, and markedly to the identification of the right tax rules to be applied, for direct taxes and VAT, to the case at hand, are the consequence of a general consideration that goes beyond the narrow boundaries of the tax sector only. In this connection the opinion highlights the necessary requirement of further qualifications, besides those expressly laid down by the legislator, for its application in practice such as to make the latter a residual event with the ensuing non applicability of the provision aimed at facilitating the forming of networks by agricultural enterprises.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
FRANCESCO DIAMANTI
Aliud pro Olio (S.p.A.?). L’operazione «Arbequino» e le nuove frontiere dell’illegal oil blending [approfondisci]
La nota a sentenza (critica, ma in parte anche adesiva) analizza la prima decisione di un caso piuttosto interessante sia per via dell’emersione di nuovi sistemi di frodi altamente sofisticate nel campo dell’olio d’oliva e della sua trasformazione, sia per l’applicazione dell’art. 416 c.p. in contesti leciti d’impresa agroalimentare. La parte finale del contributo racchiude una riflessione sull’utilizzo del diritto penale sostanziale per l’attivazione di strumenti processuali (c.d. diritto penale processualmente orientato).
The note of case (critical, but partly also supportive) analyses the first ruling on a rather interesting case for the appearance of new highly sophisticated fraud systems in the area of olive oil and its processing and for the application of Article 416 of the Penal Code to legal agrofood companies. The final part of the contribution presents some thoughts on the use of substantial penal law to activate trial instruments (so-called trial-oriented penal law).
ALBERTO GERMANÒ
Sul regime delle terre civiche costituenti il paesaggio agrario [approfondisci]
Ancora una volta la Corte costituzionale ribadisce lo stretto legame tra il regime degli usi civici e la tutela del paesaggio agrario costituzionalmente assegnata alla competenza dello Stato. Conse-guentemente è stata dichiarata illegittima la legge della Regione Sardegna n. 5/2016 là dove pre-vede distinte ipotesi di sclassificazione di terreni dal regime demaniale civico in violazione della competenza dello Stato che avrebbe preteso che la Regione Sardegna, con rispetto del principio di leale collaborazione, non avesse, in forza del proprio statuto speciale che le riconosce una competenza legislativa in materia di usi civici, sottratto una parte del patrimonio delle collettività civiche sarde senza avere preventivamente sottoposto la modifica del loro regime alla copianifi-cazione tra Stato e Regione.
Once again the Constitutional Court confirms the close ties between the rules on public uses and protec-tion of the agrarian landscape which is a competence of the State under the Constitution. Consequently Law n. 5/2016 of the Region of Sardinia has been declared to be illegitimate because it provides for two distinct cases where land is removed from State ownership in violation of the competence of the State that expected the Region of Sardinia to comply with the principle of fair cooperation. According to the State, by referring to its special statute that acknowledges its competence over matters of public use, the Region of Sardinia should not have subtracted a part of the Sardinian community public assets without having previously put this question to the State-Region joint-planning body. .
NOTE
STEFANO MASINI
La «globalizzazione» della sicurezza alimentare: a proposito della legge della Repubblica popolare cinese [approfondisci]
Attraverso la prospettiva della comparazione, la ricerca intorno agli strumenti e ai meccanismi messi a punto per garantire la sicurezza degli alimenti mostra la costruzione di un apparato normativo che, pure all’interno di culture e tradizioni diverse, è capace di rispondere a bisogni e aspettative delle realtà di produzione e di consumo, omogenee e contemporanee ai rischi che at-traversano il mercato globale. Al di là dei profili plurali che si possono assegnare alla program-mazione della sicurezza, ai fini della organizzazione degli scambi e delle condizioni di vita della collettività, nell’intreccio tra interessi pubblici e privati, si possono, dunque, cogliere alcuni pro-fili di discontinuità e alcune specifiche varianti che sollecitano meccanismi di cooperazione e in-tegrazione.
Through the comparative approach, research on the instruments and mechanisms developed to ensure food safety shows that a regulatory apparatus has been set up which, albeit within different cultures and traditions, is capable of meeting the needs and expectations of manufacturers and consumers and of facing the risks affecting the global market. Beyond the multiple profiles of safety planning, with a view to the organization of trade and living conditions of the various communities, some trends of discontinuity and some specific variations may be perceived, in the intertwining of public and private interests, that en-courage mechanisms of cooperation and integration.
Indice fascicolo 2 – 2017
NICOLÒ LIPARI
Intorno al ragionamento per principî [approfondisci]
L’idea tradizionale, secondo la quale i principî sarebbero sempre riconducibili al dato normativo formale, sembra oggi superata o comunque in via di superamento, con un percorso evolutivo che procede insieme al tendenziale abbandono del modulo argomentativo incentrato sulla fattispecie. Si tratta allora, per il giurista dei nostri giorni, di imparare a leggere la complessità di contesti mutevoli e i molteplici indici, tra i quali anche gli enunciati normativi, che consentano di ricostruire i principî. La rilevanza dei principî dipende, dunque, dalla stessa evoluzione dell’esperienza sociale, producendosi regole in relazione ai fatti, di volta in volta significativi nell’esperienza giuridica. Per altro verso, l’argomentazione per principî consente, nella realtà ordinamentale dei nostri giorni, la scoperta della stessa normatività del sistema in cui le norme e i principî si trovano a operare.
The traditional idea according to which principles can always be traced back to a formal normative notion, appears to be out-dated, or in the process of being out-dated, through a development process that proceeds together with the abandonment of the argument-based discussion centred on points of fact. Present day jurists need to learn to read the complexity of the ever-changing contexts and multiple indices among which also the normative statements, whereby principles can be reconstructed. The importance of principles, therefore, depends on the evolution of social experience where rules are produced on the basis of facts that are significant in legal experience. On the other hand, in the present-day legal system, arguments based on principles make it possible to discover the normative nature of the system where the norms and principles operate.
FRANCESCO AVERSANO
Le forme di tutela dal dissesto idrogeologico fra programmazione, pianificazione e gestione delle emergenze [approfondisci]
La vita degli alimenti è costantemente scortata dalla presenza di materiali e oggetti, indispensabili per il normale consumo alimentare attraverso la distribuzione.
Nel presente contributo si proverà a inquadrare il rapporto alimento/materiale in una prospettiva preferenzialmente intertestuale, non a scapito di quella intratestuale, alla ricerca di più rassicuranti princìpi di riferimento. Non a caso già nel titolo si è preferito anteporre la parola «alimenti», nell’ottica di orientare il metodo d’indagine sulle diverse criticità che essi incrociano quando, direttamente o indirettamente, collidano con i FMCs.
La disciplina del settore va misurata in rapporto con l’ambiente, il mercato e la persona-consumatore, le cui tutele dal punto di vista sistematico si rafforzano nella macro-aree della food law.
La lettura intertestuale, in concreto, consentirebbe l’afferenza partecipativa di tutte le imprese interessate all’interno della filiera alimentare, anche per i casi di connessione fasica (art. 3, punto 2, reg. CE n. 178/02).
Foods reach the consumer wrapped in materials and objects that are indispensable for them to be marketed. This paper examines the food-material relationship mainly in an inter-textual perspective – without this being detrimental for the intra-textual perspective – in the search for more reassuring principles of reference. It is no coincidence that in the title, the word «foods» is used as an adjective with a view to directing the investigation method towards the various critical aspects that they come up against when, either directly or indirectly, they clash with the FMCs.
The norms that govern this sector should be measured in relation to the environment, the market and the person-consumer, whose protection from a systematic standpoint is strengthened in the macro-areas of food law.
An inter-textual reading would enable the participation of all the undertakings and stakeholders involved in the supply chain that come into contact with each other at any specific stage (Article 3, point 2 EC Reg. 178/02).
RUGGIERO DIPACE
Le forme di tutela dal dissesto idrogeologico fra programmazione, pianificazione e gestione delle emergenze [approfondisci]
La vita degli alimenti è costantemente scortata dalla presenza di materiali e oggetti, indispensabili per il normale consumo alimentare attraverso la distribuzione.
Nel presente contributo si proverà a inquadrare il rapporto alimento/materiale in una prospettiva preferenzialmente intertestuale, non a scapito di quella intratestuale, alla ricerca di più rassicuranti princìpi di riferimento. Non a caso già nel titolo si è preferito anteporre la parola «alimenti», nell’ottica di orientare il metodo d’indagine sulle diverse criticità che essi incrociano quando, direttamente o indirettamente, collidano con i FMCs.
La disciplina del settore va misurata in rapporto con l’ambiente, il mercato e la persona-consumatore, le cui tutele dal punto di vista sistematico si rafforzano nella macro-aree della food law.
La lettura intertestuale, in concreto, consentirebbe l’afferenza partecipativa di tutte le imprese interessate all’interno della filiera alimentare, anche per i casi di connessione fasica (art. 3, punto 2, reg. CE n. 178/02).
Foods reach the consumer wrapped in materials and objects that are indispensable for them to be marketed. This paper examines the food-material relationship mainly in an inter-textual perspective – without this being detrimental for the intra-textual perspective – in the search for more reassuring principles of reference. It is no coincidence that in the title, the word «foods» is used as an adjective with a view to directing the investigation method towards the various critical aspects that they come up against when, either directly or indirectly, they clash with the FMCs.
The norms that govern this sector should be measured in relation to the environment, the market and the person-consumer, whose protection from a systematic standpoint is strengthened in the macro-areas of food law.
An inter-textual reading would enable the participation of all the undertakings and stakeholders involved in the supply chain that come into contact with each other at any specific stage (Article 3, point 2 EC Reg. 178/02).
STEFANO FIORE
La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni ed insuperabili limiti [approfondisci]
Nell’ambito di un nuovo e più ampio intervento avente ad oggetto il contrasto dello sfruttamento del lavoro e della intermediazione illecita (c.d. caporalato), il legislatore ha modificato ed integrato la fattispecie incriminatrice introdotta solo pochi anni prima con l’art. 603 bis c.p. Lo studio si propone di analizzare, sia pure in prima lettura ed in attesa dei riscontri applicativi, le numerose e significative modifiche relative sia alla struttura della fattispecie che alle conseguenze sanzionatorie. Nonostante la novellata disciplina penale presenti alcune apprezzabili novità su entrambi i piani, l’analisi evidenzia il persistere di nodi problematici irrisolti e l’emergere di ulteriori questioni che la prassi applicativa dovrà affrontare.
As part of a new and wider intervention concerning the contrast of the exploitation of labor and of the so called «caporalato», the legislator has amended the offence introduced only a few years earlier in the penal code (art. 603 bis). The study aims to analyze the numerous and remarkable changes relative to structure of the offence and to sanctions. Despite the renewed law present some significant news, the analysis highlights the persistence of unresolved problematic issues and the emergence of other issues that will face practical application.
ALBERTO GERMANÒ
Sulla titolarità dei segni DOP e IGP [approfondisci]
Vi sono Paesi (come gli USA) in cui le indicazioni geografiche (DOP e IGP) non sono disciplinate. In essi vi è, invece, la disciplina dei marchi (sia individuali che collettivi) geografici, la cui registrazione va richiesta dal proprietario (owner). Può capitare che in tali Paesi vengano registrati, come marchi geografici, segni il cui nome è il nome di DOP o IGP europee. Come fare a contrastare tale uso improprio dei nomi DOP e IGP europei? Premesso che, se si vuole registrare come marchi geografici secondo la normativa USA i nomi dei segni DOP e IGP europei è necessario presentarsi come proprietario del segno geografico DOP o IGP, occorre sapere chi sia il titolare dei segni DOP e IGP europei. Su detta titolarità nulla dice il diritto comunitario; nulla dice l’Accordo TRIP’s, nonostante riconosca le indicazioni geografiche come beni di proprietà intellettuale. Nulla espressamente dice il diritto italiano. Invece, il diritto spagnolo indica lo Stato come titolare dei segni DOP e IGP aventi valore in tutta la Spagna.La riflessione conduce a concludere che tanto nel diritto comunitario quanto nel diritto italiano il titolare delle DOP e IGP sia la comunità dei produttori che, però, è una collettività in forma non organizzata, cioè priva di personalità giuridica. Si prospetta, così, che lo Stato italiano, nella sua organizzazione del MiPAAF, sia titolare delle DOP e IGP italiane, non quoad dominium (che è della collettività) ma come quoad iurisdictionem, e come tale possa richiedere, negli Stati Uniti, la registrazione dei nomi DOP e IGP italiani come marchi geografici di certificazione.
There are Countries (like the USA) where not geographic names (PDO – Protected Designation of Origin, and PGI Protected Geographical Indication) but geographic trademarks (individual and collective trademarks) are regulated, and it is the owner who applies for registration. In these Countries it may happen that a sign whose name is a European PDO or PGI are registered as geographic trademarks. What can be done to prevent the improper use of European PDO and PGI names? Considering the fact that under US law, European PDO and PGI signs can be registered as geographic trademarks only by the owners of the PDO and PGI geographic signs, it is indispensable to know who is the owner of the European PDO and PGI signs. Community law says nothing about such ownership; and the TRIPs Agreement says nothing about it, in spite of the fact that it recognizes geographic indications as items of intellectual property. Italian law says nothing precise about such ownership. Instead, Spanish law indicates the State as the owner of the PDO and PGI signs that have recognized validity throughout Spain. The discussion comes to the conclusion that in both Community Law and Italian Law the owner of the PDO and of the PGI is the community of producers who, however are an unorganized collective group, i.e. they have no legal personality. Therefore it is the Italian State, through its organization of the MiPAAF that is the owner of the Italian PDOs and PGIs, not as quoad dominium (that belongs to the community) but as quoad iurisdictionem, and as such may request that the Italian PDO and PGI names be registered in the United States as certified geographic trademarks.
STEFANO MASINI
Frammenti per una storia delle frodi alimentari [approfondisci]
Il tentativo di organizzare una raccolta di materiali intorno al divenire storico del diritto penale alimentare avverte la necessità di evidenziare le ragioni economiche e le pretese sociali delle diverse fasi di evoluzione. Si può, così, riconoscere l’iniziale dimensione simbolica e rituale delle incriminazioni, almeno fino all’esperienza della romanità che, pure, riduce le condotte menzognere, assai frequenti nel commercio, ad un’offesa patrimoniale del privato salvo recuperare successivamente con l’intensificarsi dei traffici commerciali la rilevanza dell’interesse generale alla repressione come reato. La preoccupazione di mettere in moto meccanismi volti a neutralizzare il danno patrimoniale, solo con l’affermarsi dell’ordine corporativo, in una dimensione geografica allargata del mercato, si accompagna alla necessità di repressione del falsum a tutela dell’attività commerciale e dei doveri della fides publica. Le ragioni della speciale incriminazione trascorrono immutate fino alla redazione dei codici preunitari con alcune oscillazioni destinate a riflettersi nella stessa proposta di riforma Zanardelli del 1887. Anche sul versante della tutela della salute la disciplina di contrasto delle sofisticazioni alimentari risulta condizionata dal quadro storico, tanto da avvertire del tutto recente l’emersione dell’interesse della comunità a preservare le condizioni di benessere riguardo ad un pericolo che insidia l’incolumità generale. La razionale sistemazione dei reati si deve alla maturazione del pensiero illuministico, dopo aver messo alle spalle i problemi dell’approvvigionamento alimentare e la rimozione delle condizioni di scarsità di accesso attraverso la configurazione dei delitti di comune pericolo verso un numero indeterminato di vittime la cui salute sia messa a repentaglio; mentre un ulteriore e più adeguata sistemazione ha finito con il riguardare anche le incriminazioni per frode e sofisticazione, confermando come l’esperienza giuridica del penale sia del tutto aderente alle strutture economiche e alla percezione sociale maturata nella contemporaneità del contesto sociale.
The initiative of gathering and organizing the written materials on the historic development of criminal food law needs a premise where a description is provided of the economic reasons and social needs related to the various steps in the evolution of this field of criminal law. We can begin with the initial recognition of the symbolic and ritual dimension of the relevant incriminations, at least up until the Roman civilization which reduced misleading conduct, a frequent occurrence in trade, to the financial offence against the individual; but as commerce grew, offences involving food came to be seen as offences against the community and hence they were repressed as a crime. The concern that led to the adoption of mechanisms to neutralize financial damage to property, that was promoted by the guilds in an enlarged geographic dimension of the market, was accompanied by the need to repress the falsum in order to protect the commercial activities and duties of the fides publica. The reasons for incriminations for food offences remained unchanged up until the drafting of the codes drawn up before the unification of Italy, with some differences that were reflected in the Zanardelli draft reform of 1887. Also with regard to the protection of health, the fight against food adulteration was affected by the historic setting and, indeed, in recent times the community has been particularly concerned about preserving conditions of wellbeing against any danger that may threaten the safety and security of the general public. We owe the rational arrangement of food offences to the thinkers of the Enlightenment, who turned to this task after having taken care of the problems linked to food supply and to the removal of the conditions of scarce access through the configuration of crimes that might endanger the health of an undetermined number of victims. A further and more adequate classification concerned also the incriminations for fraud and food adulteration. This confirms that criminal legal experience reflects the economic structures and the perception of the society that develops within the social context.
ALDO NATALINI
Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato [approfondisci]
La contraffazione agroalimentare è un fenomeno criminale ormai «virale», pervasivo ed assai complesso da investigare: esige perciò standard di professionalità elevatissimi da parte degli organi inquirenti chiamati ad istruire procedimenti (con strumenti normativi peraltro tutt’altro che adeguati) pressoché su ogni comparto merceologico (oleario, vitivinicolo, lattiero-caseario, biologico, ecc.).
Ad uso degli operatori specializzati, ma anche al fine di arricchire – rectius: sollecitare – il dibattito parlamentare sulla riforma Caselli dei reati agroalimentari, si propone una inedita rassegna ragionata sui peculiari percorsi d’indagine e sui mezzi di prova esperibili in subiecta materia, rivelatasi assai diversa – per tecnicismo e difficoltà accertative – rispetto ai consueti approcci operativi praticati nelle aree, pur «limitrofe», della contraffazione industriale o dei reati igienico-sanitari.
Difatti i tratti «somatici» del crimine agroalimentare (fattispecie di criminalità economica, seriali e vittima muta) condizionano le stesse tecniche e strategie investigative del pubblico ministero specializzato, dalla cui prospettiva d’azione è condotta la presente disamina, a partire dalle indagini preliminari fino alla fase dibattimentale.
Oggetto del thema probandum è l’alimento frodato: un corpo del reato sui generis, tecnologicamente complesso e particolarmente vulnerabile e per questo difficile da «maneggiare» processualmente.
Al fine di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la diversità per origine, provenienza e qualità dell’alimento stesso ovvero la sua non genuinità o la sua contraffazione, la rassegna si sofferma nella seconda parte sui principali mezzi di prova esperibili, con particolare riferimento al documento (anche digitale), che riveste ruolo decisivo ed alla prova scientifica (anche con metodiche sperimentali), assai più critica ed a volte persino controproducente.
Counterfeiting in the agri-food sector has now become a «viral criminal phenomenon», which is pervasive and very complex to be investigated: it therefore requires high professional standards by the investigators to instruct procedures (with regulatory instruments, however, far from adequate) on virtually every part of sector, (olive oil, wine, dairy products, organic foods, etc.).
For specialist operators, but also to enrich – or rather: encourage – the parliamentary debate on the Caselli reform of agri-food crimes, a new review of special investigative approaches and available evidence in that field is being proposed, which proved very different – for technical reasons and verification difficulties – compared to the usual operational approaches adopted in «neighbouring» sectors, such as industrial counterfeiting or sanitary offenses.
In fact, the distinctive «features» of agri-food crimes (cases of economic and serial crimes and mute victims) affect the same investigative techniques and strategies of the specialized public prosecutor, from whose perspective this overview is carried out, starting from the preliminary investigation to trial.
The object of the thema probandum is the counterfeit food: a corpus delicti sui generis, technologically complex and particularly vulnerable and therefore difficult to «manipulate» procedurally.
In order to demonstrate beyond reasonable doubt the difference of origin, source and quality of the food itself or its non-authenticity or counterfeiting, the second part of the review focuses on the necessary evidence, with special reference to the document (also in a digital format), which plays a key role and the scientific evidence (even with experimental methods), which is far more critical and sometimes even counterproductive.
VINCENZO PACILEO
L’origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria [approfondisci]
Il legislatore mira a favorire la produzione nazionale sanzionando, anche penalmente, la commercializzazione di prodotti che alludono abusivamente allo loro «italianità». Ciò ha raggiunto talvolta il limite della forzatura del principio di libera circolazione delle merci di marca europea. La giurisprudenza ha, però, chiarito a riguardo dei prodotti industriali che l’origine o provenienza non attiene alla territorialità della produzione, bensì alla riferibilità giuridica a un determinato produttore. Le cose stanno diversamente per i prodotti agroalimentari, che traggono dal territorio le loro specificità qualitative, anche in chiave culturale quale identità del cibo. Peraltro, per i prodotti non a denominazione protetta resta aperto il problema di contemperare la corretta informazione al consumatore con il divieto di discriminazione.
While the abuse of the «Italian sounding» drives heavy negative effects on the national economy, it is difficult to find the legal way to protect really Italian products and at the same time comply with the European rules on the free market. So the national case-law holds that the origin of industrial products depends on the producer accountability rather than the production place. Nevertheless, the case can be different for food, even when registered indications are not implied, because of the physical and cultural connection with specific territories.
Indice fascicolo 1 - 2017
IRENE CANFORA
L’agricoltura come strumento di welfare. Le nuove frontiere dei servizi dell’agricoltura sociale [approfondisci]
La legge n. 141/15 sull’agricoltura sociale introduce nel diritto nazionale una qualifica giuridica delle attività di welfare che si svolgono nell’ambiente rurale, individuando oggetto (servizi ricreativi per l’istruzione e la famiglia, servizi socio-sanitari, servizi di supporto per l’inclusione sociale e l’inserimento dei lavoratori con disabilità e svantaggiati) e soggetti (imprese agricole e cooperative sociali), in funzione delle misure promozionali della legge. La principale novità è rappresentata dall’inclusione delle imprese agricole tra i soggetti e dalla qualificazione come attività connesse ex art 2135 delle attività dell’agricoltura sociale, con l’effetto di estendere i contenuti della multifunzionalità dell’agricoltura verso nuovi ambiti di produzione dei «beni comuni». Tra le misure incentivanti dell’agricoltura sociale, che dovranno tenere conto dell’attuazione da parte delle Regioni, molte delle quali hanno già legiferato in materia, emerge la possibilità di collegare l’attività di servizi di welfare alla qualificazione dei prodotti dell’impresa agricola, in relazione ai valori «etici» espressi dai soggetti economici.
The Law no. 141/2015 on Social Farming laid down a national definition of welfare activities carried out in rural areas, pointing out their content (recreational and educational activities, services for families, healthcare services, integration of disabled workers) as well as the legal entities involved in them (agricultural business and social cooperatives). Thus, the law introduces a change into the activities qualifying agricultural business, for the purpose of article 2135 Civil Code. It follows, that Italian legislation widens the framework of the public goods production made by farms, recognising a further step of multifunctional agriculture: the welfare services.
Among the rules aimed at encourage social farming, the article focuses on instruments related to agricultural food production, enhancing agricultural products on the market through their ethical value. Since the entry into force of the national law, promotional measures could be lawfully implemented by regional legislation, whereas several Regions already provided a legal framework aimed at funding agricultural welfare activities.
NICOLA LUCIFERO
Il «contenimento del consumo del suolo agricolo»: un problema di qualificazione e regolamentazione giuridica [approfondisci]
Il lavoro affronta i problemi giuridici connessi al contenimento del consumo del suolo attraverso le diverse fonti normative, principalmente europea ed interna. In dettaglio, il lavoro si prefigge di mettere in luce talune criticità correlate all’intervento legislativo in corso di definizione con l’obbiettivo di evidenziare come la questione richieda di essere affrontata, non in logica settoriale come fino ad ora è stato fatto, bensì muovendo dalla funzione che il suolo ricopre nelle aree urbane e in quelle agricole e così perseguire finalità di urbanizzazione, ambientali e sociali per le prime, salvaguardando la vocazione produttiva dei terreni agricoli.
The work addresses issues related to the containment of soil consumption through the different sources of law, in particular at the European and domestic level. In detail, the research aims to highlight certain critical issues related to Italian law proposal who is near to be defined, with the scope to highlight how the issue needs to be addressed, not in a sectoral approach as it has been done until now, but moving from the function that the ground covers in the urban areas and in the agricultural area in order to satisfy the urban purposes, environmental and social, and defense the productive vocation of the agricultural area.
CATALDO MOTTA
Sulla disciplina di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro: profili storici e interventi di riforma [approfondisci]
L’autore, all’esito della esposizione della disciplina di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e all’intermediazione illecita nel lavoro (c.d. caporalato) e dell’esame critico delle norme avvicendatesi dal 1949 ad oggi, mira a dimostrarne l’inefficacia e l’inadeguatezza, conseguenti anche ad una tecnica legislativa non esente da censure, e sollecita un ulteriore intervento normativo, proponendo un progetto di riforma di grande respiro, condiviso dall’«Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare», che coniughi repressione e prevenzione, ma senza perdere d’occhio la realtà sociale, da realizzare attraverso interventi fortemente innovativi: per un verso, restituendo alla violenza e alla minaccia, inspiegabilmente trasformate in circostanze aggravanti, il ruolo di elemento oggettivo dei reati previsti dall’art. 603 bis; per altro verso prevedendo un profilo premiale non solo a favore dell’imputato, ma anche della persona offesa che abbia denunciato i fatti e collaborato con l’autorità giudiziaria riconoscendo a quest’ultima il diritto ad essere assunta al lavoro e affiancando all’azione penale nei confronti di chi abbia commesso quei reati la misura di prevenzione del controllo giudiziario da applicare all’indagato nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale, ma soggetta alle proprie regole; e per altro verso ancora escludendo la confisca di immobili, macchinari, attrezzature o strumenti necessari per le lavorazioni, le coltivazioni, la raccolta, la cura, la conservazione del prodotto proprio al fine di non vanificare l’applicazione del controllo giudiziario dell’azienda ostacolandone la funzionalità.
After describing the regulations to counter labour exploitation and illicit intermediation (known as gangmaster system) and as a result of a critical review of the rules that have been passed since 1949, the author aims to demonstrate their ineffectiveness and inadequacy, resulting also from a legislative approach that is not free from criticism, thereby urging further regulatory actions by means of a far-reaching reform project, shared by the «Observatory on crime in agriculture and in the agri-food system», which combines repression and prevention without losing sight of the social reality, to be achieved through highly innovative interventions: on the one hand, violence and threat, which were inexplicably transformed into aggravating circumstances, should be considered as part of the objective element of the offense under art. 603 bis; on the other hand, providing a reward system not only in favour of the accused, but also of the victim who has reported the facts and cooperated with the court recognizing the latter the right to be hired to work and combining prosecution against those who committed those crimes with preventive measures of judicial control over the person under preliminary criminal investigation, but subject to their own rules; and furthermore, even excluding the confiscation of property, machinery, equipment or tools required for processing, cultivation, harvesting, care, preservation of their product in order not to undermine the judicial control over the company by disrupting its operations.
CAMILLA TALLIA e LARA FORNABAIO
The new decrees regarding mandatory origin labelling in France and Italy: some guidelines [approfondisci]
Il presente lavoro si occupa dell’indicazione obbligatoria di origine, uno dei temi oggetto del più recente dibattito nell’ambito del diritto dell’Unione europea.
L’articolo è suddiviso in due sezioni. La prima fornisce una breve descrizione introduttiva del contesto normativo di riferimento per quel che concerne l’indicazione obbligatoria di origine per i prodotti alimentari. La seconda parte analizza le nuove regole di etichettatura obbligatoria, introdotte in Francia e in Italia, per la carne e il latte e i prodotti lattiero-caseari.
Alla luce di ciò, l’articolo conclude mettendo in evidenza tutte le questioni «irrisolte» e discusse in tema di etichettatura obbligatoria, dai rischi di protezionismo e di incremento dei costi per i produttori fino al rispetto delle esigenze informative dei consumatori.
The present paper is dealing with one of the most debated and recent topic within the Food Law context, the mandatory country of origin labelling.
The paper is structured into two parts. First, it provides a brief description of the European legal framework on mandatory origin labelling for food products. Then, it analyses the new rules introduced in Italy and France (and approved by the European Commission), establishing mandatory origin labelling for meat and dairy products.
In light of this, it gets to the conclusions by highlighting the unresolved matters and doubts in connection thereto, from the risks of protectionism and increased costs for producers to the consumers’ informative needs.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
FRANCESCO DIAMANTI
Stargate. «Latte non tracciato, latte mal conservato» [art. 5, comma, 1, lett. b), legge n. 283/62] [approfondisci]
In materia penale alimentare, l’atteggiamento della giurisprudenza di legittimità ha contribui-to, nel tempo, a trasformare la disposizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283, in una norma del tutto diversa da quella tipica. Partendo da queste iniziative ermeneuti-che, la III Sezione della Corte di cassazione ha di recente affermato che l’utilizzo di una mate-ria prima non tracciata rende il prodotto finale rilevante ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b).
In matters regarding criminal offences of food law, the approach taken by the case-law of the Supreme Court has contributed, over time, to transforming the provision under Art. 5, Paragraph 1, Lett. b), Law of 30 April 1962, n. 283, into a regulation that is quite different from the typical one. Starting from these hermeneutical initiatives, the third Section of the Supreme Court of Cassation recently stated that the use of an untraced raw material makes the final product as being «in a condition of poor state of conservation», pursuant to Art. 5, Paragraph 1, Lett. b).
ANTONIO JANNARELLI
Il «contenimento del consumo del suolo agricolo»: un problema di qualificazione e regolamentazione giuridica [approfondisci]
Nella sentenza 10 novembre 2016, n. 22978 la Corte di cassazione per la prima volta ha preso in esame l’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 228 del 2001 in una vertenza in cui era in discussione la natura agricola di una società cooperativa costituita da imprenditori agricoli avente ad oggetto la macellazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti zootecnici conferiti dai soci.
La Corte ha confermato la soluzione negativa accolta dalla Corte di appello. La nota analizza criticamente la motivazione della sentenza che da un lato ignora il costante indirizzo della giurisprudenza, già emerso a proposito della interpretazione del testo originario dell’art. 2135 e che la riforma legislativa del 2001 aveva definitivamente accolto, dall’altro prospetta una lettura dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 228 del 2001 decisamente errata.
In its judgment of 10 November 2016, No. 22978 the Court of Cassation for the first time examined Article 1 Paragraph 2 of the D.Lgs. No. 228 of 2001 in a dispute where the issue discussed concerned the agricultural nature of a cooperative company formed by farmers concerning the slaughtering, processing and marketing of livestock products supplied by their members.
The Court confirmed the negative result upheld by the Court of Appeal. The note critically analyzes the reasons for the judgment that one side ignores the constant case law approach, already emerged about the interpretation of the original text of Art. 2135 c.c. and that the 2001 law reform had finally welcomed, and on the other side offers a reading of Article 1 Paragraph 2 of the D.Lgs. No. 228 of 2001 definitely wrong.
2016
[approfondisci]Indice fascicolo 3 - 2016
PIETRO MASI
Impresa ittica e attività connesse [approfondisci]
Le imprese che esercitano la pesca non hanno ricevuto menzione diretta nel codice civile del 1942 che disciplinava attività agricole ed attività commerciali, ed all’epoca della emanazione del codice la pesca marittima, rilevante nel sistema economico, era considerata appartenente alla categoria delle attività commerciali in ragione dell’uso della nave e della tradizione della navigazione. Un riconoscimento normativo delle imprese di acquacoltura, nel 1992 qualificate agricole, e l’introduzione di una disciplina specifica dell’imprenditore ittico con norme del 2001 – modificate nel 2004 e nel 2012 – hanno sancito l’assimilazione della pesca all’agricoltura, come del resto avviene nel diritto dell’Unione europea. La ricerca mira a chiarire i termini del rapporto di pesca ed acquacoltura con l’agricoltura, tra momenti comuni e specificità; essa riguarda anche le attività «connesse» a pesca ed acquacoltura – che per legge possono integrarne il ciclo produttivo acquisendone la disciplina invece di rispettare quella coerente con la loro specifica natura (per lo più commerciale) – di pescaturismo, ittiturismo, commercializzazione dei prodotti e valorizzazione dell’ambiente estendendo l’attenzione ad imprese partecipate da giovani, attive con metodo biologico, vincolate a regole precise di rispetto della legalità. La collocazione dell’impresa ittica tra quelle agricole e quelle commerciali ha rilievo importante ai fini della presenza nel mercato; infine la disciplina recente invita ad approfondire le caratteristiche, la specificità ed il ruolo di pesca ed acquacoltura anche sotto il profilo della destinazione agroalimentare e dell’esigenza di rispetto delle regole che conseguono.
Fishing enterprises were not directly mentioned in the Italian Civil Code of 1942, which disciplines agricultural and commercial activities. When it was enacted, sea fishing was relevant in the economic system, but it was considered as belonging to the category of commercial activities because of the use of ships and of the tradition of shipping. Enterprises of aquaculture, legally recognized in 1992 and qualified as agricultural activities, and the introduction of a specific discipline for fishing companies in 2001 – modified in 2004 and 2012 – confirm the assimilation of fishing to agriculture, just like in European Union law. This study aims at defining the terms of the relations between fishing, aquaculture and agriculture, their common grounds and specific identities. It also takes a look at the activities connected to fishing and agriculture, which according to the law integrate the productive cycle, and therefore acquire the discipline instead of respecting the regulations that are coherent with the nature of the activity that is carried out, which mostly is commercial i.e. fishing tourism, commercialization of products and valorization and promotion of the environment. We will also extend our attention to young entrepreneurs who actively work with biological methods and therefore under specific legal regulations. Placing fishing enterprises under agricultural and commercial activities is of great importance in relation to their position in the market place. Concluding, recent discipline invites us to study the characteristics, the specificity and the role of fishing and aquaculture more in detail, and furthermore to consider the destination agro food and the need to respect the rules that follow.
MICHELE TAMPONI
Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali [approfondisci]
L’autore muove dalla recente legge nazionale 28 dicembre 2015, n. 221 che promuove misure di green economy in materia ambientale nonché misure di contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali per sottolineare che di economia verde e di economia sostenibile o ecosostenibile si è parlato molto in questi anni, soprattutto dopo la Conferenza di Rio de Janeiro del 2012 celebrata a vent’anni da quella su ambiente e sviluppo ivi svoltasi nel 1992. L’attenzione si sofferma sui numerosi recenti provvedimenti legislativi nazionali che hanno recepito le istanze emerse in quelle occasioni, nonché su alcune vicende giurisprudenziali che consentono di cogliere luci ed ombre della legislazione e della sua concreta applicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
The author introduces the national law n. 221 (december 2015) that promotes both economic environmental sustainability as well as measures aimed at reducing the excessive exploitation of natural resources, underlining the debate of the recent years around the «green economy». The topic of sustainable development has been discussed in-depth during the Conference which took place in Rio de Janeiro in 2012, twenty years after the Rio Conference on Environment and Development held in 1992. The article focuses on numerous national legislative provisions inspired by the issues raised during these Conferences. It also reflects on a few case laws that reveal the different facets and the limits of the national legislation and of its implementation by the public administrative bodies.
GIUSEPPE AMARELLI
La responsabilità degli enti per i nuovi reati ambientali [approfondisci]
Tra i tanti meriti della legge n. 68/2015, che ha riformato in profondità i reati ambientali, va annoverato quello di aver risolto uno dei principali difetti congeniti della c.d. parte speciale del d.lgs. n. 231/2001, estendendo la responsabilità degli enti anche ai più gravi delitti ambientali introdotti contestualmente negli artt. 452 bis e ss. c.p. Nonostante i buoni propositi, però, la nuova formulazione dell’art. 25 undecies, d.lgs. n. 231/2001 presenta delle lacune e delle imprecisioni di non poco momento che generano problemi applicativi estremamente complessi ed inducono ad auspicare un nuovo intervento correttivo del legislatore.
Environmental crimes system has been thoroughly changed by law 68/2015. One of the most important innovation deals with the introduction of criminal liability for corporations involved in severe environmental crimes enacted by law 68/2015. However, such appreciable innovation is creating thorny issues in courtrooms, so that further legislative innovations are to be demanded.
ALESSANDRO CIOFFI
Paesaggio, ambiente e «beni comuni» nella giurisdizione amministrativa [approfondisci]
Tra paesaggio, ambiente e «beni comuni» vi è un nuovo collegamento e si vede nella tutela dinanzi al giudice amministrativo: precisamente, nell’interesse che fonda la situazione legittimante al ricorso. Usualmente, paesaggio e ambiente sono azionabili in giudizio come interessi diffusi, riferibili a vari soggetti esponenziali. Ma di recente la giurisprudenza riconosce una legittimazione diversa, talora usando la formula «beni comuni»: questa legittimazione è più ampia e assume un interesse che trascende l’interesse individuale e l’interesse diffuso. Appare un interesse comune, una legittimazione oggettiva. Ed è una situazione nuova per la giurisdizione amministrativa, che nel codice del processo amministrativo del 2010 è centrata sul soggetto e sull’azione, cioè sul carattere soggettivo della tutela. Mentre ora va emergendo un interesse diverso. Di qui un interrogativo di fondo: l’interesse al bene comune è davvero il riflesso della celebre formula «beni comuni»? A questo interrogativo sono dedicate le pagine che seguono.
Environment, territories and Landscapes use to be preserved by Administrative Courts. They are usually deemed as interests of someone or belonging to institutional associations or, according to an historical tradition, to be deemed as public property. A new period is now starting, which seems to be innovative, as Administrative Courts are considering Environment, territories and Landscapes as a part of the «Commons». It could be a new evolution, dealing with new social needs arising, focusing on a «Common interest», to be considered as the result of the needs of the whole Community.
STEFANO MASINI
Vizi, difetti e rischi nel consumo di alimenti: profili di responsabilità [approfondisci]
L’evoluzione che accompagna la circolazione dei prodotti alimentari ha l’effetto di porre in evidenza i limiti di adeguatezza della garanzia per vizi della vendita quale rimedio contrattuale da esperire in presenza di imperfezioni materiali ovvero in assenza delle qualità promesse. Dalla disciplina di fonte europea, orientata a tutelare i requisiti di sicurezza degli alimenti sotto il profilo igienico-sanitario, emerge l’attenzione per quelle imperfezioni destinate a rendere incommestibile un alimento perché inadatto al consumo ovvero dannoso per la salute. Occorre, altresì, rilevare i limiti della vendita anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale, prevista esclusivamente in capo al rivenditore finale che abbia agito senza la dovuta diligenza con l’onere, per il consumatore, di provare il nesso di causalità tra la condotta del produttore e l’evento lesivo. L’immissione in consumo di nuovi prodotti frutto delle più moderne tecnologie conferma i limiti del criterio della responsabilità civile, per le conseguenze che possono verificarsi anche dopo molto tempo dalla assunzione dell’alimento. La necessità, espressamente dichiarata, che a circolare siano soltanto alimenti sicuri, induce ad anticipare la tutela del consumatore ad una fase precedente al verificarsi del danno. Il rischio d’impresa conduce, pertanto, alla elaborazione di una responsabilità senza colpa del produttore, per altro, inizialmente limitata a settori diversi da quello alimentare. Il carattere oggettivo della responsabilità risulta, in ogni caso, mitigato dall’adozione, da parte dell’imprenditore, delle misure necessarie a prevenire i danni al consumatore attraverso l’adozione di idonei modelli organizzativi. L’agire dell’imprenditore senza la dovuta diligenza professionale giustifica, infine, che eventuali danni alla salute o alla sicurezza che derivino dal consumo di alimenti, siano sanzionati anche attraverso l’applicazione delle norme di diritto penale quando sia in gioco la tutela dell’incolumità pubblica per offese che si rivolgono ad una pluralità indeterminata di individui. Alcuni profili comuni possono, comunque, individuarsi chiamando in gioco la costruzione di specifiche modalità organizzative e di gestione in chiave precauzionale e non semplicemente riparativa del danno.
The increased movement of foodstuffs has highlighted the limits in terms of adequacy of the warranty against sale defects as a contractual remedy to resort to in the presence of tangible defects or when the promised quality is lacking. The European rules and regulations, oriented to protect food safety requirements from a health and sanitary standpoint, focus on defects that make food inedible and therefore unfit for consumption or hazardous to one’s health. It is also necessary to identify the limits of sale in terms of contractual liability, which lies exclusively with the final vendor who acted without due diligence, resulting in the burden for the consumer to identify the causal link between the conduct of the producer and the prejudicial event. The marketing of new products which are the result of the latest technology confirms the limits of the criterion of liability, given the consequences that can occur even long after food intake. The expressly declared need that only safe food should be marketed is pointing to an anticipation of consumer protection to an earlier stage, before the harm takes place. The business risk leads, therefore, to foresee a no-fault liability of producers, which among other things, is initially limited to sectors other than food. The objective nature of the responsibility is, however, mitigated by the adoption by the entrepreneur of the necessary measures to prevent damage to the consumer through the adoption of appropriate organizational models. The actions of the entrepreneur showing no due professional care justify, finally, that any damage to health or safety arising from the consumption of food, are also sanctioned by the application of criminal law when the protection of public safety is at stake for offenses that involve an indeterminate number of individuals. Some common profiles can, however, be identified by calling into play the development of specific organizational and management solutions as a precautionary measure rather than a merely remedy to the damage suffered.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
ALDO NATALNI
Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in stand-by [approfondisci]
Con la sentenza n. 28354/2016 la Cassazione affronta – per la prima volta dopo ben sette anni dalla sua introduzione ex lege n. 99/2009 – l’esegesi del «nuovo» reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui tratteggia succintamente bene giuridico ed ambito applicativo. Esclusa la ravvisabilità dell’art. 517 quater c.p. in una fattispecie cautelare riqualificata in frode in commercio tentata, i Supremi giudici ne individuano i profili differenziali rispetto alle limitrofe incriminazioni di cui agli artt. 517 e 515 c.p., affermando il concorso con i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. in caso di marchi registrati. Prendendo spunto dalla inedita pronuncia di legittimità, nella nota in commento si analizza genesi e struttura dell’incriminazione-simbolo sulla tutela del made in Italy agroalimentare, cercando di approfondire le ragioni della sua pressoché totale inapplicazione giudiziaria, nonostante le declamate finalità repressive.
With Judgement no. 28354/2016, the Supreme Court addresses – for the first time after seven years since its introduction under law no. 99/2009 – the exegesis of the «new» offense of counterfeiting of geographical indications or denominations of origin of food products, briefly outlining the legal asset and the application field. With the exception of the recognisability of art. 517 quater of the Italian Criminal Code as a precautionary case of attempted commercial fraud, the Supreme judges identify the diverse profiles with respect to the conterminal charges under articles. 517 and 515 of the Criminal Code, confirming the combination with the offenses referred to in articles 473 and 474 of the Criminal Code with respect to registered trademarks. Inspired by the unprecedented ruling on legitimacy, the note expands on the genesis and the structure of the symbolic charge on the protection of agrifood products made in Italy, trying to deepen, even with a view to condendo de jure, the reasons for its almost total non-enforcement at a judicial level, despite the anticipated repressive purposes.
VARIETÀ
MARCÍLIO TOSCANO FRANCA FILHO E MARIA FRANCISCA CARNEIRO
Assaporando il diritto. Per una «epistemogastronomia» giuridica (con presentazione di Alberto Vespaziani) [approfondisci]
Come in un banchetto, questo testo viene servito in quattro portate: dagli aperitivi iniziali al dessert finale. Seguendo il menu viene dimostrata la relazione intima tra il cibo e la cul-tura, in conformità alle connessioni tra lo stesso diritto e la cultura. A partire da questo panorama iniziale che avvicina l’alimentazione al cibo e alla cultura, e conseguentemente al linguaggio, sottoponiamo a scrutinio quali sapori rappresen-tano più adeguatamente il gusto della giuridicità contempora-nea. Dolce? Salato? Crudo? Cotto? Arrosto? La discussione ga-stronomica serve come tema per una riflessione sull’epistemologia del diritto attuale, partendo dalle considera-zioni teoriche di autori come Susan Sontag, Colette Brunsch-wig e Câmara Cascudo. Per concludere, al posto delle bevan-de, al lettore vengono servite le fonti bibliografiche a cui il te-sto si è abbeverato.
Like a banquet, this paper is served in four courses: from the open-ing aperitifs to the concluding dessert. The menu demonstrates the intimate relationship between food and culture, similarly to the re-lations developed between Law itself and culture. From this initial panorama that approaches food and Law to culture and, therefore, to language, we scrutinize which flavors more adequately express what contemporary juridicity tastes like. Sweet? Salty? Raw? Stewed? Roasted? This gastronomical discussion serves as the theme for a reflection on the Epistemology of nowadays Law, based on some theoretical considerations by thinkers like Susan Sontag, Co-lette Brunschwig and Câmara Cascudo. Finally, instead of drinks, the reader is served the bibliographical sources with which this pa-per was fed.
Indice fascicolo 2 - 2016
MASSIMO DONINI
Il Progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari [approfondisci]
Lo studio analizza il Progetto di riforma dei reati agroalimentari e in materia di salute pubblica concluso il 14 ottobre 2015 dalla Commissione Caselli. Si analizzano prima le carenze della disciplina vigente sia codicistica e sia della legge n. 283/1962, per poi illustrare in dettaglio le novità introdotte dal Progetto 2015. Ne emergono una significativa demarcazione del sistema tra sicurezza alimentare (legge speciale) e salute pubblica (codice penale), una rilevante depenalizzazione sul piano dell’art. 5, legge n. 283/1962, anche se lasciata in parte all’interpretazione, e un’innovazione profonda del modello contravvenzionale. Sul piano dei rapporti tra codice e legge speciale viene evidenziata un’accresciuta importanza del ruolo di prevenzione grazie alla disciplina congiunta, penale e amministrativa, che regola la responsabilità delle persone giuridiche per i delitti del codice penale, ma anche grazie a figure delittuose come la produzione e commercio di sostanze nocive per le finalità del commercio all’ingrosso o della grande distribuzione, il disastro sanitario anche per danni a distanza e su vittime indeterminate, l’omesso ritiro di sostanze pericolose e le informazioni commerciali pericolose.
The study analyses the reform Project of the agrifood and public health crimes concluded by the Caselli’s Commission on October 14, 2015, first focusing the lacks of current regulations both in the criminal code and in the law n. 283/1962, then explaining in detail the changes introduced by the Project. The analysis points out a significant demarcation in the criminal system between food safety (supplemental legislation) and public health (Penal Code) as well as a relevant decriminalization of many offences included in the art. 5, law n. 283/1962, even if this results partly by interpretation, and finally a deep innovation of the legal model of the misdemeanors. On the field of relationships between criminal code and supplemental law, the essay highlights the increased importance of prevention thanks to the joint discipline, criminal and administrative, that rules the corporate liability for criminal code offences. The preventive effect of the reform emerges also through criminal offences such as the production and sale of harmful substances for the purposes of wholesale or distribution, as well as public health disaster for long-term damages on unidentified victims, the omission to retreat hazardous food-substances, and harmful food advertising.
SONIA CARMIGNANI
La responsabilità del produttore di organismi geneticamente modificati [approfondisci]
Il tema della responsabilità del produttore di OGM solleva una articolata serie di quesiti che solo prima facie sembrerebbero trovare soluzione nella riconduzione della responsabilità alla responsabilità oggettiva per prodotto difettoso, avendo riguardo al profilo della tutela della salute, e alla responsabilità ambientale, con riferimento sia alla perdita della biodiversità che all’inquinamento genetico. L’intrinseca incertezza, che costituisce il proprium degli organismi geneticamente modificati, sottolinea il ruolo della precauzione quale principio deputato a contrastare il rischio, determinando, però, il superamento del tradizionale meccanismo della responsabilità. In un contesto di norme incentrate sull’obiettivo della sicurezza come imperativo, occorre valutare la tenuta delle regole di responsabilità alla prova delle fattispecie di danno alla salute da OGM e di danni all’ambiente, avendo particolare riguardo al versante sul quale maggiormente il legislatore europeo ha concentrato l’attenzione, dettando regole rigorose in vista della tutela del consumatore di alimenti.
The issue of liability of the producer of GMOs raises a complex set of questions that only prima facie appear to be resolved in the reconciliation of liability to strict liability for defective products, taking into account the profile of health protection, and environmental responsibility, with reference both to loss of biodiversity from genetic pollution. The inherent uncertainty, which is the proprium of genetically modified organisms, emphasizes the role of the precautionary principle as a deputy to counter the risk, determining, however, exceeding the traditional accountability mechanism. In the context of focusing on the objective standards of security as an imperative, necessary to evaluate the tightness of the rules of responsibility to the test of adverse health case by GMOs and damage to the environment, having particular regard to the side on which most European legislators It focused attention, dictating strict rules for the protection of the consumer of foodstuffs.
FABIOLA MASSA
Considerazioni dall’angolo visuale dei diritti di proprietà industriale sulla cisgenesi e sul genome editing applicati agli organismi vegetali [approfondisci]
Il mondo della ricerca in campo vegetale si è arricchito negli ultimi anni di nuove tecniche di miglioramento genetico, alternative ed auspicabilmente più efficaci delle tradizionali tecniche di incrocio e selezione degli organismi vegetali. Tra queste tecniche la cisgenesi ed il genome editing si sono guadagnate l’attenzione persino delle autorità governative, tanto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha deciso di recente di stanziare alcune risorse finanziarie per il loro sviluppo. L’articolo, dopo aver esplorato le diverse tipologie di risultato plausibilmente derivabili dall’applicazione della cisgenesi e del genome editing in ambito vegetale, cerca di fare luce sulle implicazioni che possono derivare dalla protezione giuridica di questi risultati. Una questione in particolare appare predominare nella riflessione condotta nel testo, ovvero il rischio – avvalorato anche dalla pronuncia c.d. «Tomatoes/Broccoli II» del 2015 della Commissione allargata di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti – di una sovrapposizione di diritti di proprietà industriale sullo stesso materiale vegetale, vuoi a titolo di privativa varietale vuoi a titolo di brevetto.
The vegetable field research has been enriched in recent years of new breeding techniques providing alternative and hopefully more efficient techniques than the traditional breeding and selection of plant organisms. Among these techniques the cisgenesis and the genome editing have earned the attention from the government Authorities, so much so that the Italian Ministry of Agriculture, Food and Forestry recently decided to allocate some financial resources for their development. The paper, after exploring the different kinds of results that can derive from the application of cisgenesis and genome editing into the vegetable field, tries to shed light on the implications that may arrive by the legal protection of these results. One issue, in particular, that is predominate in the reflection conducted in the text, in other words the risk – which is also supported by the decision of the EPO’s Enlarged Board of Appeal known as «Tomatoes / Broccoli II» of 2015 – an overlap of IPRs on the same biological material, either by plant variety right or by patent.
LEONARDO MAZZA
Il furto di bestiame [approfondisci]
La sottrazione di capi di bestiame dal gregge o dalle mandrie è stata considerata sin dalla antichità un crimen che rendeva insicuri i pascoli. L’esigenza di una autonoma considerazione dell’abigeato (distinto dal furto) rimane intatta nel trascorrere del tempo, e pertanto sia la legislazione statutaria comunale che poi le codificazioni preunitarie puniscono le condotte aventi lo scopo dell’impossessamento di animali anche di diverse specie, con differenti articolazioni in relazione al luogo del commesso reato, al loro valore economico, al loro numero. Nel codice Zanardelli venne considerato non solo il tipo di animali, ma anche il luogo di perpetrazione del delitto: tale soluzione non fu però sufficiente a contenere l’espandersi della sottrazione di animali, tanto che nel crinale fra Ottocento e Novecento venne varata una legislazione speciale assai severa da valere in alcune zone del territorio nazionale. Una diversa disciplina è stata adottata dal codice penale vigente che nel considerare l’abigeato come circostanza aggravante del furto dà rilievo alla composizione del gregge o della mandria, sia alla specie degli animali sottratti. Le proposte di modifica della figura dell’abigeato, avanzate in epoca repubblicana, testimoniano della sua perdurante attualità, in vista anche della tutela della impresa agricola, dedita all’allevamento, in un contesto sociale in cui sono riemersi nel nuovo millennio i valori della «ruralità».
The act of stealing cattle from a flock or from herds has been considered since ancient times a crime which rendered pastures insecure. The need for an independent consideration of cattle raiding (distinct from theft) remained intact over time, and thus both the local statutory legislation and the pre-unification codifications have sanctioned conducts aimed at the appropriation of animals of different kinds, with different implications with respect to the place where the crime has been perpetrated, the economic value and the number of the animals involved. Zanardelli code considered not only the type of animal, but also the place where the crime was committed: such solution was not sufficient, however, to restrain the rise of animal theft, so that between the nineteenth and the twentieth centuries a very strict special legislation was passed and enforced in some regions of the country. A different body of rules has been adopted by the criminal code that, in considering cattle raiding as an aggravating circumstance of theft, lays stress on the flock or herd composition, as well as on the kind of stolen animals. The proposals to amend the type of offence known as cattle raiding, put forward in the Republican era, bear witness to its enduring relevance, also in view of the protection of the farm dedicated to breeding, in a social context in which the values of «rurality» in the new millennium have been rekindled.
OSSERVATORIO
IL PRECEDENTE
ALDO NATALINI
L’irragionevolezza sanzionatoria del delitto paesaggistico non volumetrico (nota a Corte costituzionale 23 marzo 2016, n. 56) [approfondisci]
La sentenza n. 56/2016, dichiarando la parziale incostituzionalità, per irragionevolezza sanzionatoria, del comma 1 bis dell’art. 181, d.lgs. n. 42/2004, ha delimitato il delitto paesaggistico ai soli in-terventi volumetrici di particolare consistenza. Ne deriva che gli abusi ricadenti su zone vincolate in via provvedimentale ricado-no ormai sotto la più lieve contravvenzione del comma 1, con conseguente riduzione dei termini di prescrizione ed applicabilità delle speciali cause di non punibilità per accertamento postumo della compatibilità paesaggistica o per ravvedimento operoso, istituti finora preclusi. Dopo la ricostruzione della genesi della norma scrutinata, nella nota si analizzano – a prima lettura – i ti-pi criminosi «di risulta» conseguenti all’intervento demolitorio della Consulta, soffermandosi sulle implicazioni di carattere so-stanziale e processuale dello ius superveniens di favore, con parti-colare riferimento all’applicabilità delle cause di estinzione anche sui processi già definiti.
Ruling n. 56/2016, by declaring the partial unconstitutionality, given its unreasonable sanctions, of paragraph 1 bis of art. 181 of Legislative Decree, n. 42/2004, has limited the landscaping crime only to signifi-cant volumetric measures. As a result, the abuse of regulatory restricted areas now fall under the milder provisions of paragraph 1, thereby re-ducing the statute of limitations and applicability of the special causes of non-punishability for posthumous assessment of landscaping compat-ibility or voluntary disclosure, which were not admissible so far. After reviewing the background of the rule considered, the «resulting» types of crimes subsequent to the intervention of the Constitutional Court are therefore preliminary explored, focusing on substantive and proce-dural implications of the ius superveniens, with special reference also to the applicability of discharge causes with respect to already defined proceedings
DE JURE CONDENDO
LAURA COSTANTINO
Proposta di legge contro gli sprechi alimentari: analisi ed inquadramento sistematico [approfondisci]
È di recentissima approvazione da parte dalla Camera il testo unificato del disegno di legge intitolato «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi». Il legislatore italiano ha introdotto una disciplina che, se pure di natura promozionale, si propone di ridurre drasticamente lo spreco alimentare, fenomeno estremamente complesso che abbraccia materie molto diverse quali la tutela dell’ambiente, il contrasto alla povertà, il rilancio del comparto agricolo.
The Chamber of Deputies has recently passed a bill titled «Rules on donation and distribution of food and medicines for the purpose of limitation of waste». The Italian legislator has introduced a promotional law that intends to limit severely food waste, event extremely complex that covers very different matters like the environmental protection, the fight against poverty, the raising of agriculture.
Indice fascicolo 1 - 2016
FABRIZIO DI MARZIO - STEFANO MASINI
Ripresa [approfondisci]
Per dare ragione della pubblicazione di questa nuova Rivista bisogna rifarsi alle considerazioni di commiato ai lettori di Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente che, raccogliendo la risalente elaborazione di vita pratica avviata nel 1954 con la stampa della Giurisprudenza agraria italiana, ha proseguito con significativa continuità e, non ostante le tormentose vicende editoriali, fino al numero (unico) speciale del 2015 – sotto la direzione del prof. Giovanni Galloni – per abbracciare e approfondire temi e visioni che si sono manifestate realmente determinanti in rapporto con le trasformazioni profonde della società.
In quel numero si era, così, anticipato l’impegno editoriale a proseguire la pubblicazione di un periodico stampato a cui affidare il compito più ambizioso di indagare, in profondità, concetti e princìpi e qualificare istituti, che il costituirsi di quella concreta esperienza fattuale continuamente sedimenta e intreccia lungo l’itinerario di progressiva espansione della matrice agroalimentare.
Ecco definito il titolo con cui abbiamo inteso riprendere la pubblicazione della nuova Rivista, nell’intendimento che possa trovare un suo posto ed una sua utile funzione, senza invadere il campo di altre, in quanto ci si propone non solo un naturale e necessario riscontro di questioni che, di volta in volta, si manifestano come quelle in grado di cogliere i segni del tempo – così da fornire un non trascurabile ordine all’incedere dell’esperienza – quanto, sopra tutto, la pressante e meno comune sensibilità a riallacciare la ricerca in un terreno di incontro con altre competenze, operando scelte coraggiose per guardare oltre i sentieri calpestati e definire occasioni di incontro e di colloquio tra giuristi.
La definizione dell’oggetto non è il punto finale di approdo di un programma minimo da ordinare entro limiti e partizioni inevitabili; ma la meta di avvio, lontana dalla gelosia del campanile in vista della ricomposizione dinamica degli apporti così da eliminare quei confini – che un Maestro definiva «giochi d’ombra cagionati dalla limitazione del fascio luminoso proiettato dalla nostra mente» (F. Carnelutti, Metodologia del diritto, Padova, 1939, 32) – che, in passato, ha indebolito non poco il consolidamento della scienza agraristica.
Oggi che, per sorte, ci tocca di occuparci di ricerche intorno ad argomenti che si manifestano come realmente determinanti nella vita delle persone – dalla gestione del territorio, alla cura dell’ambiente; dalla produzione di alimenti, alla fornitura di servizi di interesse generale – si tratta di fronteggiare tutto quanto l’agroalimentare con gli strumenti tecnici apprestati da una ricerca rigorosa e specialistica ma, non di meno, capace di abbattere barriere con l’ampiezza di documentate dimostrazioni dottrinali e la curiosità di metodiche rassegne di giurisprudenza.
Pur senza essere organizzata in parti separate, la Rivista – che ci proponiamo di pubblicare annualmente in tre fascicoli di circa centoottanta fino a duecento pagine ciascuno – intende, dunque, presentare, a seguire della serie di ampie monografie su temi di più vivo ed attuale interesse – senza mai trascurare sintesi non legate ad identificazioni cronologiche di materiali meno affini – altri contributi raccolti in una rubrica denominata Osservatorio.
La consapevolezza è quella di far posto all’annotazione di sentenze; a rassegne di legislazione; a commenti a leggi ed atti sopraggiunti; all’esame comparativo di istituti non che a recensioni a informazioni di interesse sui maggiori problemi.
Per questo la rivista vuole essere aperta a tutti.
PAOLO GROSSI
Fattualità di un diritto pos-moderno: l’emersione di un diritto ‘agrario’ in Italia [approfondisci]
Il diritto agrario ha ereditato la propria vivacità da quel Novecento giuridico che possiamo definire pos-moderno per sottolineare l’avvio di un nuovo periodo di transizione che presenta aspetti di profonda innovazione rispetto alla stabilità di istituti giuridici che, pur espressione della modernità, appartengono ad un percorso storico definito nel quale poco è stato esplorato il carattere complesso di una società plurale che muta e si evolve nel tempo. Indagando il carattere storico del diritto, i giuristi hanno individuato una realtà agraria variegata e multiforme, non limitata al possedere ma orientata al valorizzare il bene terra. La proprietà privata, nella sua dimensione statica, si converte in impresa economica, nella sua funzione organizzativa e produttiva. Di questa evoluzione pos-moderna sono testimoni i gius-agraristi del Novecento che hanno saputo interpretare con fantasia e concretezza le esigenze provenienti dal mondo rurale, ponendo nuove e stimolanti sfide. L’aderenza ai fatti e lo sviluppo di nuove conoscenze hanno permesso, infine, di scoprire sfumature finora inedite del diritto agrario, identificando il valore della terra non soltanto nella res frugifera in sé ma nella sua capacità di produrre ambiente tutelando la bellezza dei paesaggi e la salubrità dei territori a garanzia delle produzioni agroalimentari, frutto del carattere distintivo di luoghi e persone che esprimono, attraverso i fatti interpretati dal diritto, la loro identità.
Agricultural law owes its liveliness to the Twentieth Century that we can define as pos-modern from a legal standpoint to highlight the start of a new period of transition which was considerably innovative with respect to the stability of legal institutions since, although an expression of modernity, they belonged to a clear historical path whose plural society – that changes and evolves over time – had been poorly explored. By investigating the historical character of the law, the jurists have identified a diverse and multifaceted agricultural reality, which is however not limited to the ownership of land but to its enhancement. Private property, in its static dimension, is turned into a business, given its organizational and productive function. Agricultural law experts witnessed this pos-modern evolution of the twentieth century, for they have been able to interpret the needs of the rural areas with imagination and pragmatism, posing new and exciting challenges. Sticking to the facts and the acquisition of new knowledge has allowed, finally, to discover some fresh shades of the agricultural law, identifying the value of the land not only as res frugifera per se but in its ability to produce environment by preserving the beauty of the landscapes and the healthiness of the territories to guarantee agri-food production, the result of the distinctive character of places and people that express their identity through the facts interpreted by the law.
IRENE CANFORA
Alimenti, nuovi alimenti e alimenti tradizionali nel mercato dell’UE, dopo il reg. 2015/2283 [approfondisci]
Il regolamento 2015/2238 aggiorna la disciplina per l’immissione sul mercato dei «nuovi alimenti» sostituendo, a partire dal 2018, il regolamento 258/97. Nell’articolo si discute di come la definizione di novel food permette di individuare una gradazione nelle regole applicabili alle diverse tipologie di alimenti: accanto ad una puntuale elen-cazione dei prodotti che richiedono l’autorizzazione ai fini dell’immissione in com-mercio come novel food, il regolamento introduce una disciplina semplificata per i pro-dotti tradizionali provenienti da Stati extra UE, riconducibili alla produzione prima-ria. Inoltre, si individua come tipologia a sé stante quella degli alimenti derivanti da animali clonati, anche in considerazione della concreta possibilità di una autorizza-zione come nuovi alimenti, alla luce dell’attuale evoluzione della legislazione europea. Partendo dalla definizione di nuovi alimenti, l’articolo analizza quindi la relazione tra alimenti e produzione agricola. Infine si evidenziano gli effetti del regolamento sulla regolamentazione dei mercati agroalimentari, con riguardo alla posizione delle impre-se interessate a presentare domanda per l’immissione sul mercato di nuovi alimenti.
The Regulation 2015/2283, applying starting from January 2018, revises the European legisla-tion on novel food, based on a pre-marketing authorization procedure. The Regulation specifies the definition of novel food. This article outlines that the category of «novel food» should be shared in 3 different typologies of goods, each of them with own regulation: a wider definition, including both food developed using novel technologies and products of natural origin, not usually marketed as food; within them, special rules laid down for traditional food products imported form Third Coun-tries; furthermore food from animal clones. As pointed out in the article, a request of authorization for food from animal clones, temporary regulated by reg. 2015/2283, should be rejected, consider-ing the contents of drafts already adopted by EU on this matter, as well as the relevance of general principles recognized by the Treaties in the application of the rules of Regulation. Furthermore, it is considered the relevance of agriculture for a legal definition of food, moving from the consideration that agricultural production is a preferred condition for the admission to products within the category of novel food. Finally, the Author discusses the impact on the market of the Regulation 2015/2283. The simplification of the authorization procedure, as well as the expressed provision of protection rules for information requested to the applicants, shows that the main goal of the new Regulation is to implement the access to the internal market of products as novel food, promoting activities of large-size businesses processing or importing food in the EU market.
CRISTIANO CUPELLI
La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi [approfondisci]
Nei lavori della Commissione per la riforma dei reati in materia agroalimentare, che si sono appena conclusi e tradotti in uno Schema di disegno di legge, un ruolo cruciale ha rivestito l’esigenza di ammodernamento dell’intervento penale nella mate-ria agroalimentare, la cui realizzazione è stata perseguita, fra l’altro, attraverso l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti, la creazione di un’apposita tipologia di delega di fun-zioni e la previsione di peculiari ipotesi di non punibilità soprav-venuta, incentrate su condotte post-fatto a contenuto riparatorio. Da una prima analisi, l’articolato sembra delineare un sistema ri-spettoso delle garanzie, moderno sul piano delle scelte di politica criminale e rispetto a talune soluzioni di tecnica legislativa.
In the works of the Commission for the reform of the offenses in agri-business matters, which have just been completed and resulted into a bill, a crucial role was played by the need to modernize criminal action in agri-food matters, whose implementation has been pursued, among other things, through the extension of the administrative liability, the creation of a special delegation of tasks and the provision of specific cases of privilege focused on post-remedial conducts. The articles seem to outline a system respecting the guarantees, which appear to be mod-ern in terms of criminal policy choices and compliance with certain technical legislative solutions.
ANTONIO JANNARELLI
L’eccezionalismo agricolo e la catena alimentare nel futuro della PAC [approfondisci]
Il saggio analizza il tema dell’eccezionalismo agricolo alla luce della significativa differenza di poteri presente nella catena alimentare con riferimento sia alla esperienza nord-americana sia a quella europea. Storicamente gli Stati Uniti hanno dato rilievo al rapporto tra la farm policy e il farm trade nettamente distinte dalla food policy. Viceversa, in Europa il legato dell’economia premoderna ha portato a preservare il legame tra la farm policy e la food policy come emerge dagli obiettivi della PAC di cui all’art. 39 del TFUE. Di conseguenza, l’ampia nozione di agricoltura qui accolta è ambigua nella misura in cui comprende sia gli agricoltori in senso stretto sia gli altri operatori della catena agro-alimentare. Nell’attuale crisi globale dell’economia, negli Stati Uniti la protezione degli agricoltori è affidata sia al rafforzamento del potere negoziale delle organizzazioni dei produttori agricoli anche sul piano della disciplina della concorrenza, sia all’introduzione di specifiche discipline privatistiche relative ai contratti di fornitura presenti nella catena alimentare. Viceversa, l’Europa continua di fatto a guardare con sospetto all’aumento del potere negoziale delle organizzazioni dei produttori agricoli in quanto teme che possa essere pregiudicata l’unità del mercato unico interno, per cui preferisce affidare la tutela dei farmers alle autorità antitrust sulla base solo di sanzioni amministrative e del rispetto della disciplina generale antitrust con il rischio così di sacrificare del tutto la politica agricola.
The paper analyzes the issue of agricultural exceptionalism in the light of the serious power imbalances that emerge in economic relations in the food chain in the experience of United States and the European Union. The United States has historically given a strong link between the Farm policy and Trade policy clearly distinct from the Food policy. In contrast, in Europe the legacy pre-modern economy has led to the preservation of the link between Farm policy and Food policy as is clear from Article 39 TFEU. Consequently, the very notion of agriculture is ambiguous in that it embraces both the farmers and the other economic operators in the food chain. In the presence of the current global economic situation, in the US the protection of farmers in the agro-food chain is entrusted on strengthening the bargaining power of farmers’organizations also in competition law and on the introduction of statute law on production contracts. The European Union looks suspiciously strengthening the bargaining power of farmers' organizations for fear that the unity of the internal market may be prejudiced, therefore prefers to entrust the defense of farmers in the food chain to antitrust authorities only on the basis of administrative sanctions and the respect of the general competition rules at the risk of totally sacrificing agricultural policy.
FRANCESCO MACARIO
Crisi e insolvenza dell’impresa agricola. Spunti di riflessione da un recente contributo [approfondisci]
L’insolvenza dell’imprenditore agricolo è da tempo oggetto di dibattito tra gli studiosi, tanto del diritto commerciale, quanto del diritto agrario. Un recente contributo monografico riporta in evidenza il tema, attraverso una sapiente analisi comparativa con altre esperienze giuridiche, come quella francese (che si caratterizza per la recente riforma attuata mediante la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté), quella nord-americana (affidata alle norme in tema di Adjustment of the Debts of a Family Farmer With regular Annual Income, contenute nel Chapter 12 del Bankruptcy Code) e infine canadese (a partire dal risalente Farmers Creditors Arrangement Act). Da tutte queste diverse normative è possibile (e auspicabile) che vengano tratti spunti dal nostro legislatore per una riconsiderazione del problema relativo alla disciplina applicabile alla crisi e all’insolvenza dell’impresa agricola, nella cornice delle procedure concorsuali, rispettando le specificità di tale attività economica.
The treatment of the farmer’s insolvency has been a disputed matter for a long time among scholars of both commercial and agricultural law areas. A recently published book gives the opportunity to focus the attention on this subject again, thanks to the precise comparative analysis with other legal experiences: in particular, the French (with the recent reform made through the loi de sauvegarde des entreprises en difficulté), the North-american (through the rules and procedures contained in the Chapter 12 of the Bakruptcy Code, under the sect. Adjustment of the Debts of a Family Farmer With regular Annual Income) and finally the Canadian (starting from the old Farmers Creditors Arrangement Act). All these different laws and regulations could surely be helpful to our legislator, in order to reconsider the legal approach to farmers’ insolvency within the new insolvency procedures framework.
PIETRO MASI
Agricoltura, alimenti e ricerca spaziale [approfondisci]
Lo sviluppo e l’aumento della durata delle esplorazioni nello spazio sono accompagnati dalla notizia di esperimenti di «coltivazioni», che evocano l’agricoltura, mentre sono oggetto della ricerca spaziale alimenti, negli obiettivi anche «freschi», adeguati al consumo degli astronauti. Le interazioni della dimensione spaziale con la tradizione e le regole di agricoltura ed alimenti, mostrano che esigenze di sicurezza, qualità, informazione permangono ma subiscono condizionamenti, mentre la tecnologia e la sperimentazione assumono un ruolo importante anche in vista di un trasferimento delle conoscenze acquisite sulla terra. La prospettiva di una agricoltura senza terreno e di alimenti «progettati» per soddisfare esigenze fondamentali, già di sopravvivenza, dei fruitori, ad esempio con sacrificio della biodiversità, potrebbe incidere su modelli produttivi e stili di vita terrestri, auspicabilmente affiancandosi ad essi senza sopprimere manifestazioni di godimento della realtà rurale, varia anche per ambiente e paesaggio, presenti nella storia della stirpe umana.
The evolution in space exploration has brought about news on experiments on «cultivation of crops» that evoke earth farming, and identifying «fresh» produce suitable for astronauts during their journeys is also under investigation in space research. The interaction between the dimension of outer space and the traditions, rules and regulations of food and agriculture on Earth, show that the need for security, quality and information persists, but that it is influenced by space research, while technologies and testing assume an important role in the prospect of transferring knowledge acquired on earth. The perspective of an agriculture without soil and with foodstuff designed and conceived to satisfy fundamental needs, that is the survival of its consumers, sacrificing for example biodiversity may have effects on both productive models and lifestyles. The hope is that space agriculture shall accompany earth farming side by side without abolishing the diversity of rural areas with the variety of environments and landscapes that have always existed in the history of the human race.
STEFANO MASINI
Alla ricerca dei princìpi del diritto alimentare [approfondisci]
All’iniziale diffusione di regole implicite e non codificate in vista della produzione e dello scambio di alimenti segue un progressivo consolidamento di un sistema in sé ordinato e norme in grado di proporre l’affermazione di princìpi generali, siano essi espressamente richiamati da fonti positive ovvero di fatto osservati. All’attività dell’interprete resta, per tanto, ritagliato il compito di verificare la corrispondenza della singola norma al programma di sviluppo della materia lungo le coordinate tracciate dai suddetti princìpi. Si possono inventariare diverse categorie: a partire dai princìpi che presentano una previa intelaiatura sistematica all’interno del regolamento n. 178 del 2002 fino a comprenderne altri chiamati a sorreggere dall’esterno la ragionevole sistematicità della materia, tenendo conto dei più importanti mutamenti che intervengono nel contesto economico e sociale.
The initial spread of implicit and non-codified rules regarding the production and exchange of food follows along the lines of a progressive consolidation of an ordered system and standards laying out some general principles, whether expressly referred to as positive sources or observed de facto. Therefore, those who have to interpret said rules must verify the correspondence of individual provisions with the development program of the matter along the coordinates set out by the above principles. Several categories can be taken stock of: starting from the principles that originate from the Regulation no. 178 of 2002 to include others supporting the reasonable systematic nature of the matter, taking into account the major changes occurring in the economic and social context.
LORENZA PAOLONI
Biodiversità e risorse genetiche nella legge nazionale di tutela e valorizzazione [approfondisci]
La legge 1° dicembre 2015, n. 194, per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, giunge, con un discreto ritardo, a tentare di colmare il gap creatosi tra una serie feconda di accordi internazionali intervenuti, a vario titolo, a disciplinare il delicato tema della salvaguardia della diversità biologica ed agricola ed una altrettanto fertile stagione di leggi regionali mirate a tutelare, con approcci diversi, il grande patrimonio genetico dei nostri territori. L’obiettivo fondamentale della legge è la realizzazione un impianto istituzionale, organizzato su livelli e competenze diverse, per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare che miri alla tutela delle risorse genetiche locali, rilevanti dal punto di vista agricolo ed alimentare, dal rischio di estinzione ed erosione genetica. L’articolo, dopo aver percorso gli itinerari legislativi nazionali ed internazionali in materia di agro biodiversità e risorse genetiche, svolge una prima analisi critica sulle luci ed ombre della neonata legge di settore.
The act 194, passed of the 1st of December 2015, on safety and conservation of agricultural and food biodiversity, attempts to fill a gap between a set of prolific international agreements – aimed, in different ways, at regulating the delicate topic of the safety of biological and agricultural diversity – and a likewise productive season of regional acts, focused on the protection of our territory’s remarkable genetic heritage. This legislation’s main objective is to achieve an international framework, arranged through different levels and competences, for the safety and conservation of agricultural and food biodiversity, able to safeguard local genetic resources – both agricultural and food – from the risk of genetic erosion and extinction. The current article is an attempt, through an overview of different national and international legislations within the spectrum of agro biodiversity and genetic resources, to carry out a preliminary critique on strengths and weaknesses of this new-born sectorial legislation.
LUIGI RUSSO
Le sanzioni amministrative conseguenti all’applicazione delle regole di condizionalità: sanzioni punitive o strumentario interno alla PAC? [approfondisci]
Il lavoro si propone di verificare se l’utilizzo, da parte del reg. UE n. 1306/2013, dell’espressione «sanzione amministrativa», con riferimento alle conseguenze dell’applicazione della disciplina in tema di condizionalità (la quale prevede la riduzione o, nei casi più gravi, la perdita del diritto all’aiuto da parte del beneficiario in caso di inadempimento agli impegni di condizionalità) costituisca un consapevole richiamo al concetto di sanzione di natura punitiva, o rappresenti, più semplicemente, un utilizzo atecnico dell’espressione in oggetto, atteso che in forza della disciplina previgente non si dubitava dell’inquadramento dell’istituto della condizionalità quale meccanismo amministrativo specifico interno alla PAC, privo di intenti afflittivo-punitivi.
This paper aims to determine whether the words «administrative penalty» used in the EU Reg. no. 1306/2013, with reference to the application of the rules regarding cross-compliance (which provides for the beneficiary’s reduction or, in severe cases, loss of entitlement to the aid in case of failure to fulfill cross-compliance obligations) are explicitly referring to punitive sanctions, or rather represent a common use of the words, since under the previous legislation, «cross-compliance» was clearly designed to be an internal administrative mechanism specific to the CAP with no punitive intents.