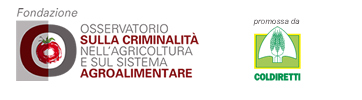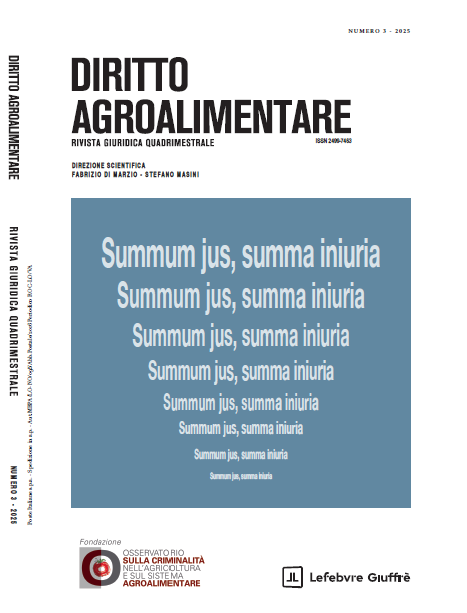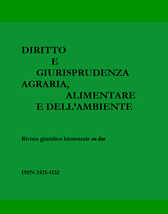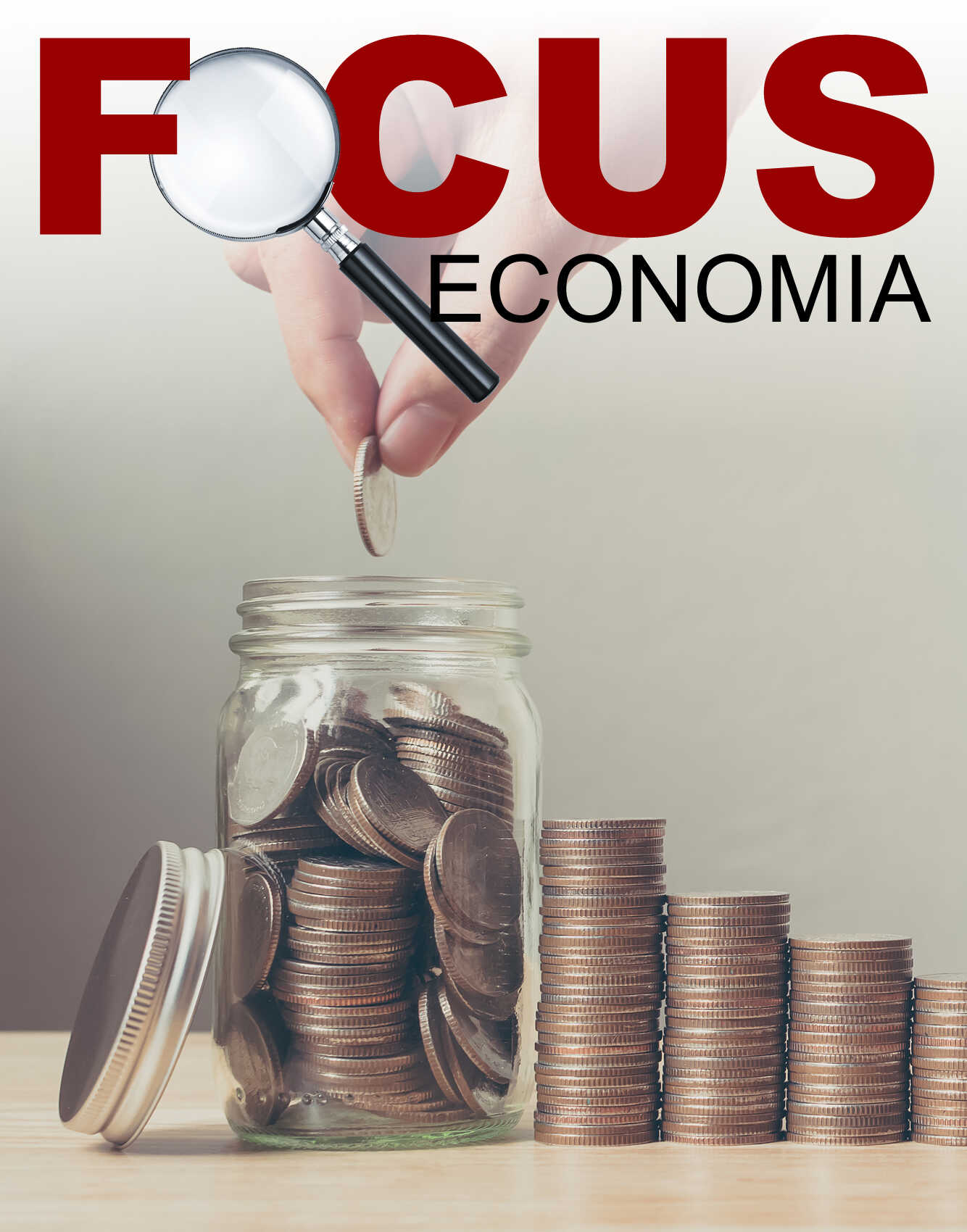Il difficile rapporto tra nuovo diritto penale e antiche tradizioni rurali: la combustione di residui vegetali.
1. La normativa comunitaria e nazionale sui rifiuti trova alle volte non poche difficoltà di applicazione in alcune aree geografiche e in determinati settori di attività per l’utilizzo che in tali aree e in tali settori si fa (perché s’è sempre fatto) di beni che quella normativa ritiene, quantomeno prima facie, dei rifiuti.
Uno di questi settori è senza dubbio quello agricolo, dove spesso si assiste a controversie legate, appunto, ad un utilizzo degli «scarti» che potrebbe essere, in certo senso, produttivo per il settore stesso ma che, invece, la normativa sui rifiuti individua, più o meno correttamente, come utilizzo – recte, riutilizzo – di rifiuti, con tutto quel che ne consegue (in termini di autorizzazioni, smaltimento, recupero, etc.).
Un caso emblematico è rappresentato dal c.d. «pastazzo» di agrumi, vale a dire un particolare «sottoprodotto» (in senso prima di tutto tecnico) dell’industria agrumaria, che si ottiene con gli scarti (principalmente, le bucce) di tali frutti e che in agricoltura è sempre stato adoperato come ammendante vegetale, mentre in zootecnia veniva utilizzato nelle miscele di concentrati per l’alimentazione animale (per es. dei bovini). Il «pastazzo» è stato, dal punto di vista giuridico, protagonista di una interessante vicenda nata proprio dallo scontro tra le antiche e consolidate abitudini della vita di campagna, da una parte, e le nuove norme penali riferite allo smaltimento e/o al recupero abusivo di rifiuti, dall’altra parte. A tale vicenda, intanto, ci si riferisce al passato, perché il legislatore ha fatto definitiva chiarezza sulla natura e sulla pericolosità di tale sostanza, mettendo finalmente pace tra le «pratiche» (inteso come usi) contadine e le «pratiche» (inteso come fascicoli) giudiziarie: lo scorso anno, infatti, è stato emanato il noto «decreto del fare», il d.l. n. 69/2013, poi convertito in legge (con legge n. 98/2013, pubblicata in G.U. n. 184 del 20 agosto 2013) che, nel dichiarato intento di rilanciare l’economia nazionale, si era occupato di diversi aspetti che coinvolgono tale accezione [tra cui, per attenerci al settore ambientale, la disciplina delle terre e rocce da scavo, che ha visto comparire, con l’art. 41 bis del d.l. citato (alla cui lettura, congiunta a quella del precedente art. 41, si rimanda per non dilungarci troppo) le regole di gestione c.d. semplificata, per gli impianti di piccole dimensioni e per quelli relativi alla realizzazione di progetti di opere e/o interventi non soggetti da AIA e/o VIA, che, quindi, oggi vigono al fianco di quelle ordinarie, previste dall’apposito d.m. n. 161/2012]. Ebbene, questo stesso testo di legge contiene un’altra norma, di interesse in questa sede: il riferimento corre all’art. art. 41 quater, che ha introdotto la «disciplina dell’utilizzo del pastazzo», norma posta (in un certo senso, significativamente) dopo l’art. 41 ter, dedicato, invece, ad introdurre alcune modifiche normative in alcuni casi «ad inquinamento scarsamente significativo». Stando alla riferita normativa, il pastazzo è sicuramente uno scarto e quindi, per certi versi, un potenziale rifiuto; nondimeno, è uno scarto dalle proprietà tali per cui se ne è sempre fatto uso nel settore agricolo, con ciò escludendo ogni intenzione di disfacimento da parte del produttore – e, così, facendo venir meno il requisito soggettivo sottostante all’identificazione dei rifiuti.
leggi o scarica l’articolo completo
Paolo Costantino (*)
(*) Legale d’impresa.