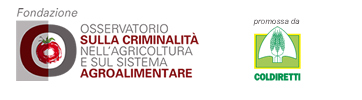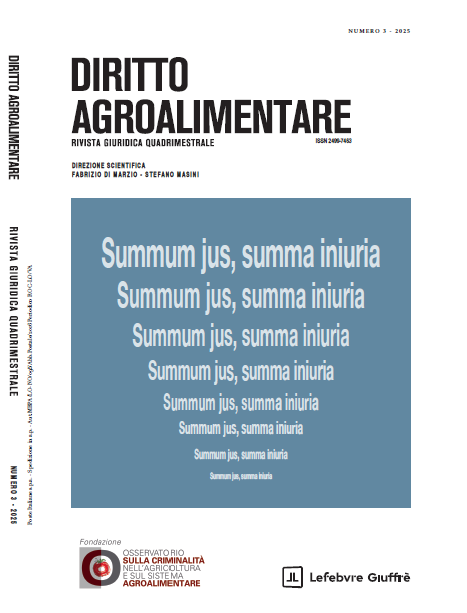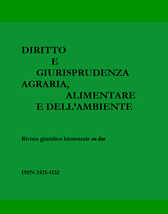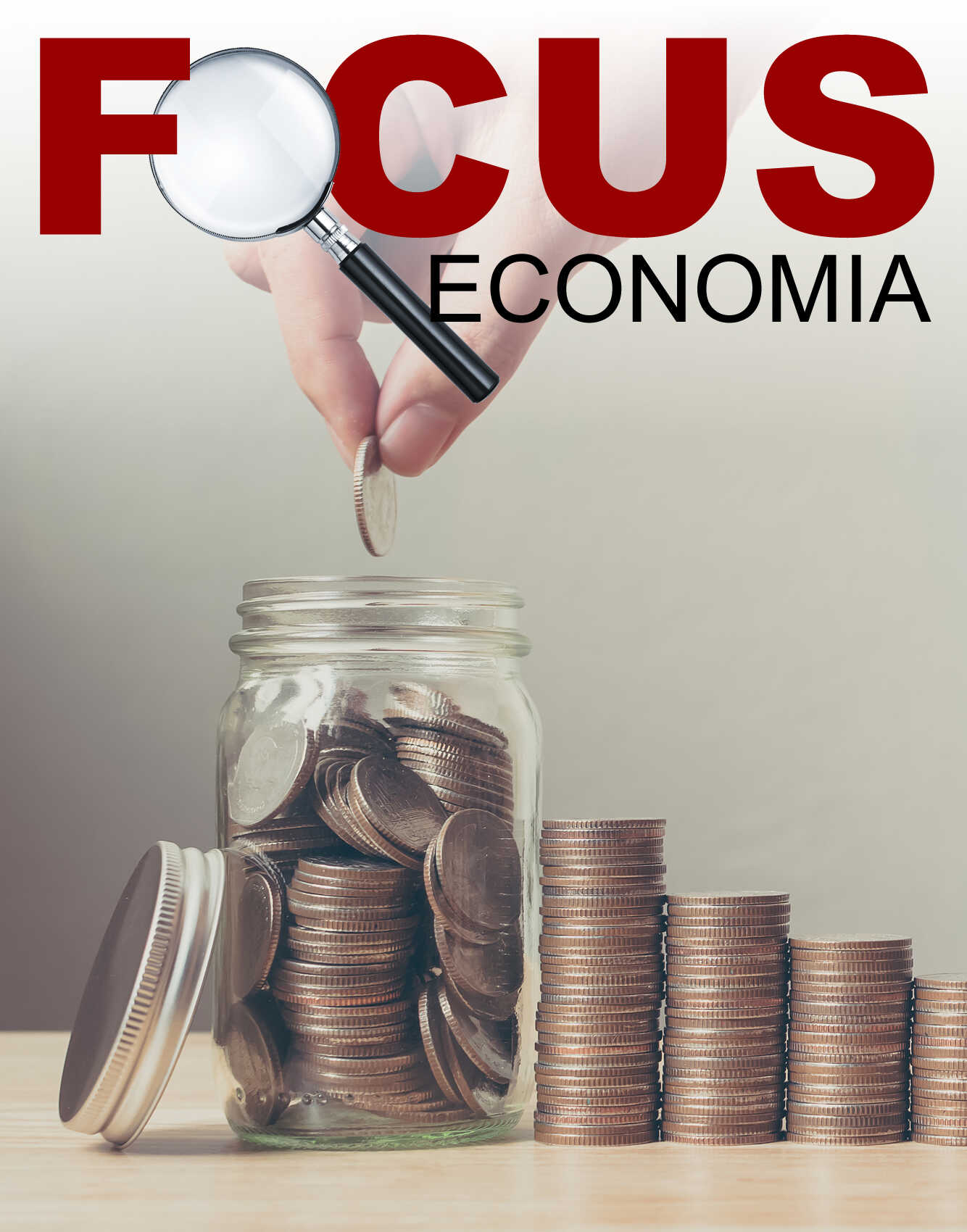La Bussola dell’Economia Italiana
LEGGI il documento completo
a cura di Elisa Coletti, Paolo Mameli, Carlo Ruoti e Andrea Volpi
ABSTRACT
L’evoluzione dello scenario congiunturale
Il tema dell’invecchiamento della popolazione sarà di importanza crescente nei prossimi decenni: esso peserà sia sul PIL potenziale che sulla spesa pubblica relativa alla previdenza, alla sanità e all’assistenza di lungo termine in tutti i Paesi UE, probabilmente anche in misura maggiore rispetto alle proiezioni di base contenute nell’Ageing Report 2024 della Commissione.
L’Italia è, tra i Paesi occidentali, quello dove il problema si è manifestato più precocemente, ma ha dalla sua la sostenibilità di lungo temine del sistema pensionistico.
Le proiezioni demografiche utilizzate dalla Commissione Europea mostrano un calo della popolazione UE pari a oltre 17 milioni di abitanti entro il 2070 (da 449 milioni nel 2022 a meno di 432 milioni nel 2070.
L’Italia è, tra i Paesi occidentali, quello dove il problema dell’invecchiamento si è manifestato più precocemente, ma il tema diverrà di importanza crescente anche per gli altri Paesi dell’Eurozona.
La diminuzione attesa della popolazione italiana è da ricondurre principalmente al calo del tasso di fertilità (numero di nascite per donna).
Come emerge dai dati Istat, dopo un picco nel 2008 pari a 1,43, l’indice è calato costantemente negli anni successivi (1,24 nel 2023, è tra i più bassi fra i Paesi UE), ben lontano dal tasso di sostituzione naturale (2,1).
La popolazione italiana, oltre che più ristretta, diventa sempre più anziana a seguito dell’invecchiamento delle generazioni del baby boom, ovvero di coloro che sono nati tra il 1946 e 1964.
Ciò implica evidentemente un progressivo spostamento di individui dalla popolazione in età lavorativa a quella in età da pensione.
L’indice di dipendenza degli anziani è visto in salita in tutti i Paesi UE.
In Italia tale indicatore sale dal 40,8% del 2022 al 65,5% del 2070.
Tale dinamica fa emergere uno squilibrio crescente tra pensionati e lavoratori, determinando un impatto potenzialmente oneroso (a parità di legislazione) sulle voci di spesa pubblica correlate.
In Italia, le forze di lavoro sono attese diminuire del 14% nel 2070 rispetto al 2022 (-3,5 milioni di individui), a causa dell’ampio calo della popolazione in età lavorativa, compensato solo parzialmente da un aumento del tasso di partecipazione, dal 60,3% del 2022 al 67,4% nel 2070.
L’aumento del tasso di partecipazione sarà accompagnato da un incremento del tasso di occupazione (+6,5% per la fascia d’età 20-64 anni, +7,8% fino a 74 anni).
Tuttavia, la diminuzione della popolazione in età lavorativa farà sì che, nonostante l’evoluzione favorevole della partecipazione e del tasso di occupazione, le ore lavorate totali si contraggano a partire dal 2030 (di -0,15% all’anno in media nel periodo 2030-2070).
L’impatto sul PIL potenziale del trend demografico sfavorevole sarà negativo.
Nel breve periodo (su un orizzonte a 10 anni) prevale il freno derivante dal minor input di lavoro (che fa calare il PIL potenziale dai valori correnti, vicini all’1%, sino a un minimo di 0,5% nel 2031-33); nel lungo termine, nelle ipotesi della Commissione, prevale l’effetto di crescita della produttività e del capital deepening, che fa risalire il PIL potenziale sino a una media di 1,4% nel periodo 2040-2060 (successivamente, il PIL torna a rallentare, sino a raggiungere l’1,1% nel 2070).
Nel complesso, per la media di tutto il periodo preso in considerazione (2022-2070), se la produttività del lavoro fosse in linea con quella registrata nel periodo 2000-2022 (0,25%), il tasso di crescita medio annuo del PIL sarebbe pari a 0,2% nel 2022-2070 anziché 1,1% come da stime della Commissione.
Nell’Ageing Report, la Commissione Europea analizza poi gli effetti degli scenari demografici sul bilancio pubblico.
In base alle attuali proiezioni demografiche, a parità di legislazione, la spesa pensionistica in rapporto al PIL in Italia, già la più alta nel confronto con tutti gli altri Paesi UE, seguirà una traiettoria crescente nel prossimo decennio, fino a raggiungere un picco del 17,3% nel 2036; in seguito, la spesa è attesa tornare a calare gradualmente, fino a raggiungere il 13,7% nel 2060 e stabilizzarsi su quei livelli negli anni successivi.
Da notare che le riforme effettuate a più riprese negli ultimi decenni hanno reso il sistema previdenziale in Italia più sostenibile di quello di altri Paesi.
Infine, l’invecchiamento della popolazione ha effetti non solo sulla spesa previdenziale ma anche sugli altri capitoli di spesa pubblica legata all’età ovvero:
– Spesa sanitaria. In Italia, secondo lo scenario di base della Commissione, la spesa pubblica per la salute, che si è attestata al 6,3% del PIL nel 2022, è attesa calare al 5,8% quest’anno.
In questo contesto, l’invecchiamento della popolazione causerà un graduale aumento a partire dal 2029, sino a un picco al 6,5% di PIL nel 2048-2061.
Il rischio è che la percentuale di spesa sanitaria a carico dei privati (già in Italia sensibilmente più alta che negli altri grandi Paesi UE) sia destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni.
– Spesa per Long-Term Care. In Italia, come in molti Paesi UE, la domanda legata a questa tipologia di servizi eccede già l’offerta. La spesa pubblica per LTC è attesa salire dall’attuale livello pari all’1,6% del PIL sino a un picco di 2,2% nel 2052-2068.
– Spesa per istruzione. Si tratta dell’unico capitolo di spesa che potrà giovarsi dei trend demografici, diminuendo da 3,8% di PIL nel 2022-23 sino a 3,1% già entro il 2040 (e al 3% nel 2070): infatti, il numero di studenti è atteso ridursi di un quarto alla fine del periodo considerato.
Nel complesso, nello scenario base della Commissione, in Italia il trend demografico è atteso causare una diminuzione della spesa pubblica legata all’età nel periodo 2022-2070 pari a -2 punti percentuali.
Tra i grandi Paesi UE, quello che vedrà crescere maggiormente la spesa pubblica per effetto dell’invecchiamento della popolazione, sull’orizzonte al 2070, è la Spagna, seguita dalla Germania.
Tendenze del settore bancario
Nel 2° trimestre i prestiti hanno visto un calo lievemente più contenuto rispetto ai primi tre mesi dell’anno.
A maggio l’aggregato dei prestiti a famiglie e imprese ha segnato un calo del -2,1% seguito dal -1,7% stimato da ABI per giugno, a confronto con il -2,6% dei primi tre mesi dell’anno.
In dettaglio, i prestiti a società non-finanziarie hanno riportato una flessione del -3,1%, meno intensa rispetto al -3,9% del 1° trimestre.
Per i prestiti alle famiglie, la lenta riduzione dello stock è risultata anch’essa in lieve miglioramento dal -1,4% di marzo al -1,0% di maggio.
In particolare, lo stock di mutui è rimasto in stallo.
In questo quadro, i flussi di nuovi prestiti per acquisto abitazioni hanno confermato il ritorno alla crescita, sebbene a un ritmo modesto, del +1,4% a maggio, il secondo dato positivo dopo il +4,5% di aprile, che faceva seguito a una serie di cali da settembre 2022.
All’opposto, è proseguita la riduzione delle rinegoziazioni.
Le erogazioni sono rimaste in massima percentuale a tasso fisso, pari al 90% del totale operazioni.
Si rafforza il miglioramento della dinamica dei depositi che a maggio hanno segnato una variazione nulla e, secondo dati preliminari, a giugno sono tornati in crescita.
L’andamento di maggio ha tratto vigore dai depositi delle società non-finanziarie che hanno segnato un aumento del 5,3% nel mese, mentre i depositi delle famiglie hanno registrato una minor flessione rispetto a inizio anno, ma in linea con i due mesi precedenti, del -2%.
Prosegue anche la forte dinamica delle obbligazioni, che a maggio hanno riportato una crescita dello stock del 18,4%, seguita dal +14,9% a giugno secondo le stime ABI.
È quindi proseguito l’aumento della raccolta totale da clientela, con il +1,4% di maggio e il +3% a giugno secondo le anticipazioni ABI.
Indice dei contenuti
• L’inverno demografico allunga la sua ombra su PIL e spesa pubblica (p. 2 )
• Sintesi della previsione macroeconomica (p.13 )
• L’industria continua a frenare la crescita (p. 14 )
• Le indagini manifatturiere non mostrano ancora segnali di ripartenza (p. 15 )
• La produzione nelle costruzioni registra un’inattesa tenuta nei mesi primaverili (p. 16 )
• I servizi restano pressoché l’unico motore di crescita (p. 17 )
• La ripresa del potere d’acquisto sosterrà i consumi nei prossimi trimestri (p. 18 )
• Il mercato del lavoro rimane solido (p. 19 )
• Battuta d’arresto per l’export a maggio (p. 20 )
• L’inflazione resta ben inferiore alla media dell’Eurozona (p. 21 )
• Si conferma una modesta ripresa dei nuovi mutui alle famiglie (p. 22 )
• Prosegue la crescita dei depositi delle imprese (p. 25 )